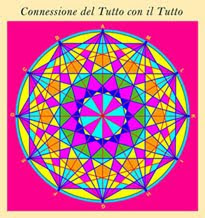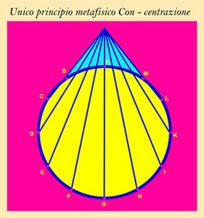- RAIMONDO di SANGRO:GRAN MAESTRO DELLA MASSONERIA NAPOLETANA
 A bordo della sua carrozza,entra o esce dal suo palazzo nel centro di Napoli il Principe di Sansevero, «Signore di corta statura, di gran capo, di bello e gioviale aspetto, filosofo di spirito, molto dedito nelle meccaniche, di amabilissimo e dolcissimo costume, studioso e ritirato, amante la conversazione di uomini di lettere», come lo descrive l’illuminista Antonio Genovesi. Entra in scena e subito la domina: i vicoli si animano,mille occhi curiosi furtivamente scrutano dalle finestre,da dietro i carretti,dai crocchi,dalla chiesa e dall’osteria. Tutta la massa del popolo che si assiepa intorno al suo palazzo rispetta e riverisce “ sua Eccellenza ‘O Principe” ma anche lo teme. “Ssst jesce ‘o Principe”. Dai bassi e dalle botteghe sguardi indagatori seguono,senza darlo a vedere la carrozza con i valletti,nell’intento di scoprire la destinazione del Principe. E’ un personaggio strano,come il suo palazzo,e quella sua chiesetta che ha riempito di statue strane che non si capisce che hanno a che fare con la religione: Come quella donna “ che da sotto un velo di marmo trasparentissimo ti sbatte in faccia due zizze belle tonde e che lui ha chiamato La Pudicizia”,o quel “povero cristo di pescatore finito nella sua stessa rete e che si dibatte per liberarsi e che ha chiamato il Disinganno”. Il popolo rispetta e teme il Principe,ma non lo capisce. E come potrebbe? Raimondo di Sangro, Principe di Sansevero, è senza dubbio uno dei personaggi più affascinanti e misteriosi del Settecento napoletano. Non si può comprenderne appieno la figura,o capire l’essenza delle sue opere se non si considerano le sue origini ed il contesto storico in cui visse. Discendente da stirpe Carolingia,e dalla casata dei duchi di Borgogna,Raimondo nasce il 30 gennaio 1710 a Torremaggiore, in provincia di Foggia, da Antonio di Sangro e da Cecilia Gaetani d’Aragona, famiglie di antichissimo lignaggio, che vantavano ascendenze al medio evo, un’eredità che li poneva in una posizione di autonomia e privilegio rispetto alle varie dominazioni succedutesi a Napoli. La personalità di Raimondo fu influenzata dalle vicende dei genitori. La madre Carlotta era morta quando il Principe aveva un anno; era figlia di Aurora Sanseverino e Nicola Gaetani, intellettuali, mecenati di filosofi e di artisti come Vico e Solimena, fautori dello sviluppo di un pensiero rinnovatore che i primi del 1700 poteva apparire rivoluzionario. Ma altri personaggi nella stessa casata influenzeranno notevolmente il pensiero e le opere di Raimondo: l’abate del monastero benedettino di Montecassino, S.Berardo, S.Oderisio,il Vescovo Leone Ostiense autore dei primi libri della Cronica Casinensis. Il ramo paterno, di tradizione militare, annoverava numerosi condottieri al servizio dell’esercito spagnolo lungo tutto l’arco del vicereame. Ma è soprattutto nel periodo asburgico (1705-1734), dopo la morte di Carlo II di Spagna, che la famiglia di Sangro divenne particolarmente potente. Il nonno, Paolo di Sangro, si era guadagnato il titolo di Grande di Spagna, di prima categoria, per sé e per i suoi discendenti maschi, oltre a tutti gli incarichi ufficiali presso la corte. La figura del nonno paterno ha un ruolo fondamentale nella formazione di Raimondo, poiché è alle sue cure, cui era stato affidato da piccolissimo, che si deve lo sviluppo intellettuale del Principe e il suo amore per la ricerca. Raimondo era stato mandato a Roma a studiare presso i Gesuiti dove era entrato in contatto con una cultura orientata sia in senso umanistico che scientifico,e per entrambe le branche del sapere Raimondo aveva manifestato interesse ed inclinazione. Fu scrittore arguto e brillante, intellettuale illuminato dall'ingegno vivacissimo e dai molteplici interessi, dedito a studi e ricerche spesso discutibili. La sua conoscenza del pensiero dell’epoca, è dimostrata dalla sua biblioteca: 1600 volumi circa con opere autografe di Pierre Bayle, Denis Diderot, Montesquieu, Voltaire, Condillac, Rousseau, e tanti altri. Innumerevoli le opere a carattere tecnico-scientifico. L’unico testo di carattere cabalistico era Il Conte di Gabalis, scritto dall’abate francese Villars de Mountfauçon, che il Principe aveva nell’edizione originale francese del 1742 e che aveva tradotta in Italiano e pubblicata nel 1752. Esponente di primo piano della nobiltà del Regno,fu tuttavia aperto alla borghesia del tempo,considerando nobili “coloro che mostrano ingegno virtù ed onestà”, Gran Maestro della Massoneria napoletana dalla personalità anticonformista e poliedrica, dopo aver suscitato l'ammirazione e la curiosità dei contemporanei, ma anche forti ed irriducibili opposizioni, ha continuato ad esercitare, nel corso dei secoli, un fascino del tutto particolare, assumendo talvolta gli inquietanti tratti di uno stregone,dell'iniziato e dell'alchimista,dell’inventore,sempre,tuttavia,quelli di un personaggio quanto mai enigmatico. Sarà per tutte queste caratteristiche, per l'enfasi un po' guascona con cui presentava se stesso e ogni sua creazione, che tra gli animi più avveduti un'aura di maldicenza ne accompagna la memoria. “O principe è 'nu riavulo”, ripete ancora e sempre la voce del vicolo;con sufficienza e una punta di fastidio, la casta dei sapienti precisa: “il principe è solo un ciarlatano , credulo nelle antiche fandonie sulla magia alchimistica”. E lui rivendicava la magia quale scienza di ciò che è ancora ignoto in grembo alla Natura. Magia pervasa dal soffio del divino. In questo senso si voleva Mago. Ma la vita del Principe de Sangro è un insieme di simbologie alchemiche,magiche,massoniche ed ermetiche,in accordo con l'originaria dottrina egizia,secondo la quale, per ottenere l'illuminazione bisogna operare un cammino che prevede di tagliare simbolicamente a pezzi il proprio corpo ed aspettare che esso attraversi la sua fase di putrefazione affinché risorga a nuova vita, una vita dominata dallo spirito. E’ la trasposizione del mito della morte e resurrezione di Osiride che, posto all'interno di un sarcofago delle sue dimensioni e fatto a pezzi dal fratello Seth, verrà ricomposto da Iside per dare alla luce il figlio Horus, lo spirito splendente d'oro. E’ ormai noto che la società dei Liberi Muratori in Europa ebbe il suo primo embrione in Calabria con la scuola Pitagorica, denominata per antonomasia Scuola-Italica,ed i misteri di Iside ed Osiride, coi rispettivi rituali delle iniziazioni arcane e misteriose. Dato che si vuole che lo stesso Numa Pompilio sia stato iniziato a questa Scuola misterica,. possiamo dire che Scuola Pitagorica,Scuola Italica e Massoneria Italiana sono da sempre legate da un unico filo che parte dall’Egitto,ed in ossequio alle loro origini, i liberi muratori del Grande Oriente di Napoli si mostrarono sempre gelosi nel custodire le dottrine dell’Ordine ed,a fronte di qualunque ostacolo,ne propagandarono i principi che sono pervenuti sino a noi attraverso molti secoli, I Figli del Sebeto mostrarono sempre coraggio e virtù nell’affrontare arditamente i patiboli e col “non far di berretto o inchinarsi giammai all’odiatissimo dispotismo”. Fu per effetto di questi principi che si proclamò in Napoli il Regime Repubblicano e la Repubblica Partenopea, che costava al popolo tanti sacrifici, non così facilmente si sarebbe spenta se non fosse stata stroncata dal fanatismo religioso appoggiato il dispotismo. Nel napoletano il secolo dei lumi si caratterizza come un momento di fervente attività in ogni campo. E’ un periodo storico, che lascia una traccia profonda nella storia del Mezzogiorno d’Italia, sia sotto l’aspetto culturale che per gli avvenimenti di carattere socio-economico che ebbero a verificarsi. Può ben dirsi, per le iniziative di varia natura che vi si presero, che questo secolo contribuì notevolmente a creare una Napoli proiettata nel futuro. Come non riconoscere i grandi meriti di Carlo di Borbone,nel rinnovamento napoletano dell’epoca? Fu infatti grazie alla sua azione di governo che: -Si costituì il collegio “Nautico”, per la formazione di ufficiali della marina mercantile; -Venne fondato il Corpo dei Piloti di porto; -Furono incrementati gli scambi commerciali fra il Regno di Napoli ed i paesi dell’area mediterranea -Fu introdotto nel Regno il “gioco del lotto”, -Il 2 luglio 1738, nacque l’Ordine Cavalleresco di San Gennaro,che sostituì quello di San Carlo - nel marzo del 1737 ebbe inizio la costruzione del Teatro San Carlo, affidata all’architetto Angelo Carotale, -Su disegno dell’architetto cav. Fuga, fu costruito l’Albergo dei Poveri, aperto ai diseredati di tutto il Regno. -Ed ancora l’opera di ammodernamento della capitale, il miglioramento dell’edificio dei Regi Studi,la costruzione della Reggia di Caserta, su progetto dell’architetto Vanvitelli Anche sul piano culturale, si ebbe un’imponente ripresa di ogni attività esaltante il pensiero umano,infatti si diede in questo periodo, grande impulso agli scavi di Ercolano e di Pompei, istituendo una scuola per la decifrazione dei Papiri Ercolanensi, . L’Università degli Studi di Napoli, fondata da Federico II°, venne ravvivata da Carlo che vi raccolse i migliori intelletti del secolo, facendone il centro motore del movimento illuministico del Settecento napoletano. Anche l’Accademia di Lettere e Scienze mutò sistema di lavoro, abbandonando ogni pompa del passato, prendendo di mira l’utilità della collettività nazionale, richiedendo l’applicazione alle arti, alla medicina, alle lettere, affinché venissero chiariti i punti basilari della storia patria, in modo da contribuire al miglioramento dell’arte di governo dei popoli. Notevole fu l’apporto che questo secolo ricevette dall’azione di uomini illuminati quali: Raimondo di Sangro, Francesco Spirito Principe di Scalea, Paolo Doria Principe d’Angri, Vincenzo Cuoco, Domenico Cirillo, Pietro Colletta, il Tenucci, Gaetano Filangieri, il Marchese Vargas Macciucca, Giuseppe Aurelio De Gennaro, Pasquale Cirillo, Biagio Troie, Mario Pagano, mentre fra gli ecclesiastici ricordiamo il Genovesi, il Galliani, il Martini, Padre Carconi e l’arcivescovo Rossi. Non poteva mancare il contributo femminile a questo particolare momento storico e notevole fu quello dato da donne come: Faustina Pignatelli, Eleonora Pimentel Fonseca e tante altre ancora. Fu appunto questa notevole ripresa culturale della Napoli settecentesca che, assieme all’incrementato scambio con altri paesi, dette quello che poi venne definito: «l’Illuminismo napoletano» che anche sul piano socio-politico, doveva porre i presupposti per quella grande pagina di storia che fu la Rivolta e la gloriosa Repubblica Partenopea. Grande posizione assume in questo quadro, appena accennato,il fenomeno Massonico, per gli uomini che ne furono i propulsori ma anche per la tenace azione da essa assolta nella storia di questo secolo. Fu infatti dalla Massoneria Napoletana che si manifestarono importanti componenti ideali che troveranno poi la loro identificazione più evidente, nei paesi più liberali. Vediamo infatti la giovane Massoneria Napoletana di questo secolo muoversi con la spontaneità propria dei modelli nuovi,allo scopo di dare il suo storico contributo alla società nella quale si trova ad operare,spesso subendo persecuzioni e censure per affermare,primo tra tutti il diritto di associazione È infatti molto indicativo in proposito, leggere l’inizio del “De Collegiis et Corporibus” ove è detto: «In qualunque ben regolato governo non vi è male, che più contraddica e distrugga i principi dell’intrinseca sua costituzione, quanto la perniciosa libertà, che si arrogassero i cittadini di portare a loro capriccio di formare unioni, e stringersi in società». Un sicuro insediamento della massoneria a Napoli, a parte un precedente del 1728 (relativo ad una loggia denominata Perfetta Unione di cui tratteremo poi), può esser fatto risalire al 1745, allorquando un commerciante francese Louis Larnage fondò una nuova Loggia che divenne “giusta” nel 1749, quando vi vennero iniziati cinque ufficiali borbonici e successivamente altri dieci fratelli tra cui Francesco Zelaja ed il sacerdote Filippo Nazani Paltoni. Secondo quanto scrive Francovich, la Loggia svolgeva i lavori nel rispetto dei Rituali inglesi con i tre gradi della M. Azzurra (apprendista, compagno e maestro) Nell’anno 1750 venne eletto Maestro Venerabile lo Zelaja, il quale desideroso di rilanciare l’Ordine Massonico, avvertiva la necessità di immettere nella Famiglia uomini di alto lignaggio che avessero potuto offrire all’Ordine protezione e facilitarne l’azione di proselitismo come Gennaro Carafa,Domenico Venier,il principe di Calvarusso.In questo periodo vengono inseriti ad opera del R+C Charles Radcliff altri gradi detti Superiori o Scozzesi Nel contempo la Loggia si trasferisce al Palazzo del Marchese Rimise. In questa nuova sede vennero ricevuti diversi ufficiali e nobili di alto rango, fra i quali Gennaro Carafa Principe della Roccella. Nel luglio del 1750 viene iniziato Libero Muratore Raimondo di Sangro Principe di Sansevero, il quale l’anno successivo assume il titolo di gran maestro. In questo periodo v’erano due distinte correnti massoniche nel regno di Napoli: una formata dai ranghi più elevati della gerarchia militare insieme ai nobili legati alla corte, e che operava con gli alti Gradi,ed una seconda che accoglieva gran parte dei commercianti,inglesi e francesi, ed anche ufficiali di basso rango. La maggioranza di coloro che componevano questa seconda «ala» borghese delle logge partenopee era di religione calvinista, ed era questa ala che era guidata dallo Zelaja. A partire dal momento del riconoscimento di Raimondo come Gran Maestro di tutte le logge napoletane, il Principe si tuffa nella politica del regno, avvicinandosi al Re di cui gode la stima e collaborando alla ristrutturazione dell’esercito, anche attraverso l’invenzione di macchine da guerra, del tutto nuove per l’epoca. Convinto seguace di Bayle, Shaftesbury, Collins e Toland, da cui aveva mutuato i principi di tolleranza religiosa e di libertà di pensiero, il Principe non può fare a meno di coinvolgere nel proprio progetto i magistrati con i quali i nobili rivaleggiavano «negli affari del Regno» procurando grave disagio alla corona, al regno intero, ed offrendo all’estero motivo di discredito per il Regno di Napoli. Questo aprirsi di Raimondo alla borghesia, questo considerare «nobili» coloro i quali mostrano ingegno, virtù, ed onestà, e’ di certo dovuto all’evolversi del suo pensiero massonico. Tale attività la mantenne fino al 1751 anno in cui,Carlo III di Borbone dovette con un editto cancellare le logge napoletane e bandire la massoneria dal regno. Comunque la Napoli di quegli anni è da considerarsi un vero crogiuolo di attività esoteriche, di sodalizi iniziatici di diversa matrice,che, amalgamatisi gradatamente fra loro, originarono un complesso regime esoterico di natura sincretica, dalla prevalente e spiccata matrice italico-egizia-caldaica. E' proprio a Napoli che nacque e prosperò quel centro tradizionale che, secondo Brunelli, “di volta in volta diede manifestazioni di sé attraverso l'ispirazione di fratellanze esoteriche di particolare importanza” a noi noti come "Rito di Misraim, Alta Massoneria, Ordine della Stella Fiammeggiante”; strutture iniziatiche che, come osserva il Kremmerz, “originatesi dalle scuole magiche osiridee, propriamente di origini italiche, e passate insospettate fino alla seconda metà del secolo XVIII, (sono) ritornate poi nell'ombra della storia, tanto che ora non si sa dove stiano e se ancora esistano”. Ad ogni modo, ancora oscuri e scarsamente documentati appaiono i primi indizi dell'ermetismo di ispirazione egizia nel pensiero del secolo dei "lumi" che, nella Massoneria, troveranno i "segni" più incisivi della loro riscoperta. La fondazione di una loggia con connotazioni egizie, anche se non sicuramente documentata sembra risalire al tempo del viceregno austriaco in Napoli, ma dati più certi si hanno per la metà del XVIII secolo. La notizia è in buona parte confermata da un ms. compilato appena dopo il 1750 da un anonimo Curioso dilettante di novità. La particolarità dell'officina napoletana della Perfetta Unione che, come vedremo, assumerà la denominazione di "Primaria Loggia",era quella di far uso di un sigillo caratterizzata da una piramide sormontata dal sole raggiante, davanti alla quale vi era la sfinge, e la rappresentazione della luna crescente sul dorso. Le zampe anteriori poggiano su un ramo di acacia e su di una pietra cubica grezza. Il sigillo in argento, avorio. ed oro reca le seguenti leggende: SIG: NEAPOLIT: LATOMOR: FRATERN: PERFETTA-UNIONE...ed all'interno, nel campo superiore la frase :QUI QUASI CURSORES VITAE LAMPADA TRADUNT A.L. 1728 che si traduce in SIGILLO DELLA FRATELLANZA DEI MURATORI NAPOLETANI DELLA PERFETTA UNIONE;COLORO CHE COME CORRIDORI TRASMETTONO LA LAMPADA DELLA VITA. ANNO DELLA LUCE 1728. Il sigillo,che quindi sposterebbe al 1728 l'anno di fondazione della Perfetta Unione,presenta notevoli analogie con una medaglia commemorativa realizzata dai massoni romani nel 1742 durante la permanenza del celebre massone inglese Martin Folkes nella capitale. Infatti, praticamente simili sono i motivi della piramide (per alcuni sarebbe quella romana di Caio Cestio), del sole radiante, della sfinge della luna,del ramo di acacia, della pietra cubica. Tale medaglia era stata realizzata ispirandosi al sigillo della Perfetta Unione napoletana? Oltre ai riferimenti del Francovich, un'altra fonte confermerebbe l'esistenza di una loggia operativa detta della Perfetta Unione in Napoli nel 1728. La notizia è tratta dalle Tavole Barbaia, documento che, nel 1885, attestava la ricostruzione della Perfetta Unione all'Obbedienza del Supremo Consiglio del 33° Grado per la Giurisdizione Italiana sedente a Torino. Nella breve cronistoria che contiene, la Tavola rimanda al 1728 l'origine della Perfetta Unione napoletana.
A bordo della sua carrozza,entra o esce dal suo palazzo nel centro di Napoli il Principe di Sansevero, «Signore di corta statura, di gran capo, di bello e gioviale aspetto, filosofo di spirito, molto dedito nelle meccaniche, di amabilissimo e dolcissimo costume, studioso e ritirato, amante la conversazione di uomini di lettere», come lo descrive l’illuminista Antonio Genovesi. Entra in scena e subito la domina: i vicoli si animano,mille occhi curiosi furtivamente scrutano dalle finestre,da dietro i carretti,dai crocchi,dalla chiesa e dall’osteria. Tutta la massa del popolo che si assiepa intorno al suo palazzo rispetta e riverisce “ sua Eccellenza ‘O Principe” ma anche lo teme. “Ssst jesce ‘o Principe”. Dai bassi e dalle botteghe sguardi indagatori seguono,senza darlo a vedere la carrozza con i valletti,nell’intento di scoprire la destinazione del Principe. E’ un personaggio strano,come il suo palazzo,e quella sua chiesetta che ha riempito di statue strane che non si capisce che hanno a che fare con la religione: Come quella donna “ che da sotto un velo di marmo trasparentissimo ti sbatte in faccia due zizze belle tonde e che lui ha chiamato La Pudicizia”,o quel “povero cristo di pescatore finito nella sua stessa rete e che si dibatte per liberarsi e che ha chiamato il Disinganno”. Il popolo rispetta e teme il Principe,ma non lo capisce. E come potrebbe? Raimondo di Sangro, Principe di Sansevero, è senza dubbio uno dei personaggi più affascinanti e misteriosi del Settecento napoletano. Non si può comprenderne appieno la figura,o capire l’essenza delle sue opere se non si considerano le sue origini ed il contesto storico in cui visse. Discendente da stirpe Carolingia,e dalla casata dei duchi di Borgogna,Raimondo nasce il 30 gennaio 1710 a Torremaggiore, in provincia di Foggia, da Antonio di Sangro e da Cecilia Gaetani d’Aragona, famiglie di antichissimo lignaggio, che vantavano ascendenze al medio evo, un’eredità che li poneva in una posizione di autonomia e privilegio rispetto alle varie dominazioni succedutesi a Napoli. La personalità di Raimondo fu influenzata dalle vicende dei genitori. La madre Carlotta era morta quando il Principe aveva un anno; era figlia di Aurora Sanseverino e Nicola Gaetani, intellettuali, mecenati di filosofi e di artisti come Vico e Solimena, fautori dello sviluppo di un pensiero rinnovatore che i primi del 1700 poteva apparire rivoluzionario. Ma altri personaggi nella stessa casata influenzeranno notevolmente il pensiero e le opere di Raimondo: l’abate del monastero benedettino di Montecassino, S.Berardo, S.Oderisio,il Vescovo Leone Ostiense autore dei primi libri della Cronica Casinensis. Il ramo paterno, di tradizione militare, annoverava numerosi condottieri al servizio dell’esercito spagnolo lungo tutto l’arco del vicereame. Ma è soprattutto nel periodo asburgico (1705-1734), dopo la morte di Carlo II di Spagna, che la famiglia di Sangro divenne particolarmente potente. Il nonno, Paolo di Sangro, si era guadagnato il titolo di Grande di Spagna, di prima categoria, per sé e per i suoi discendenti maschi, oltre a tutti gli incarichi ufficiali presso la corte. La figura del nonno paterno ha un ruolo fondamentale nella formazione di Raimondo, poiché è alle sue cure, cui era stato affidato da piccolissimo, che si deve lo sviluppo intellettuale del Principe e il suo amore per la ricerca. Raimondo era stato mandato a Roma a studiare presso i Gesuiti dove era entrato in contatto con una cultura orientata sia in senso umanistico che scientifico,e per entrambe le branche del sapere Raimondo aveva manifestato interesse ed inclinazione. Fu scrittore arguto e brillante, intellettuale illuminato dall'ingegno vivacissimo e dai molteplici interessi, dedito a studi e ricerche spesso discutibili. La sua conoscenza del pensiero dell’epoca, è dimostrata dalla sua biblioteca: 1600 volumi circa con opere autografe di Pierre Bayle, Denis Diderot, Montesquieu, Voltaire, Condillac, Rousseau, e tanti altri. Innumerevoli le opere a carattere tecnico-scientifico. L’unico testo di carattere cabalistico era Il Conte di Gabalis, scritto dall’abate francese Villars de Mountfauçon, che il Principe aveva nell’edizione originale francese del 1742 e che aveva tradotta in Italiano e pubblicata nel 1752. Esponente di primo piano della nobiltà del Regno,fu tuttavia aperto alla borghesia del tempo,considerando nobili “coloro che mostrano ingegno virtù ed onestà”, Gran Maestro della Massoneria napoletana dalla personalità anticonformista e poliedrica, dopo aver suscitato l'ammirazione e la curiosità dei contemporanei, ma anche forti ed irriducibili opposizioni, ha continuato ad esercitare, nel corso dei secoli, un fascino del tutto particolare, assumendo talvolta gli inquietanti tratti di uno stregone,dell'iniziato e dell'alchimista,dell’inventore,sempre,tuttavia,quelli di un personaggio quanto mai enigmatico. Sarà per tutte queste caratteristiche, per l'enfasi un po' guascona con cui presentava se stesso e ogni sua creazione, che tra gli animi più avveduti un'aura di maldicenza ne accompagna la memoria. “O principe è 'nu riavulo”, ripete ancora e sempre la voce del vicolo;con sufficienza e una punta di fastidio, la casta dei sapienti precisa: “il principe è solo un ciarlatano , credulo nelle antiche fandonie sulla magia alchimistica”. E lui rivendicava la magia quale scienza di ciò che è ancora ignoto in grembo alla Natura. Magia pervasa dal soffio del divino. In questo senso si voleva Mago. Ma la vita del Principe de Sangro è un insieme di simbologie alchemiche,magiche,massoniche ed ermetiche,in accordo con l'originaria dottrina egizia,secondo la quale, per ottenere l'illuminazione bisogna operare un cammino che prevede di tagliare simbolicamente a pezzi il proprio corpo ed aspettare che esso attraversi la sua fase di putrefazione affinché risorga a nuova vita, una vita dominata dallo spirito. E’ la trasposizione del mito della morte e resurrezione di Osiride che, posto all'interno di un sarcofago delle sue dimensioni e fatto a pezzi dal fratello Seth, verrà ricomposto da Iside per dare alla luce il figlio Horus, lo spirito splendente d'oro. E’ ormai noto che la società dei Liberi Muratori in Europa ebbe il suo primo embrione in Calabria con la scuola Pitagorica, denominata per antonomasia Scuola-Italica,ed i misteri di Iside ed Osiride, coi rispettivi rituali delle iniziazioni arcane e misteriose. Dato che si vuole che lo stesso Numa Pompilio sia stato iniziato a questa Scuola misterica,. possiamo dire che Scuola Pitagorica,Scuola Italica e Massoneria Italiana sono da sempre legate da un unico filo che parte dall’Egitto,ed in ossequio alle loro origini, i liberi muratori del Grande Oriente di Napoli si mostrarono sempre gelosi nel custodire le dottrine dell’Ordine ed,a fronte di qualunque ostacolo,ne propagandarono i principi che sono pervenuti sino a noi attraverso molti secoli, I Figli del Sebeto mostrarono sempre coraggio e virtù nell’affrontare arditamente i patiboli e col “non far di berretto o inchinarsi giammai all’odiatissimo dispotismo”. Fu per effetto di questi principi che si proclamò in Napoli il Regime Repubblicano e la Repubblica Partenopea, che costava al popolo tanti sacrifici, non così facilmente si sarebbe spenta se non fosse stata stroncata dal fanatismo religioso appoggiato il dispotismo. Nel napoletano il secolo dei lumi si caratterizza come un momento di fervente attività in ogni campo. E’ un periodo storico, che lascia una traccia profonda nella storia del Mezzogiorno d’Italia, sia sotto l’aspetto culturale che per gli avvenimenti di carattere socio-economico che ebbero a verificarsi. Può ben dirsi, per le iniziative di varia natura che vi si presero, che questo secolo contribuì notevolmente a creare una Napoli proiettata nel futuro. Come non riconoscere i grandi meriti di Carlo di Borbone,nel rinnovamento napoletano dell’epoca? Fu infatti grazie alla sua azione di governo che: -Si costituì il collegio “Nautico”, per la formazione di ufficiali della marina mercantile; -Venne fondato il Corpo dei Piloti di porto; -Furono incrementati gli scambi commerciali fra il Regno di Napoli ed i paesi dell’area mediterranea -Fu introdotto nel Regno il “gioco del lotto”, -Il 2 luglio 1738, nacque l’Ordine Cavalleresco di San Gennaro,che sostituì quello di San Carlo - nel marzo del 1737 ebbe inizio la costruzione del Teatro San Carlo, affidata all’architetto Angelo Carotale, -Su disegno dell’architetto cav. Fuga, fu costruito l’Albergo dei Poveri, aperto ai diseredati di tutto il Regno. -Ed ancora l’opera di ammodernamento della capitale, il miglioramento dell’edificio dei Regi Studi,la costruzione della Reggia di Caserta, su progetto dell’architetto Vanvitelli Anche sul piano culturale, si ebbe un’imponente ripresa di ogni attività esaltante il pensiero umano,infatti si diede in questo periodo, grande impulso agli scavi di Ercolano e di Pompei, istituendo una scuola per la decifrazione dei Papiri Ercolanensi, . L’Università degli Studi di Napoli, fondata da Federico II°, venne ravvivata da Carlo che vi raccolse i migliori intelletti del secolo, facendone il centro motore del movimento illuministico del Settecento napoletano. Anche l’Accademia di Lettere e Scienze mutò sistema di lavoro, abbandonando ogni pompa del passato, prendendo di mira l’utilità della collettività nazionale, richiedendo l’applicazione alle arti, alla medicina, alle lettere, affinché venissero chiariti i punti basilari della storia patria, in modo da contribuire al miglioramento dell’arte di governo dei popoli. Notevole fu l’apporto che questo secolo ricevette dall’azione di uomini illuminati quali: Raimondo di Sangro, Francesco Spirito Principe di Scalea, Paolo Doria Principe d’Angri, Vincenzo Cuoco, Domenico Cirillo, Pietro Colletta, il Tenucci, Gaetano Filangieri, il Marchese Vargas Macciucca, Giuseppe Aurelio De Gennaro, Pasquale Cirillo, Biagio Troie, Mario Pagano, mentre fra gli ecclesiastici ricordiamo il Genovesi, il Galliani, il Martini, Padre Carconi e l’arcivescovo Rossi. Non poteva mancare il contributo femminile a questo particolare momento storico e notevole fu quello dato da donne come: Faustina Pignatelli, Eleonora Pimentel Fonseca e tante altre ancora. Fu appunto questa notevole ripresa culturale della Napoli settecentesca che, assieme all’incrementato scambio con altri paesi, dette quello che poi venne definito: «l’Illuminismo napoletano» che anche sul piano socio-politico, doveva porre i presupposti per quella grande pagina di storia che fu la Rivolta e la gloriosa Repubblica Partenopea. Grande posizione assume in questo quadro, appena accennato,il fenomeno Massonico, per gli uomini che ne furono i propulsori ma anche per la tenace azione da essa assolta nella storia di questo secolo. Fu infatti dalla Massoneria Napoletana che si manifestarono importanti componenti ideali che troveranno poi la loro identificazione più evidente, nei paesi più liberali. Vediamo infatti la giovane Massoneria Napoletana di questo secolo muoversi con la spontaneità propria dei modelli nuovi,allo scopo di dare il suo storico contributo alla società nella quale si trova ad operare,spesso subendo persecuzioni e censure per affermare,primo tra tutti il diritto di associazione È infatti molto indicativo in proposito, leggere l’inizio del “De Collegiis et Corporibus” ove è detto: «In qualunque ben regolato governo non vi è male, che più contraddica e distrugga i principi dell’intrinseca sua costituzione, quanto la perniciosa libertà, che si arrogassero i cittadini di portare a loro capriccio di formare unioni, e stringersi in società». Un sicuro insediamento della massoneria a Napoli, a parte un precedente del 1728 (relativo ad una loggia denominata Perfetta Unione di cui tratteremo poi), può esser fatto risalire al 1745, allorquando un commerciante francese Louis Larnage fondò una nuova Loggia che divenne “giusta” nel 1749, quando vi vennero iniziati cinque ufficiali borbonici e successivamente altri dieci fratelli tra cui Francesco Zelaja ed il sacerdote Filippo Nazani Paltoni. Secondo quanto scrive Francovich, la Loggia svolgeva i lavori nel rispetto dei Rituali inglesi con i tre gradi della M. Azzurra (apprendista, compagno e maestro) Nell’anno 1750 venne eletto Maestro Venerabile lo Zelaja, il quale desideroso di rilanciare l’Ordine Massonico, avvertiva la necessità di immettere nella Famiglia uomini di alto lignaggio che avessero potuto offrire all’Ordine protezione e facilitarne l’azione di proselitismo come Gennaro Carafa,Domenico Venier,il principe di Calvarusso.In questo periodo vengono inseriti ad opera del R+C Charles Radcliff altri gradi detti Superiori o Scozzesi Nel contempo la Loggia si trasferisce al Palazzo del Marchese Rimise. In questa nuova sede vennero ricevuti diversi ufficiali e nobili di alto rango, fra i quali Gennaro Carafa Principe della Roccella. Nel luglio del 1750 viene iniziato Libero Muratore Raimondo di Sangro Principe di Sansevero, il quale l’anno successivo assume il titolo di gran maestro. In questo periodo v’erano due distinte correnti massoniche nel regno di Napoli: una formata dai ranghi più elevati della gerarchia militare insieme ai nobili legati alla corte, e che operava con gli alti Gradi,ed una seconda che accoglieva gran parte dei commercianti,inglesi e francesi, ed anche ufficiali di basso rango. La maggioranza di coloro che componevano questa seconda «ala» borghese delle logge partenopee era di religione calvinista, ed era questa ala che era guidata dallo Zelaja. A partire dal momento del riconoscimento di Raimondo come Gran Maestro di tutte le logge napoletane, il Principe si tuffa nella politica del regno, avvicinandosi al Re di cui gode la stima e collaborando alla ristrutturazione dell’esercito, anche attraverso l’invenzione di macchine da guerra, del tutto nuove per l’epoca. Convinto seguace di Bayle, Shaftesbury, Collins e Toland, da cui aveva mutuato i principi di tolleranza religiosa e di libertà di pensiero, il Principe non può fare a meno di coinvolgere nel proprio progetto i magistrati con i quali i nobili rivaleggiavano «negli affari del Regno» procurando grave disagio alla corona, al regno intero, ed offrendo all’estero motivo di discredito per il Regno di Napoli. Questo aprirsi di Raimondo alla borghesia, questo considerare «nobili» coloro i quali mostrano ingegno, virtù, ed onestà, e’ di certo dovuto all’evolversi del suo pensiero massonico. Tale attività la mantenne fino al 1751 anno in cui,Carlo III di Borbone dovette con un editto cancellare le logge napoletane e bandire la massoneria dal regno. Comunque la Napoli di quegli anni è da considerarsi un vero crogiuolo di attività esoteriche, di sodalizi iniziatici di diversa matrice,che, amalgamatisi gradatamente fra loro, originarono un complesso regime esoterico di natura sincretica, dalla prevalente e spiccata matrice italico-egizia-caldaica. E' proprio a Napoli che nacque e prosperò quel centro tradizionale che, secondo Brunelli, “di volta in volta diede manifestazioni di sé attraverso l'ispirazione di fratellanze esoteriche di particolare importanza” a noi noti come "Rito di Misraim, Alta Massoneria, Ordine della Stella Fiammeggiante”; strutture iniziatiche che, come osserva il Kremmerz, “originatesi dalle scuole magiche osiridee, propriamente di origini italiche, e passate insospettate fino alla seconda metà del secolo XVIII, (sono) ritornate poi nell'ombra della storia, tanto che ora non si sa dove stiano e se ancora esistano”. Ad ogni modo, ancora oscuri e scarsamente documentati appaiono i primi indizi dell'ermetismo di ispirazione egizia nel pensiero del secolo dei "lumi" che, nella Massoneria, troveranno i "segni" più incisivi della loro riscoperta. La fondazione di una loggia con connotazioni egizie, anche se non sicuramente documentata sembra risalire al tempo del viceregno austriaco in Napoli, ma dati più certi si hanno per la metà del XVIII secolo. La notizia è in buona parte confermata da un ms. compilato appena dopo il 1750 da un anonimo Curioso dilettante di novità. La particolarità dell'officina napoletana della Perfetta Unione che, come vedremo, assumerà la denominazione di "Primaria Loggia",era quella di far uso di un sigillo caratterizzata da una piramide sormontata dal sole raggiante, davanti alla quale vi era la sfinge, e la rappresentazione della luna crescente sul dorso. Le zampe anteriori poggiano su un ramo di acacia e su di una pietra cubica grezza. Il sigillo in argento, avorio. ed oro reca le seguenti leggende: SIG: NEAPOLIT: LATOMOR: FRATERN: PERFETTA-UNIONE...ed all'interno, nel campo superiore la frase :QUI QUASI CURSORES VITAE LAMPADA TRADUNT A.L. 1728 che si traduce in SIGILLO DELLA FRATELLANZA DEI MURATORI NAPOLETANI DELLA PERFETTA UNIONE;COLORO CHE COME CORRIDORI TRASMETTONO LA LAMPADA DELLA VITA. ANNO DELLA LUCE 1728. Il sigillo,che quindi sposterebbe al 1728 l'anno di fondazione della Perfetta Unione,presenta notevoli analogie con una medaglia commemorativa realizzata dai massoni romani nel 1742 durante la permanenza del celebre massone inglese Martin Folkes nella capitale. Infatti, praticamente simili sono i motivi della piramide (per alcuni sarebbe quella romana di Caio Cestio), del sole radiante, della sfinge della luna,del ramo di acacia, della pietra cubica. Tale medaglia era stata realizzata ispirandosi al sigillo della Perfetta Unione napoletana? Oltre ai riferimenti del Francovich, un'altra fonte confermerebbe l'esistenza di una loggia operativa detta della Perfetta Unione in Napoli nel 1728. La notizia è tratta dalle Tavole Barbaia, documento che, nel 1885, attestava la ricostruzione della Perfetta Unione all'Obbedienza del Supremo Consiglio del 33° Grado per la Giurisdizione Italiana sedente a Torino. Nella breve cronistoria che contiene, la Tavola rimanda al 1728 l'origine della Perfetta Unione napoletana.Per concludere i riferimenti alle origini dell'officina partenopea, bisogna far menzione di una patente di legalità che, nel maggio 1728,veniva concessa dalla Loggia Madre di Londra a firma di Lord H.H. Coleraine per una non meglio specificata loggia napoletana. In ogni caso la simbologia del sigillo della Perfetta Unione non pone dubbi sul tipo di "tegolatura" usata nella più antica delle officine partenopee, poi diventata verosimilmente "Primaria Loggia" all' epoca del mandato di Raimondo di Sangro. Non conosciamo da documenti l'impronta data dal principe alla sua loggia che, in breve, per il rilevante numero dei muratori dette origine a gemmazione di altre officine. Nonostante l'esiguità del tempo di venerabile in carica,il Sansevero si adoperò per lo più ad organizzare una struttura di più ampio respiro rispetto al passato, e ad appianare i dissensi interni tra gli orientamenti conservatori di Larnage ed innovatori dello Zelaja.Il Sansevero divise i massoni napoletani in tre Logge: la Di Sangro,la Carafa e la Moncada (dai nomi dei rispettivi venerabili). La Di Sangro,forte di trecento fratelli aveva nel suo interno un nucleo di ispirazione Hiramitica,Rosicruciano,alchimistico e templare,come si evidenzia da alcuni documenti scritti dallo stesso Di Sangro al barone Tschudy. Interessante notare che questa “superloggia” operava col titolo di Rosa d’ordine Magno, forse con rituali egizi o ebraico-egizi. Dalla "Lettera Apologetica" si rileva la profonda erudizione del di Sangro relativamente agli Egizi e alle loro conoscenze delle costellazioni, del ritrovamento del Corpus di conoscenze metafisiche di Adamo e delle opere di Ermete Trismegisto. Inoltre,da profondo conoscitore della lingua ebraica,il Sansevero era in grado di consultare gli antichi testi cabalistici nella loro stesura originale,anche se per evitare gli strali della censura ecclesiastica,fu costretto ad attribuire l'origine del geroglifico, e quindi la nascita dell'intelligenza dell'umanità, ad Adamo e alla "ebraica nazione". In questo modo,usando un linguaggio ironico, sembrava accettare la generale impostazione della chiesa che la conoscenza divina passi dalla sapienza ebraica a quella dell'Egitto e che questa sia stata trasmessa da Misraim, nipote di Cham. Questa affermazione apparentemente non eretica viene ribadita dal termine Memphis-Misraim con il quale più che far precedere una tradizione all'altra si tende a far comprendere che esse si trovano entrambe ad oriente del nostro mondo. La pubblicazione, avvenuta il 28 maggio 1751,della Bolla Providas Romanorum Pontificum emanata da Papa Benedetto XIV,al secolo Prospero Lambertini, bolognese(egli stesso massone,cavaliere kadosh),per ribadire la condanna pontificia del 1738 di Papa Clemente XII,del 28 aprile 1738 In Eminenti Apostolatus Specula, indusse Carlo VII di Borbone (poi Carlo III, come re di Spagna) alla promulgazione di un editto (10 luglio1751) che proibiva la Libera Muratoria nel regno di Napoli. Avendo avuto sentore della tempesta che stava per abbattersi sulla massoneria napoletana, fin dal 26 dicembre 1750 il principe di San Severo aveva informato il re sulla esatta realtà dell’organizzazione da lui presieduta e, con altrettanta tempestività, il 1° agosto 1751 inviò al Papa un’abilissima lettera di ritrattazione. Le proteste di lealismo politico-religioso del San Severo valsero a limitare le sanzioni contro i liberi muratori napoletani, che si ridussero per la stragrande maggioranza di essi a una solenne ammonizione giudiziaria grazie anche alla commissione inquirente nominata da re Carlo, composta dal Duca di Mirando,il duca di Castropignano,dal Principe di Centola,e da padre Benedetto Latilla. Unici condannati,il Larnage,il frate francescano Bonaventura di Bisognano ed il barone Tschudy. Dopo il “tradimento” del principe e la fuga del barone Tschudy, la Primaria Loggia o della Perfetta Unione,presumibilmente, venne"assonnata". Tale gesto da alcuni fu interpretato come atto di vigliaccheria, da altri come unico atto possibile per salvare i fratelli, disciogliendo l’ordine. Il progetto del di Sangro era di far risorgere la nobiltà napoletana, spesso accusata di essere dedita solo alla vita di corte, alla caccia, e di essere legata solo ai propri privilegi feudali. Riscattarla quindi dal letargo per aprirla ai fermenti innovatori che in Europa si facevano sentire. Dopo i fatti del 1751,la repressione,la scomunica ed il tentativo a vuoto dell’Inquisizione di tradurlo a Castel Sant’Angelo, Raimondo si vede costretto a chiudere la tipografia in cui stampava i manoscritti da lui stesso tradotti, a volte sotto pseudonimo. Due gesuiti, in particolare, tallonavano da presso il Principe: Innocenzo Molinari e Francesco Pepe che riferivano ai responsabili superiori dei «servizi» vaticani circa le opere e le iniziative del Principe. Soprattutto si scagliavano, nei loro rapporti, contro le opere «pericolosamente scientifiche» che Raimondo stampava e divulgava. Costretto al silenzio, Raimondo di Sangro non trovò altra maniera di dialogare con il mondo intelligente che quello di scrivere il proprio testamento spirituale nella Cappella, da lasciare a quella parte di mondo che, animata dalla sete della conoscenza, avrebbe profuso sforzi ed energia per interpretarlo. Mancano notizie certe fino al 1768, data di una petizione da parte di Jean Rodolphe Passavant alla Grand Lodge of England per essere autorizzato a ricostituire in Napoli la loggia regolare La Perfetta Unione, portandola, successivamente, alla dignità di Gran Loggia Provinciale. Nel 1763, divenuto re di Spagna dal 1759 Carlo VII, e regnante sotto la tutela del toscano ministro Bernardo Tanucci l’ancora minore suo figliolo Ferdinando IV, il gran maestro aggiunto della G.L. Nazionale d’Olanda, Franc Van der Goes, concesse una patente provvisoria di fondazione per una loggia sotto la denominazione di Les Zelés. La patente definitiva venne rilasciata il 10 agosto 1763 e ad essa il 10 marzo 1764 fece seguito un’altra patente, che promuoveva la loggia Les Zelés al rango di Gran Loggia Provinciale per il regno di Napoli. In questo momento, nella massoneria napoletana operano personaggi importanti come Luigi D'Aquino (1739-1783), fratello del principe Francesco, legato al noto Giuseppe Balsamo. Benché occultata, la Napoli massonica era rappresentata da piccoli gruppi tenuti uniti dal fratello Francesco, per lo più interessati a vendicarsi delle delazioni e tradimenti subiti con la famosa "sorpresa di Capodimonte" del capo della polizia, Pallante per ordine del ministro Tanucci. Nel 1767 viene denunciato a corte da un massone "pentito" e da un prete, il duca di Torremaggiore, Vincenzo Di Sangro (1743-1790), figlio di don Raimondo e futuro principe che alla morte del padre erediterà il titolo principesco, il palazzo e le proprietà e, soprattutto, i numerosi debiti che un matrimonio di interesse riuscì appena ad arginare. Comunque Vincenzo,subito dopo la morte del padre, ricostituì la Perfetta Unione che non essendo riconosciuta dalla Gran Loggia d'Inghilterra, fu considerata irregolare,ma,fu quasi certamente il cavalier D'Aquino, cugino del Di Sangro, ad introdurre nel Corpus dottrinario della loggia un'operatività segreta a cui lo stesso era stato iniziato a Malta e che si riteneva fosse derivata dall'antica sapienza sacerdotale egizia e caldea. Oltre al Balsamo-Cagliostro (1743-1795) che grazie all'amicizia del D'Aquino, ebbe contatti con la loggia, impossessandosi, forse, della liturgia di un rito che gli fu utile per il suo rituale egizio, vanno ricordati, in quanto appartenenti alla Perfetta Unione, Nicola Palomba sacerdote di Avigliano (1746-1799), Carlo Castone Della Torre Di Rezzonico, Francesco Caracciolo (1752-1799). Non si possono del resto ignorare massoni intellettuali e patrioti come Gaetano Filangieri principe di Arianello (1752-1788), Mario Pagano, Domenico Cirillo e tanti altri. Ma,ritorniamo al Sansevero .Nel 1744, dopo essersi distinto nella battaglia di Velletri, è ricevuto dal Pontefice Benedetto XIV ottenendo la "licenza di poter leggere ogni genere di libri proibiti", ed inizia un periodo di intensa attività intellettuale "con occuparsi nel giorno del continuo a studi meccanici, e nella notte, ove si gode una maggior quiete, e sono più lontani i rumori, alle scienze, ed arriviamo al periodo cruciale della vita di Raimondo di Sangro, che in pochi anni viene iniziato nella Libera Muratoria (se dobbiamo ritenere rispondente a verità la sua dichiarazione di essere stato iniziato il 22 Luglio 1750) e poco dopo ne diventa il Gran Maestro, elabora con il Corradini, anch'egli Libero Muratore, il programma iconografico della Cappella e dà inizio alla sua decorazione. Abbiamo visto che la prima Loggia Massonica costituita dal Larnage, subì una scissione ad opera degli aristocratici i quali si riunivano in Palazzo Alvise e riconobbero quale loro Maestro Venerabile il Di Sangro, mentre il Larnage costituì una nuova Loggia alla quale dettero la loro adesione quei fratelli rimasti fedeli alla Ritualità inglese. Prima fatica del Maestro Venerabile Di Sangro fu quindi quella di avere intensi contatti con il Larnage ed i suoi seguaci, allo scopo di eliminare ogni malinteso fra le due Logge e far rientrare la scissione, e la sua tenace azione ebbe positivi risultati. Infatti il 24 ottobre 1750, a Posillipo, nella villa del Principe Gennaro Carafa, si pervenne all’agognata unificazione dei due rami della Massoneria Napoletana, tanto che,nella predetta riunione il Larnage riconobbe il Principe Raimondo di Sangro, nella dignità di Gran Maestro della Massoneria Napoletana. Il Sansevero, vinte scissioni e malintesi, si dedicò con impegno alla riorganizzazione della Massoneria Napoletana, determinando una sua notevole crescita numerica e dividendo quindi i fratelli napoletani in tre Logge: la “Di Sangro” con un piedilista di oltre 280 fratelli, la “Moncada” e la “Carafa”. Superata la fase di unificazione e riorganizzazione, il Sansevero si dedicò all’approfondimento dottrinario e ritualistico, sostenendo che il cammino iniziatico, iniziato nei primi tre gradi dell’Ordine, dovesse trovare il suo perfezionamento nei gradi “scozzesi”, o Alti Gradi, nei quali si trattava della leggenda di Hiram e del Tempio, di Salomone Fu merito quindi del Principe di Sansevero, la costituzione nella Massoneria napoletana della prima Loggia Scozzese, presso la “Di Sangro”, che maggiormente si prestava alle esigenze rituali dello Scozzesismo, sia per il più alto numero di componenti che per la loro formazione esoterica. La loggia del di Sangro,usava certamente una tegolatura ebraica-egizia,ed un rituale segreto,dedicato ad una selezionata cerchia di appartenenti che verrà in futuro codificata negli ultimi gradi del Rito di Misraim,noti come la Scala di Napoli o Arcana Arcanorum,cui corrisponde la conoscenza di una pratica utile a conseguire il magistero alchemico-trasmutativo.Questo livello conduceva attraverso i misteri di Iside ed Osiride alla realizzazione di un “Corpo di Gloria”,ovvero al raggiungimento della immortalità,che fu sempre l’idea dominante di tutta l’opera del Di Sangro. Più in generale,la “Perfetta Unione” recuperò e custodì un corpus dottrinario tradizionale di ispirazione ebraico-egizio con forti influenze caldee e pitagoriche, perfettamente in linea con quella tradizione Italica,che nel Meridione d’Italia ebbe la sua maggior diffusione. Ma l’azione riformatrice del Principe di Sansevero, non poteva fermarsi a questi obiettivi. Infatti,venne diffuso nel Napoletano, fra l’altro, la traduzione del “Conte di Gabalis” del Montfaucon de Villars, contenente nozioni cabalistiche e della concezione Rosacrociana, in quell’epoca molto diffusa in Germania, nonché del “Riccio Rapito”, poema esoterico di Alessandro Pope in cui si fa riferimento a Paracelso ed agli spiriti elementari dell'Adeisidaemon del Toland. Ma il rapido diffondersi della Massoneria nel Regno di Napoli, creò notevole allarme negli ambienti ecclesiastici, tanto che già nell’autunno del 1750, iniziò con violenza una feroce campagna antimassonica a Napoli, con le prediche nelle chiese e piazze del gesuita Padre Pepe e del popolare “Padre Rocco” del quale si occupa Benedetto Croce nella sua “Vita religiosa a Napoli del settecento”. Questa situazione destò i primi allarmi anche nella Curia romana che intervenne presso il Re Carlo V°, invitandolo ad intervenire. Questo stato di allarmismo, indusse nei primi mesi del 1751 il di Sangro ad avere un colloquio con Carlo V° per rassicurarlo che nel corso del lavori Massonici “non si trama né contro la monarchia, né contro la religione.” Intanto, in conseguenza delle pressioni del clero napoletano, la situazione precipitava con la emanazione da parte del Pontefice Benedetto XII°, il 28 maggio 1751, della Bolla «Provvidae Romanorum Pontificum», con la quale confermava la scomunica emanata tredici anni prima dal suo predecessore, colpendo in maniera particolare “il segreto massonico” ed il suggello che esso riceve, sotto il vincolo del giuramento. Conseguentemente alla presa di posizione del Pontefice, il clero locale accentuò le sue pressioni su Re Carlo, perché si decidesse a deliberare misure restrittive nei confronti della Massoneria. Messo alle strette, il sovrano napoletano, il 10 luglio 1751, per la prima volta nella storia del suo Regno, emanò un editto che condannava e proibiva la Massoneria nel Regno. Nel frattempo il Principe di Sansevero aveva pubblicato nella sua tipografia, un opuscolo dal titolo «Lettera apologetica del Quipu», sotto lo pseudonimo di Esercitato , nella quale, scrivendo di sé e delle sue invenzioni, consente al lettore di farsi una ben precisa idea sui suoi orientamenti culturali e su diversi aspetti della sua personalità. In esso, mentre voleva colpire con la satira la società del suo tempo, riprendeva di fatto le nozioni di scrittura – tecnico-mnemonica – predisposta con fili di vari colori annodati in modo diverso dal “Quipu”. Sostanzialmente però, la Lettera Apologetica, affronta temi cabalistici. Questo lavoro del Principe, fu l’occasione perché gli ambienti clericali napoletani potessero scagliare con maggiore veemenza, una nuova campagna antimassonica, additandolo ai napoletani quale “rinnegatore della Sacra Scrittura e del miracolo di San Gennaro”. Colpito dai rinnovati attacchi, allo scopo di evitare all’Ordine massonico conseguenze più gravi, il Gran Maestro si fece ricevere dal Sovrano napoletano allo scopo di rinunciare pubblicamente alla dignità di Gran Maestro e chiedere di essere ricevuto, attraverso il Nunzio Apostolico, dal Pontefice, per chiarire i motivi della sua adesione alla Massoneria ed il vero significato della sua opera sul “Quipu”. Appare evidente che, con questo gesto, il Principe intendeva placare la bufera che si era scatenata nell’opinione pubblica partenopea contro la Massoneria,e d’altro canto, il chiarimento al Papa, non doveva essere considerato la ritrattazione delle sue convinzioni esoteriche,ma una ben congegnata mossa politica. Nel frattempo furono messe in circolazione, nella città di Napoli, le prime copie dell’opera “Il Conte di Gabalis” ,e purtroppo questa operazione aggravò maggiormente la campagna antimassonica scatenata nel Regno di Carlo di Borbone, annullando l’azione che il Principe di Sansevero, con la sua rinuncia alla Gran Maestranza, aveva tentato di determinare. Di fronte alla campagna antimassonica che si andava scatenando, Raimondo di Sangro, il 3 agosto 1751, dopo essersi confessato presso il sacerdote G.B. Alasia, inviò al Pontefice Benedetto XIV° una lettera con la quale, nel precisare tempi e luoghi della sua Iniziazione Massonica, precisava nel contempo che le Logge Massoniche non svolgevano alcuna azione eversiva contro la Chiesa e contro l’ordine costituito. "Compie in questo corrente mese di Luglio appunto un anno, Santissimo Padre, da che un ragguardevolissimo Cavaliere della Corte del mio Re Carlo Borbone ( col quale avea gran dimestichezza, secretamente parlandomi m'invitò ad entrare nel ruolo di coloro, chè volgarmente Liberi Muratori son detti". Il Principe racconta quindi che, dopo essere stato interrogato dal "Presidente o sia dal Maestro, siccome essi dicono, dell'Ordine", venne ammesso all'iniziazione: "e avendoci il Presidente e tutti gli altri Confratelli acconsentito, son tra loro ricevuto a' 22. di Luglio del prossimo passato anno", ovvero del 1750. Il Principe riferisce di essersi trovato "in mezzo ad onestissima Gente" e che, avendo partecipato a numerose riunioni, non si era imbattuto "in alcuna cosa viziosa, se non in molte piuttosto ridicole ed insulse, cioè in certi enigmi, sotto i quali ciascuna bagattella alla società appartenente si nasconde": e continua quindi affermando che per tale motivo si era piuttosto disgustato; tuttavia, aveva deciso di "perseverarci per qualche tempo" soprattutto perchè gli sembrava "laudabile" che uomini di diverso ceto. "posta da banda la nobiltà della nascita e la gravità degl'impieghi, doveano fra loro familiarmente conversare, e promettersi uno scambievole soccorso in caso di caderne in bisogno" e pensando inoltre che "si potesse apportare un grandissimo benefizio alla Patria coll'unire insieme gli animi de'più Potenti Cittadini e quelli de'Giureconsulti"."Trenta giorni appena dopo la mia ricezione - continua il Principe - per comune consentimento di tutti fui eletto Presidente, o per meglio dire Gran Maestro dell'Ordine nel Regno Napoletano". Per quanto riguarda la vicenda massonica del Principe, ritengo che essa si sia svolta diversamente da quanto risulta dalle dichiarazioni che egli stesso fu costretto a fare. Non è credibile che il Principe fu iniziato appena pochi mesi prima di essere eletto Gran Maestro, ma che la sua appartenenza alla Libera Muratoria debba risalire a circa un decennio prima. Secondo quanto afferma il Curioso Dilettante. La Massoneria fu introdotta nel Regno di Napoli nel 1731 dai militari austriaci, ma già nel 1728 la Gran Loggia d'Inghilterra aveva rilasciato un mandato per fondare una Loggia a Napoli. Da un manoscritto del 1804 redatto da Emanuele Palermo, apprendiamo che dopo il 1734 la Massoneria continuò ad essere presente a Napoli solo con Logge composte da forestieri, finchè, intorno al 1745, un "Piemontese ed un Francese (il Larnage), ambi di domicilio in Napoli, il primo di mestiere acquavitaro, e'l secondo negoziante di drappi e seta" non "pensarono di erigere una Loggia separata e farsene essi i Capi e Direttori, non tanto per aver l'onore di esserne chiamati i Fondatori della Loggia di Napoli, ma quanto per averne il profitto". Va però detto che verso il 1740 circolava in città una traduzione manoscritta del discorso del 21 marzo 1737 di Michel-André de Ramsay, discorso che viene considerato il punto di partenza per l'istituzione della Massoneria Scozzese, e ci sono diverse ragioni per pensare che intorno al 1740 già esistesse a Napoli una Loggia "aristocratica" orientata verso la filosofia degli Alti Gradi. di cui avrebbero fatto parte diversi esponenti dell'aristocrazia, e, forse, lo stesso Principe di Sansevero: a questa Loggia si sarebbe aggiunta, dopo il 1745, la Loggia di ispirazione "inglese" e "borghese" del Lamage. In questa fase della storia della Libera Muratoria napoletana, si inserisce la vicenda del Principe di Sansevero, il quale fornisce la versione ufficiale sulla sua esperienza massonica nella lettera scritta a Benedetto XIV e datata il I agosto 1751, Il Principe di Sansevero. infatti, su proposta dallo Zelaja, venne "di comune consenso acclamato e riconosciuto per Gran Maestro dell'Ordine", riconoscimento che gli fu confermato il 24 ottobre 1750 anche dalla Loggia del Larnage: pertanto. sotto il Gran Maestrato del Principe di Sansevero, le Logge napoletane andarono a costituire una Gran Loggia Nazionale. Sorge, a questo punto, una legittima perplessità: come è possibile che il Principe di Sansevero, per quanto prestigiosa fosse la sua figura, potesse essere eletto Gran Maestro dell'Ordine appena un mese dopo la sua ricezione? Una così rapida carriera massonica appare molto improbabile, mentre sembra ben più verosimile l'ipotesi che il Principe di Sansevero fosse stato iniziato già diverso tempo prima, e che nel 1750 abbia invece voluto imprimere una svolta decisiva alla Massoneria napoletana, riorganizzando le Logge, rafforzandola e rendendola autonoma con la costituzione della Gran Loggia Nazionale. L'idea che il Principe di Sansevero facesse parte della Libera Muratoria da prima del 1750, è stata già avanzata da più parti, e secondo Gamberini il Principe sarebbe stato iniziato nella Loggia del duca di Villeroy fra il 1736 e il 173725. Henri Theodor Tschudy riporta il testo di un'Orazione che il Principe avrebbe pronunciata nel 1745, in occasione dell'ingresso di alcuni Apprendisti nella sua Loggia. Il tono dell'orazione è tale che a tenerla non può essere stato che il Maestro Venerabile,o l’oratore della Loggia: pertanto, il Principe di Sansevero nel 1745 non solo sarebbe già stato inserito nell'Ordine, ma vi avrebbe occupato un posto di primo piano. Inoltre, in un documento massonico dell'epoca, un volumetto recante il titolo Le Costituzioni della Società dei Liberi Muratori, viene riportata la "Canzonetta Recitata in Napoli nel dì 21. Gennaio 1750. assistendo il F.. Tolvach Inglese al travaglio della Loggia della Concordia, una delle Logge del F.. Raimondo di Sangro, Principe di S.Severo, Primo Gran Maestro in Italia": apprendiamo in tal modo il titolo distintivo di una delle Logge del Principe di Sansevero, ma soprattutto troviamo la conferma che il Principe era già a capo della Massoneria napoletana il 21 gennaio 1750, cioè sei mesi prima della data del 22 luglio 1750, in cui egli stesso afferma di essere stato iniziato. In mancanza di documenti più precisi ed attendibili, la vera data dell'iniziazione massonica del Principe di Sansevero resta ancora avvolta nel mistero. Ritengo tuttavia che un'indicazione in merito sia stata fornita, in forma velata, dallo stesso Principe nella Lettera Apologetica, quando parla del suo Progetto d'una Multiplice Difesa Interna, affermando che "questo ammirabile trattato è la cosa, che con più gelosa cura custodisce l'Autore: sembra infatti di poter scorgere, nella Molteplice Difesa Interna, non solo un modello di fortificazione militare, ma anche un'allusione allo schema della Triplice Cinta simbolo dell'insegnamento iniziatico coi suoi tre gradi visti come barriere da superare per penetrare nel punto centrale, cuore del mistero e fonte dell'insegnamento. Non sembra eccessivamente azzardato ipotizzare che la data del 1741, attribuita a tale Progetto, possa essere la vera data dell'iniziazione massonica del Principe, il che sembrerebbe trovare conferma in un altro passo che precede il brano in questione, ed in cui il Principe cita un'altra sua opera sulla “vera cagione produttrice della luce". Vedere o ricevere la Luce è ciò che il neofita chiede all'atto della sua iniziazione, e non possiamo non ricordare, in proposito, la frase con cui lo stesso Principe aveva salutato alcuni Apprendisti in occasione del loro ingresso nella sua Loggia: "è giusto, infine, che vi renda partecipi della Luce che avete cercato con tanta cura." Dopo la sua rinuncia all’appartenenza all’Ordine Massonico,deluso ed amareggiato,il Principe si concentra sui lavori della sua Cappella e sulle sue amate ricerche: "abbandonando ogni altro intrapreso suo studio nello stesso anno 1751, pensò di darsi del tuffo allo studio della Fisica sperimentale come la più profittevole per l'umana società, con animo di tentar nuove sperienze, e illustrar con nuove scoverte una si famosa, e necessaria Scienza". Intraprende quindi delle nuove sperienze fisiche e fa costruire in un sotterraneo del suo palazzo una fornace, sul tipo di quelle adoperate dai vetrai "ma di una particolare costruttura", aggiungendovi diversi altri forni "a fuoco di riverbero"; poi, in un altro locale, fece installare un "Laboratorio Chimico con ogni sorta di fornelli, di Vasellami, o di ordigni per qualunque operazione". Realizza dei cristalli e delle pietre dure artificiali e riprende a fare degli esperimenti,già precedentemente tentati, sulla rigenerazione della vita dei granchi e sulla formazione del sangue dal cibo, facendo "altre belle scoperte... alcune delle quali sembrano fuori dell'ordine della Natura". Fra queste va ricordato soprattutto il cosiddetto Lume Eterno, ampiamente descritto nelle Lettere indirizzate al Cavaliere fiorentino Giovanni Giraldi ed all'Abate Nollet dell'Accademia Reale delle Scienze di Parigi. Il tema della Luce che si sprigiona dai corpi viene ulteriormente trattato nella”Dissertazione sopra una lucerna ritrovata ultimamente in Monaco”, e creduta una delle perpetue degli antichi. Se questi comportamenti del Principe di Sansevero riuscirono a placare, sia pure momentaneamente, la bufera che si era addensata sul suo capo e sulla massoneria napoletana, da parte del clero, iniziava nel contempo quelli dei Liberi Muratori, i quali videro nelle prese di posizione del loro ex Gran Maestro un tradimento all’Ordine ed al Segreto Massonico. Ritengo che, esaminando attentamente il comportamento del di Sangro alla luce delle persecuzioni che in quel periodo si condussero contro la Massoneria, non si può non apprezzare il suo saggio e prudente comportamento che evitò ai Massoni partenopei ( o perlomeno ad una ristretta cerchia di essi ),ulteriori danni e fastidi. Lo stesso comportamento di Re Carlo di Borbone fu prudente e non certamente severo. Peraltro, ripercorrendo gli eventi che si verificarono in così breve tempo, contro l’Ordine Massonico ed il suo Gran Maestro, non può non riconoscersi l’inevitabilità che il di Sangro, il quale si era trovato al centro della bufera, lasciasse la carica di Gran Maestro. Le dichiarazioni rese e le lettere inviate al Sovrano ed al Pontefice, non furono certo una rinuncia alle idee che aveva fatte sue, con piena convinzione, da uomo di cultura. Esse vennero rilasciate, per motivi contingenti, e certamente non senza rammarico. Raimondo di Sangro, in un momento particolare, della Massoneria e del regno di Napoli, convinto di aver evitato il peggio ai Liberi Muratori napoletani, con il suo comportamento, preferì ritirarsi silenziosamente, senza rinunciare alle sue idee, per dedicarsi agli studi preferiti ed alle sue ricerche . Ma dopo esserci soffermati ad esaminare il periodo storico nel quale visse ed operò, quella che fu la sua azione quale Libero Muratore e Gran Maestro della Massoneria napoletana, prima ancora di portare la nostra meditazione sulla simbologia del Tempio che egli lasciò alla posterità, soffermiamoci sia pur brevemente a considerare l’uomo e la sua azione scientifico-culturale sotto l’aspetto esoterico, nonché dei particolari studi da lui condotti e degli Ordini esoterici dei quali certamente fece parte. Alla luce di questo particolare aspetto del Raimondo di Sangro “Iniziato”, potremo di sicuro meglio comprendere i suoi comportamenti, la sua azione scientifica e culturale e la simbologia che ci ha lasciato, quale ultimo insegnamento, nel suo Tempio. Raimondo di Sangro, fu uno spirito eletto, di quelli che appaiono periodicamente, nella storia dell’umanità. Alla vita mondana, piena di piaceri e dissolutezza che il suo rango e la sua situazione economica gli offrivano, preferì la solitudine dello studio, della meditazione e della ricerca tuffandosi, con amore immenso, al servizio dell’umanità, nel cuore infinito della Sapienza, alla ricerca della Verità. Trascorre le sue giornate assorto nello studio, preso dalla meditazione, ricercando, sperimentando, fra storte e lambicchi. Fu particolarmente versato nello studio della scienza in genere, della chimica e dell’alchimia. Fra le sue tante scoperte, molte delle quali di particolare interesse esoterico, vi è la «lampada perpetua» riportata in molte opere Rosacrociane, questa dopo essere rimasta ininterrottamente accesa per un periodo di tre mesi, per un fatto puramente accidentale, si spense ed il Di Sangro volle distruggerne ogni traccia. Si salvarono solo le descrizioni che ne fece nelle lettere da lui scritte ad alcuni membri dell’Accademia delle Scienze di Parigi. Così come abbiamo prima ricordato, che Raimondo di Sangro fu il primo a costituire nella Massoneria napoletana Logge di Rito Scozzese, non può sottacersi che egli rinverdì il Rito di Misraim, riallacciandosi al centro occulto legato all’Egitto che è sempre esistito nel napoletano. Infatti, scrive Francesco Brunelli nella sua opera sul Rito di Memphis e Misraim: «Secondo Usekaf a Napoli è esistita per secoli una catena iniziatica risalente all’antico Egitto ed i gruppi esoterici che nell’andar del tempo si sono succeduti all’Eggregoro superindividuale di una corporazione di Egizi esistente a Napoli, sin dall’età imperiale e forse molto prima, nella zona attualmente denominata Via Nilo e Piazzetta Nilo. Essendosi gli Egizi assimilati nei secoli agli altri napoletani, sarebbe rimasto l’eggregore del culto egizio, adattato a Fratellanza Magico-Ermetica». È comunque evidente che le concezioni esoteriche mediterranee, che ebbero a manifestarsi attraverso la linea ermetico-egizia e quella pitagorico-cabalistica trovarono nei movimenti Rosacrociani e Massonici napoletani le loro migliori manifestazioni ed il Di Sangro secondo il Francovich “era probabilmente collegato con un gruppo di Rosa+Croce che pur dovevano esistere in Napoli”. Non si può peraltro ignorare che la tipografia del nostro Principe, secondo il Soriga, pubblicò alcuni opuscoli massonici, dei quali uno molto importante, in quanto riportava la prima elaborazione del Rito di Misraim. È proprio con il Principe di Sansevero che dobbiamo rilevare: 1° - il distaccarsi della Massoneria dall’Ortodossia Cattolica ed il suo aprirsi a ricerche esoteriche; 2° - la costituzione, fra gli uomini che gravitavano intorno al Di Sangro, di un nuovo Rito, identificato dal Soriga in quello di Misraim; 3° - l’azione educatrice evidenziatasi mediante la formazione di discepoli, fra i quali il barone Tschudy, creatore della stella fiammeggiante e di un sistema massonico impostato sullo studio dell’ermetismo e dell’alchimia, meglio noto, come Ordine dei Filosofi Incogniti. Da quanto abbiamo fin qui ricordato appare evidente, sia dalla sua azione che dagli scritti suoi o ritenuti suoi, nonché dalle opere pubblicate dalla sua tipografia, la sua grande cultura ermetico-cabalistica nonché la sua formazione Rosacrociana. Peraltro, anche nella Cappella gentilizia della sua famiglia poi divenuta «Cappella di Sansevero», esistono espliciti riferimenti cabalistici, nella disposizione delle statue simboliche, nonché precisi riferimenti ai Rosa+Croce, in varie statue, anche se con maggiore evidenza in quella della “Pudicizia” e nell’altare maggiore della Cappella, attraverso le due teste, una maschile e l’altra femminile, disposte al di sopra del bassorilievo della “Deposizione”. È fuori di ogni dubbio che Raimondo di Sangro, da vero Rosa+Croce, con la sua mente aperta ad ogni tipo di studio, cercò di leggere il Grande Libro della Natura per comprenderne il profondo significato. Le sue scoperte scientifiche e militari vollero essere un modo per avere il dominio dell’Universo. Egli da perfetto adepto dell’Ordine dei Rosa+Croce, volle penetrare i livelli profondi dell’esperienza religiosa, sollevando i sette veli del Sancta-Sanctorum della Divina Sapienza, afferrandone il segreto significato. E da quell’Iniziato che fu, seppe conservare il Segreto, pur riuscendo in attuazione alla concezione Rosacrociana a trasformare questa sua presa di coscienza della Verità, in servizio a favore dell’umanità, nell’immensa profonda simbologia che lasciò ai posteri, nella sua Cappella. Raimondo di Sangro che aveva cominciato il suo percorso iniziatico sollevando il velo nel misterioso Rito egizio di Misraim, era un alchimista che attraverso lo studio della cabala e dell’ermetismo, si era avvicinato all’Ordine Rosacrociano, divenendone un adepto, come dimostrano i suoi studi, le sue scoperte, la stessa simbologia che volle dare ai gruppi simbolici della Cappella di Sansevero. Fu uno di quelle guide dell’umanità che solo periodicamente compaiono su questa terra, per essere di esempio, con l’azione e con il servizio che all’umanità stessa rendono. Raimondo di Sangro, che pur essendo vissuto nell’Era dei Pesci, era nato sotto il segno astrologico dell’Acquario, seppe essere, con l’azione di tutta la sua vita operosa, uno spirito puro proiettato nell’Era Nuova, ad indicare ai suoi simili, come facendo fiorire la rosa sulla sua Croce, dovrà essere l’Uomo dalla mente concreta dell’Era dell’Acquario. Il Principe voleva a tutti i costi essere padrone di quella sottile linea di confine che passa tra la vita e la morte,ossia la soluzione della immortalità terrena. Si racconta, che uccise sette cardinali e che con le loro ossa realizzò sette seggiole, ricoprendone il fondo con la loro pelle. Si narra che,quando sentì avvicinarsi la morte, provvide ad organizzare la sua resurrezione. L’ambizioso progetto era quello di creare un luogo magico,dove chi avesse la conoscenza dell'Arte Regia (l'Alchimia) e delle regole della Massoneria, avrebbe poi decifrato il messaggio nascosto dal Principe nelle sue opere. Un messaggio tra il sacro e profano, tra mitologia e teologia, tra il naturale ed il sovrannaturale, il tutto coronato dalla sua ossessione verso il simbolismo e verso quella sapienza che deriva dagli antichi Egizi. Non più scrivendolo nei libri ma criptandolo nelle opere raccolte nella sua,la cappella costruita su un luogo dove anticamente vi era un tempio dedicato alla dea Iside. Un messaggio non ancora svelato ma, come le sue opere, semplicemente "velato" da un simbolismo allegorico. Quel "velo" sotto il quale s'intravede la vera realtà dell'esistenza umana. Solo l'occhio attento di colui che ha intrapreso il cammino dell'iniziato riuscirà a carpirne il vero significato. Un significato che non ha più nulla di arcano se la conoscenza ha donato le chiavi. In tal modo si spiega anche l'uccisione dei sette cardinali e sette è il numero dell'Illuminazione e corrisponde alle sette chiese dell'Apocalisse o ai "Sette Saggi" dei libri della fondazione egizia, iscritti sulle pareti del tempio di Horus a Edfu. Si tratta, della forza del serpente che si snoda lungo la colonna vertebrale dell'uomo e che, attivando tutti i sette centri energetici, dona illuminazione e vita eterna. Un simbolismo che si ritrova nel caduceo del dio Mercurio, presente all'interno della cappella nelle mani della statua della "Sincerità".Il simbolismo che impiegò il de Sangro, probabilmente volontariamente "mitizzato" dai suoi "discepoli", è riscontrabile proprio sull’altare della cappella, dove è visibile un volto dorato di chiara ispirazione sindonica. Gli alchimisti, eredi di una tradizione antica, consideravano la Sindone quale"veste del corpo di gloria" del risorto, cioè il raggiungimento della Pietra Filosofale. Questo spiega anche perché il Principe volle nella sua cappella la statua di un Cristo "velato" dalla Sindone in quanto essa era simbolo di quell’immortalità dalla quale era tanto ossessionato. Il principe se ne andava in un giorno di primavera. Il 22 marzo 1771, Sessantun anni appena compiuti. Un uomo relativamente ancora giovane. Che da tempo, però, avvertiva dolori, soffriva. Aspettava, da un giorno all'altro, che la sua compagna di sempre, la morte, lo chiamasse a sé per l'ultima e definitiva volta, E serenamente era spirato, in pace con se stesso e con la Chiesa come attesta l'atto di morte: "A' 22 Marzo 1771. L'eccellentissimo Signor don Raimondo de' Sangro, marito della eccellentissima signora donna Carlotta Caietani d'Aragona, Principe di Sansevero, abitante nel proprio palazzo, ricevuti i Santissimi Sacramenti, morì in Comunione di Santa Chiesa, a di detto, e fu seppellito nella propria Cappella pubblica; era dell’età 62 anni circa" . Destino curioso. Morto lui, si perde ogni traccia delle sue mirabolanti invenzioni. Ne resta una descrizione non sempre chiara, negli scritti di suo pugno o da lui ispirati, nulla più. Volatili, pura intenzione, restano una serie di opere spesso annunciate mai tradotte nero su bianco; I funerali furono solenni, fastosi, come si addiceva a un nobile del suo rango. Tra velluti, ori, argenti, la pompa, e anche questo era da mettere in conto, prese il sopravvento sulla tristezza, che solo si poteva leggere nei tratti tirati di Carlotta Gaetani e nello sguardo compunto di qualche amico. La primavera aveva fatto il suo ingresso proprio il giorno precedente. Le cronache raccontano che, quel 22 marzo, il sole splendeva alto sul golfo di Napoli.
E.S. 2006