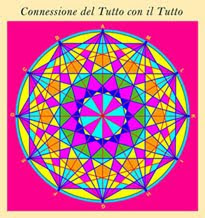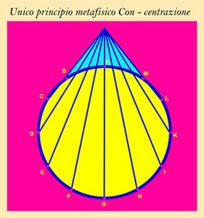La Libera Muratoria italiana, nel 18° secolo, trae ispirazione da due diversi indirizzi: quello “inglese” e quello, operante in Francia, detto “scozzese”. La Massoneria Inglese, caratterizzata da tre gradi, è razionalista e liberale, ha una matrice originaria protestante, si presenta come un sistema morale separato dal credo religioso. Osteggia i vecchi ordinamenti politici assolutisti e favorisce Ia formazione di stati moderni sul modello delle monarchie illuminate o di quelle costituzionali. I propri adepti sono reclutati tra professionisti, intellettuali borghesi, proprietari e nobili imborghesiti. Essa nasce dalla antica gilda dei muratori e dalle compagnie di livrea, è costituita in Gran Loggia nel 1717 da alcune logge londinesi ed è istituita, in modo organico, nel 1723, dal dottor James Anderson che concepisce e scrive la Costituzione ed i Regolamenti.
Nel 1700, incontriamo, per la prima volta in Francia, una Libera Muratoria, soprannominata “scozzese”, non certo per provenienza geografica, ma perché concepita e praticata da gruppi di cattolici-stuardisti i quali avevano addizionati ai tre gradi originari una serie di cosiddetti “alti gradi”.
Nei rituali di tali gradi, erano presenti elementi di esoterismo e di occultismo, suggestioni ermetiche, alchimistiche, teosofiche e teurgiche. Queste suggestioni non mirano a contrastare lo spirito cristiano-cattolico introdotto nei rituali dagli stuardisti ed adottato da una certa massoneria cavalleresca creata da un tal cavaliere Ramsey, anzi si fondono con esso dando origine ad un misticismo esoterico di una tinta del tutto particolare. Chi veniva insignito degli “alti gradi” pretendeva di rappresentare l’aristocrazia della massoneria e di possedere conoscenze esclusive. Le riunioni avevano luogo in logge particolari chiamati “Capitoli”, “Consigli” o “Concistori” ed ivi venivano officiate cerimonie molto complesse in atmosfere mistiche e misteriose. Il patriziato settecentesco amò organizzare le proprie irrequietezze spirituali in questi complessi sistemi, ricchi di simboli e di allegorie, ispirati dal cristianesimo esoterico dei Rosacroce e dei Templari, densi di fasto cerimoniale, spesso “sinonimi di indigenza intellettuale”, ritenuti veicoli di esclusive conoscenze e di poteri spirituali annunciati, ma mai rivelati.
Questi due orientamenti saranno determinanti per la storia e lo sviluppo della muratoria partenopea durante tutto questo secolo: ora intrecciandosi, ora scontrandosi, ora fondendosi, determineranno tendenze culturali, aggregazioni sociali, scelte politiche. In Napoli, al tempo del conte di Harrach, viceré di Carlo VI d’Austria dal 1728 al 1733, esistevano Logge di militari austriaci. Queste Logge erano chiamate “Feldiogen”, logge di campo, prive di numero e di titolo, non stilavano verbali delle loro riunioni. Si può supporre che «ciascuna di esse riunisse fratelli di una stessa arma o nazionalità, o fatto non raro a quei tempi, di una medesima confessione cristiana». Michelangelo D’Ayala riferisce che nella biblioteca del principe di Belmonte era conservato un manoscritto anonimo, nel quale si leggeva: «I Liberi Muratori sino del tempo di Carlo III si erano introdotti in Napoli, ma si mantenevano in maniera nascosta e ristretti tra soli forestieri, che sotto tutt’altro pretesto si radunavano. Da principio un piemontese di mestiere acquavitaro ed un francese, mercante di seta furono ammessi. Costoro conosciuti a fondo i principi della società, pensarono di erigere una Loggia separata: infatti, l’anno 1745 eseguirono un tale immaginato disegno».
G. De Blasis scopri nel 1905 un documento, presso l’Archivio della Società napoletana di storia patria che confermava tale circostanza. Questo può essere considerato il più importante documento sulle origini della muratoria in Napoli e, forse, il più antico in lingua italiana. In esso si legge: «Allorché l’Armi Cesaree presero il possesso del Regno di Napoli (si riferisce al 1707) si introdussero in quella vasta città le logge dei Liberi Muratori, i quali celebrarono i loro misteri con cautela. Negli anni 1749, 50, 51 vi si stabilirono più logge e ne furono maestri reggenti il primo Lornage.... L’autore del documento citato dal De Blasiis è anonimo e si firma: “Curioso dilettante”. Il titolo per intero è: «Istituto ossia Ordine dè Liberi Muratori. Traduzione germana dall’idioma francese nell’italiano fatta che un Curioso Dilettante di novità, con i catechismi, Capitoli, Tavole di Disegni ed altre Cerimonie e Funzioni solite fassi nelle Università dè Muratori, con tutti i Segni e le parole antiche, e recentemente riformate con dissertazione Apologetica, formule di Patenti, ed alcuni discorsi soliti recitarsi nelle Logge, dai rispettivi oratori in tutte le ricezioni dei fratelli, ed in altre diverse occasioni, con il Ragguaglio dello Stabilimento dè Liberi Muratori nel Regno di Napoli 1749, 1753, 1765».
Dunque, mentre il Curioso Dilettante data la nascita della prima Loggia nel 1749, l’anonimo del manoscritte del Principe di Belmonte parla del 1745, tutti e due però concordano che un “francese” fu il primo Maestro Venerabile, Louis Lornage, così si chiamava “il francese” che era lionese, di mestiere “mercante di sete” come sostengono documenti del 1776, di religione calvinista. Dal manoscritto del Curioso Dilettante apprendiamo che la Loggia Lornage era formata da borghesi, qualche militare e molti inglesi e scozzesi. Pertanto, riteniamo che lavorasse secondo i rituali inglesi dei tre gradi simbolici ed avesse essenzialmente un carattere filantropico. Lornage iniziò nella sua Loggia diversi militari tra i quali l’Alfiere Zelaia, del Reggimento reale di Napoli, un sacerdote don Filippo Pattoni Nazari di Savigliano, qualche nobile, Don Domenico Vernier, aiutante di Camera di S.M. I militari, però, mal sopportavano d’essere rappresentati da un “borghesuccio” come Lornage, anche perché ritenevano «fosse necessario ammettervi persone di nobile e cospicuo casato che all’occorrenza proteggessero la loggia dalle opposizione governative». Non poteva certo, un piccolo borghese, un “bottegaio”, ricevere e tenere “sotto il proprio maglietto” nobili e militari di alto grado. Probabilmente fu questo il motivo che creò disarmonia nella Loggia; e nell’Aprile del 1750, Lornage fu “deposto” o come dice ancora il Curioso Dilettante, fu “escluso”. Ma sappiamo che questi due termini, “deposto” ed “escluso”, non hanno senso nella Libera Muratoria, quindi pensiamo che Lornage fu indotto a dimettersi ed al suo posto venne, unanimemente, eletto l’Alfiere Zelajia (o Zelaia). Questa a me sembra l’interpretazione pin verosimile dei fatti, anche perché Lornage non lascia subito la Loggia, ma come riferisce il Curioso Dilettante, «nel mese di Luglio dell’istesso anno 1750 su alcune differenze si disunì La Loggia Zelajia. I Fratelli Pattoni, Ocham e Carreras, abbandonarono la Loggia Zelajia ed insieme con Voaijcr, Lornagc e Fromentin Forestier ne fondarono un’altra alla quale presiede nuovamente Lornage». Questa Loggia si arricchì di nuovi fratelli, ma rimase sempre una Loggia della piccola borghesia. Invece, alla Loggia di Zelajia, che si riuniva nel palazzo del Marchese Aloise al Ponte di Chiaia, aderirono diversi militari ed alcuni nobili. Il primo ad essere ricevuto fu Gennaro Carafa, principe di Roccella, presentato da Don Domenico Venier, aiutante di Camera di Sua Maestà. «Indi furono ricevuti il Principe di S. Severo cd il Principe di Calvarusso, e molti altri». È importante tentare una interpretazione del contrasto tra Zelajia e Lornage, poiché aldilà di quello che può sembrare una bega di Loggia dettata da piccoli ambizioni, esiste un diverso modo di concepire la Libera Muratoria. A tale proposito Francovich scrive: «Ma questo dissidio tra Zelajia e Lornage, non è tanto un dissidio tra persone ambiziose, desiderose entrambe di primeggiare; si tratta evidentemente di un contrasto fondato sulla diversa provenienza sociale, che a sua volta provocava una diversa valutazione della Libera Muratoria.
Sembra chiaro che lo Zelajia, amico di principi e nobile lui stesso, volesse innestare alla massoneria inglese, dai tre gradi simbolici e dall’ideologia liberali la riforma scozzese che meglio corrispondeva alle ambizioni e al gusto degli aristocratici napoletani i quali da allora assumono la direzione della libera muratoria partenopea. Non solo, ma il groviglio degli alti gradi meglio serviva a celare gli interessi esoterici di alcuni nobili cultori della magia». Ma siamo sicuri che nella massoneria napoletana esistessero gli alti gradi? La risposta è affermativa. Infatti, Renato Soriga sostiene di avere trovato nell’Archivio Vaticano una parte del rituale per il grado di Maestro Scozzese. Il rituale è di quel periodo e fu stampato clandestinamente nella tipografia del Principe di San Severo. Inoltre, risulta che dopo lo scioglimento delle Logge nel 1751 per la scomunica papale, Carlo III abbia inviato al pontefice certi documenti dal Principe di San Severo. Questi manoscritti contenevano “la traduzione francese delle Costituzioni delle Logge d’Inghilterra, costituzioni qui (cioè a Napoli) capitate, ma non per ancora accettate” e gli Statuti di tre alti gradi: Maestro Scozzese, Eletto e della Sublime filosofia.
Ma chi aveva importato a Napoli gli alti gradi e da dove? «Abbiamo visto come lo scozzesismo nascesse e si affermasse, intorno agli anni ‘40, in Francia, dove una società aristocratica e fortemente gerarchizzata aveva anteposto il mito della cavalleria cristiana all’egualitarismo razionalista e deista del rito anglicano». Una delle prime Logge francese fu fondata da John Coustos, intagliatore di pietra, calvinista, famoso nella storia della Libera Muratoria perché, nel 1743, venne processato a Lisbona dall’Inquisizione, con l’accusa di svolgere proselitismo massonico, torturato e condannato al remo per quattro anni sulle navi portoghesi. Fu messo in libertà subito per l’intervento diplomatico dal governo inglese e si stabilì in Inghilterra. La Loggia Custos era una Loggia di tradizione inglese della quale faceva parte una certa nobiltà francese.
Quando nel 1747 Coustos lascia la Francia, gli succede come Venerabile Louis François Anne de Neafville, duca di Villeroy, parì di Francia, favorito di Luigi XV. La Loggia Coustos diventa la Loggia Villeroy e dai verbali, conservati alla Biblioteca Nazionale di Parigi apprendiamo che sono membri di questa Loggia 27 francesi e 41 stranieri. «Con il mutare del Venerabile, non è più la Loggia del borghese e protestante John Coustos, ma diventa ora la Loggia del duca di Villeroy; e questo cambiamento da una direzione borghese a una aristocratica, comporta l’abbandono della massoneria hannoveriana e l’adozione degli alti gradi». Scorrendo l’elenco dei fratelli, ci rendiamo conto che questa non è una semplice Loggia, ma una Loggia madre dalla quale Ia massoneria degli alti gradi si propaga per tutta l’Europa. Tra i fratelli stranieri c’è il barone Scheffer, fondatore dell’Ordine in Svezia; il principe Lumbomirski, uno dei fondatori della Loggia “I tre fratelli” di Varsavia; il principe Nariskin, fondatore della Loggia “Apollon” a Pietroburgo; Johann Daniel Kraft, fondatore della Loggia di Amburgo; ed anche il principe Gennaro Carafa della Roccella. È probabile, quindi, che sia stato Carafa a dare questo nuovo indirizzo anche alla Massoneria Partenopea. Tornando, adesso, alle vicende delle Logge napoletane, apprendiamo dal Curioso Dilettante che il principe di San Severo compie una fulminea e sfolgorante carriera poiché viene, quasi subito, proclamato dalla Loggia Zelajia, Gran Maestro dell’Ordine. «Ma avendo la Loggia Zelajia proclamato per Gran Maestro dell’Ordine, e in tale qualità riconosciuto il Principe di San Severo, ed essendo da questo ricercato Lornage e la sua Loggia a riconoscerlo per tale, dopo vane deputazioni e dibattimenti, sotto il 24 di Ottobre dell’istesso anno 1750 fu riconosciuto anche da questi per Gran Maestro interinalmente, però, sino al 24 Giugno 1751». Apprendiamo, altresì, che sempre quel giorno, cioè il 24 Ottobre 1750, la Loggia Lornage rimase incorporata in quella del Gran Maestro e che egli “nelle debite forme, sedendo in trono di re Salomone” creò la Loggia di Guglielmo Moncada, principe di Calvaruso. Dall’elenco degli affiliati si può dedurre che questa Loggia pur essendo presieduta da un principe aveva un carattere borghese e seguiva probabilmente la tradizione inglese. Era Primo Sorvegliante Lornage e Secondo Sorvegliante Fromentin, due calvinisti. Nella Loggia vi erano negozianti, militari, cattolici e protestanti, napoletani e stranieri. Sedevano tra le colonne ben tre ecclesiastici e come aggregato anche l’ambasciatore di Danimarca. Nel Febbraio del 1751, il Gran Maestro Di Sangro diede una Patente per aprire una Loggia al barone Henri Teodor Tschudi, cadetto nel reggimento svizzero. La Loggia si riuniva in casa del Maresciallo Leonardo Tschudi, zio del barone ed anche lui massone. II barone Tschudi diventerà una personalità nel mondo massonico del settecento poiché fonderà un proprio sistema massonico occultistico, chiamato la “stella fiammeggiante”, con propri simboli e rituali piuttosto complessi, ispirati all’ermetismo ed all’alchimia. Teodor Tschudi era un massone spiritualista, egli mirava alla rigenerazione morale dell’uomo, all’attuazione della “grande opera” degli alchimisti mistici. Probabilmente aveva avuto uno scambio di informazioni con il Principe Di Sangro attento studioso e sperimentatore di alchimia. Infine, anche il principe Gaetano Carafa della Roccella fu abilitato, con patente rilasciata dal Gran Maestro San Severo, ad aprire una loggia. In questo periodo «la massoneria era diffusissima a Napoli e, pur avendo fatto proseliti nell’alta nobiltà del Regno e negli ambienti di corte, essa non era venuta meno alla prerogativa di mescolare ceti diversi, affiancando nelle logge l’ufficialetto al maresciallo, il mercante al principe di sangue. Il gusto del mistero ed il culto della magia si confondevano con la mondanità e con la possibilità di entrare in dimestichezza con persone altolocate». Ma chi era San Severo? Chi lo sosteneva? Perché dopo una fulminea ascesa esce di scena in modo rovinoso per l’Ordine? Raimondo Maria de Sangro, Marchese di Castronovo, settimo Principe di San Severo, pari di Spagna era uomo di eccezionale fascino ed autorità. Antonio Genovesi nell’autobiografia cosi lo descrive: «È di corta statura, di gran capo, di bello e giovanile aspetto; filosofo di spirito, molto dedito alle meccaniche; di amabilissimo e dolcissimo costume; studioso e ritirato; amante le conversazioni di uomini di lettere. Se egli non avesse il difetto di avere troppa fantasia, per cui è portato a vedere cose poco verosimili, potrebbe passare per uno dei perfetti filosofi. Per molti versi egli può essere considerato l’incarnazione dell’estetica del suo tempo; un uomo barocco, nato per stupire: Barocco il teatro che ad ogni occasione fa scorrere sotto gli occhi dei suoi contemporanei, barocca si deve considerare la sua passione per la pirotecnica, per i molti giochi, le fantasmagoriche illusioni che permette di improvvisare; con l’aggiunta di una evidente inclinazione all’umorismo e all’ironia. Un pò meno all’autoironia; ma si sa, i nobili hanno spesso un concetto molto alto delle loro persone per riderci sopra». II Principe era un uomo colto, molto colto in confronto alla media della nobiltà napoletana. Aveva studiato a Roma in un Collegio dei Gesuiti. Dal 1743 al 1746, aveva servito nell’esercito ispano-napoletano con il titolo di Colonnello della provincia di Capitanata, partecipando alle campagne militari della guerra di successione austriaca e distinguendosi nella battaglia di Velletri. Era un leale suddito di Carlo III, verso il quale nutriva scotimenti di sincera e devota amicizia, sebbene odiasse la corte e particolarmente il ministro Tanucci. Nei confronti del Papa nutriva una filiale affezione, ma disprezzava il clero e la curia. Ma il volgo patrizio e plebeo considerava il principe «nu tipo curiusu assai». Nacque così «la singolare leggenda, alimentata da monaci e da malevoli, non del tutto spenta ancora oggi, che egli fosse un mago o uno stregone». In verità, il principe era solo un alchimista, un empirico sperimentatore. Aveva impiantato un laboratorio nel suo palazzo al Largo Del Real Monastero di San Domenico. «Chi si fosse trovato a passare, nel cuore della notte, nei dintorni di Palazzo Sansevero, in quel largo finalmente libero da tutti gli ingombri e le cianfrusaglie del giorno – non libero però dall’immondizia, stabilmente inserita nel paesaggio - sarebbe stato costretto a pensare l’esatto contrario». «Fiamme vaganti, luci infernali guizzavano dietro gli enormi finestroni che danno dal pianoterra, nel vico San Severo scomparivano le fiamme, si rifaceva il buio ed ecco rumori sordi e prolungati suonavano là dentro . Era di là che il rumore partiva: lì, inserrato coi suoi aiutanti, il principe componeva meravigliose misture, cuoceva in muffoli divampanti - emulo di quell’Elettore di Sassonia di cui Carlo III aveva sposato la docile figliola - porcellane squisite e terraglia d’ogni sorta». Il popolino dei bassi vicini era terrorizzato e mormorava a bassa voce: «0 principe è ‘nu diavolo’ ». Probabilmente il Principe era collegato ad un gruppo di Rosacroce esistente a Napoli, ma al tempo stesso era uno studioso di Sesto Empirico e di Bayle. Come se non bastasse tutto questo, il Di Sangro aveva sistemato nel suo palazzo una stamperia dalla quale uscivano opere tutt’altro che canoniche, come il proibitissimo libro dell’abate Montfaucon de Villars dal titolo: “Il conte di Cabali, ovvero ragionamento sulle scienze segrete”, o ancora un altro famoso testo di magia: “L’Adcisidemon sive titus livius a superstitione vindicortus”, pubblicato in gran segreto, falsificando luogo e data, e infine la sua opera: “Lettera apologetica dell’Esercitato Accademico della Crusca” contenente la difesa del libro intitolato: “Lettere di una peruviana per rispetto della supposizione dei Quipu.” Quest’ultima opera venne definita dal prete salernitano Innocenzo Molinari, una continua cabala e una sentina di eresie e di empietà, dove si negava la Genesi, ed il miracolo di San Gennaro e se non bastava si prendeva pure la difesa della setta massonica. Sorse una pubblicistica polemica e calunniosa nei confronti del Principe che gli fruttò severi rimproveri da parte delle autorità ecclesiastiche e la messa al bando dell’opera. «Nè va dimenticato che il Di Sangro è anche Il fondatore del più importante monumento d’arte barocca esistente a Napoli: la Cappella San Severo in cui non solo si manifesta la volontà di stupire, di scoprire e di ammaestrare del committente, ma anche il bisogno di esprimere con complesso Simbolismo il senso segreto di un mondo arcano. Penso infatti che le decorazioni che vi fece apporre, indicando agli scultori i temi da svolgere, le lapidi che egli stesso dettava, abbiano nel loro simbolismo, finora mai o mal spiegato, un significato massonico. Massone infatti era - oltre che amico del principe - l’artefice principale della Cappella, lo scultore Antonio Corradini, che fece parte in quegli anni di una loggia napoletana». L’accoglienza di Raimondo San Severo nella Loggia Zelaija, fu sollecitata dal principe Gaetano Carafa della Roccella, membro della Loggia Villeroy di Parigi, con il segreto intento di dare una svolta scozzese alla Muratoria Partenopea, fondata da borghesi protestanti sul modello trigradale inglese. Forse il padre putativo della Massoneria Napoletana Luis Lornage, mercante, calvinista, il suo amico Fromentin, il sacerdote Pattoni e pochi altri fratelli esperti di cose massoniche intuirono il piano del Carafa e si opposero, pur sapendo di combattere una battaglia perduta poiché molti erano i fratelli impazienti ed orgogliosi di avere tra le colonne la nobiltà ed i militari di alto rango. Così il gruppo Lornage batté ritirata e fondò un’altra loggia, conservando la ritualità inglese. Il disegno dello scozzese Carafa si compì con l’elezione del Principe Raimondo Di Sangro a Gran Maestro. Egli si affrettò a ricercare Lornage e la sua Loggia “a riconoscerlo per tale” e dopo vane “deputazioni e dibattimenti sotto il 24 ottobre dello stesso anno 1750 fu riconosciuto”, ed il povero Lornage venne giubilato insieme al suo gruppo. II Gran Maestro aveva dato un forte impulso alla Muratoria, il reclutamento tra i nobili ed i militari di alto grado andava benissimo, le logge avevano mutato fisionomia, tra le colonne non c’erano solo borghesucci ed ufficialetti, ma il fior fiore della nobiltà, dei giureconsulti, della milizia borbonica e dei borghesi. Il Principe immaginava nuovi e grandiosi scenari socio-politici: «Come Gran Maestro, capo della massoneria del regno, forte del disegno che la setta perseguiva, avrebbe tentato di accentuare la pressione sul potere cui era più vicino, sul sovrano, fino ad ottenere che diventasse lui il Capo della muratoria napoletana. Con Carlo a fargli da scudo, nulla e nessuno lo avrebbe fermato». Fantasticava una utopistica concertazione «tra la nobiltà ed i giureconsulti, tra il primato ereditario degli aristocratici le loro sacrosante prerogative e le pretese crescenti dei borghesi, le loro legittime ambizioni». Tutto ciò doveva avvenire con il consenso del Re, sotto la spinta della Libera Muratoria per il beneficio di tutti. Ma il Principe come diceva il suo amico Genovesi - aveva troppa fantasia, per cui era portato a vedere cose poco verosimili; infatti dopo pochi mesi le illusioni del Principe si infransero rovinosamente contro il becero e reazionario immobilismo del Re, sostenuto dal ministro Tanucci e contro la tenace opposizione di un clero forte, ricco ed avido, che rivendicava ed imponeva le proprie prerogative e che si sentiva tremendamente minacciato dalla scellerata combriccola dei massoni. Ma tutt’Italia e non solo il Regno di Napoli, ed anche la Francia e qui e là tutta l’Europa era un rigoglio di Logge, e come se non bastasse, circolavano inesistenti dicerie secondo le quali i re, i vescovi e i cardinali, oltre al medesimo Pontefice fossero membri della diabolica congrega, anzi si diceva che fosse imminente la revoca della scomunica lanciata tredici anni prima da Clemente XII. A metà di gennaio del ‘51 il Papa chiese all’ambasciatore di Carlo III di comunicare al suo sovrano che «Napoli era già appestata dalla setta dei Liberi Muratori e che la peste era già penetrata fisica- mente fra non pochi personaggi della Corte». L’ambasciatore riferì e gli fu risposto che il Re sapeva di tali logge e che era disposto a prendere segrete ed adeguate misure per sradicare il nascente male, non solo evitando che avvenissero riunioni, ma soprattutto intervenendo per stroncare il proselitismo. Mentre era in corso questa corrispondenza frati, preti, confessori e, specialmente, il gesuita Francesco Maria Pepe misero in agitazione il popolo, i lazzeri, tanto che a Napoli «vi fu un vero movimento popolare contro la setta, la quale venne incolpata perfino del mancato miracolo di San Gennaro, in quell’anno 1751». Naturalmente il Principe Raimondo Di Sangro fu il bersaglio prediletto dei preti, del volgo e degli stessi nobili, sobillati dal Ministro Tanucci che lo odiava e lo disprezzava. Il 28 maggio del 1751 il Pontefice, ruppe gli indugi, ed emanò la bolla Provides Romanorum Pontifcum, con la quale confermò la scomunica lanciata da Clemente XII spiegando i motivi che l’avevano ispirata - confirmamus, roboramus et innovamus - aggiungendo dure parole contro i calunniatori - contra obloquentes, quo facilius possemus mendacibus calumniis fomentum… Inoltre, Benedetto XIV condannò lo spirito di tolleranza massonico che permettcva, nelle logge, la promiscua convivenza tra cattolici e protestanti e perfino ebrei. Biasimò il segreto massonico ed il fatto che fosse sancito con un giuramento, ed, infine, richiamandosi alle leggi civili ed al diritto romano: ne societates et conventus sine Principis auctoritate inire et habere possent, sottolineava l’argomento, tanto caro alla pubblicistica antimassonica, che il sorgere delle Logge rappresentava un pericolo, non solo per la religione cattolica ma anche per lo Stato. Per il Gran Maestro Di Sangro fu un brutto colpo, i suoi sogni svanivano, la Chiesa aveva condannato duramente la fratellanza, adesso bisognava evitare che anche il Sovrano prendesse provvedimenti, «Carlo era geloso della propria autonomia, se si abbandonava nelle manifestazioni esteriori di ossequio, in realtà conduceva uno strano braccio di ferro con la Santa Sede». Di Sangro, dopo avere a lungo riflettuto, decise di fare Ia prima mossa, uscì allo scoperto e chiese udienza a re Carlo: egli era il Gran Maestro dei Liberi Muratori, ma era anche un principe, un Grande di Spagna, un valoroso militare che aveva messo la sua vita a servizio della corona e soprattutto un fedele e devoto suddito, sinceramente amico del sovrano. Avrebbe usato le sue capacità diplomatiche, i discorsi più appropriati e convenienti per far comprendere al sovrano che la Libera Muratoria non era la peste e men che mai un pericolo per lo Stato. Questo era l’unico modo - secondo il Principe - per limitare i danni personali e salvare l’Istituzione Massonica e partenopea. Invece, il colloquio fu penoso. Il Principe si destreggiò con cautela, «riuscì a non rivelare al Sovrano i segreti fondamentali della fratellanza... si impegnò a minimizzare tutto, a far apparire quella storia una sceneggiata senza senso, ad assicurare il Sovrano che la Massoneria non era in alcun modo nemica della religione, meno che mai del potere reale. Ebbe un tuffo al cuore quando, quasi senza accorgersene, incalzato dalle domande, sentì la sua voce che elencava gli statuti delle Logge, e uno dopo l’altro prendeva a tirar fuori anche i nomi degli associati. Sarà stato anche uno spirito diabolico ma certo il Principe non mancava di ingenuità. Si era convinto, infatti, che quel colloquio sarebbe bastato a fugare i dubbi ed i sospetti del sovrano. Si sbagliava il Principe perché il 2 luglio del 1751, Carlo III pubblicò un durissimo Editto che metteva fuori legge la Società dei Liberi Muratori. Quando venne a conoscenza della prammatica reale, il Principe di San Severo fu costernato e pensò di tirarsi fuori dai futuri impicci sottomettendosi alla Chiesa. Fece una piena e completa confessione al sacerdote Giovan Battista Alasia, esternando la sua contrizione e rinunciando “in perpetuo” all’appartenenza alla Libera Muratoria e ricevendo, in cambio, “l’assoluzione dalle censure”. Ma Di Sangro non era uomo di mezze misure ed il 1 Agosto 1751 decise di inviare una epistola, in latino al Papa: fece l’apologia di se stesso, mise in berlina l’Istituzione Massonica e si dimostrò pentito. Il Papa gli rispose, non direttamente, inviandogli l’apostolica benedizione. Sta di fatto che cosi’operando il Principe tradi’ il segreto massonico e - come annota il Curioso Dilettante - «non più Gran Maestro dell’Ordine ma come fratello spergiuro e ribelle... [fu] proscritto da tutta la Società, e di tal proscrizione ne restarono avvisate tutte le Logge sparse per l’Universo mondo». Prima di promulgare l’editto, re Carlo aveva meditato a lungo. Egli era ben deciso a colpire la Massoneria e quindi ad accogliere ed assecondare i disegni della Chiesa cattolica, ma nello stesso tempo voleva evitare qualsiasi danno o accanimento nei confronti dei nobili e dei militari che avevano aderito alla società. Il 17 giugno del 1751, il Sovrano rispondendo ad una lettera del Pontefice che gi trasmetteva in via riservata la bolla di scomunica, gli inviò la minuta dell’editto che intendeva promulgare chiedendogli opportuni suggerimenti. Il Papa rispose sottolineando la necessaria alleanza tra altare e trono per tenere testa ai settari massoni, «e poiché nella minuta dell’editto contro la Libera Muratoria napoletana si accennava ad un precedente editto del 1746 con il quale Carlo III, allora sotto l’influenza dei suggerimenti giannoniani, toglieva ai vescovi autorità che avessero dal Papa in materia civile, costui, che male aveva digerito siffatta affermazione, consigliava la soppressione di quel passo e la sua sostituzione con un generico richiamo allo ius Regio, onde evitare che la rievocazione di passati contrasti potesse avvantaggiare i Liberi Muratori.
Il monarca annunciava, nel proclama, che: «in qualunque ben regolato Stato non vi è male che più contraddica e distrugga i princìpi della intrinseca sua costituzione, quando la perniciosa libertà che si arrogassero i cittadini di potere a loro capriccio formare riunioni e stringersi in società». Fatta questa premessa, il sovrano constatava che l’unione dei Liberi Muratori «quantunque dappertutto sia stata rigorosamente bandita ha insidiosamente penetrato sin’ anche nei nostri domini; quindi per ovviare ad un male sì grande e durevole di una società troppo sospetta incoraggianti Se Filippo [il primogenito] è idiota, Ferdinando non è una gran testa». Ad ottobre, Carlo III lasciò Napoli per Madrid ed abdicò in favore del minore Ferdinando IV. Egli, prima di partire per la Spagna, affidò la reggenza al ministro Bernardo Tanucci in modo da tenere saldamente in pugno anche la politica del Regno partenopeo. Con la partenza del Re iniziò la ripresa massonica anche perché Tanucci, sebbene non nutrisse simpatia per la “fratellanza”, lasciava ampi margini d’azione considerando la Massoneria una moda d’oltralpe, forse pericolosa per la Chiesa cattolica, ma non certo per lo Stato, valutando, anche, che molti aristocratici militavano nella setta. Sappiamo con certezza che nel 1763 la Gran Loggia d’Olanda rilasciò una patente alla Loggia “Gli Zelanti” di Napoli e che nel medesimo periodo la Gran Loggia d’Inghilterra, mentre era Gran Maestro Lord Blancy, nominò un Provincial Grand Mastet for Italy nella persona di Nicola Manuzzi napoletano. Nel 1768 la medesima Gran Loggia riconobbe la “Perfect Union Lodge” assegnandogli il n° 433 e nel 1769 la “Well Chosen Lodge” con il n° 444, della quale era Maestro Venerabile S. A. Francesco d’Aquino, Principe di Caramanico. Intanto, sempre nel 1763, una “Madre Loggia Scozzese” di Marsiglia concesse una patente alla Loggia palermitana “San Giovanni di Scozia” e nel 1765 la medesima Loggia ottenne “la suprema facoltà di costituire Logge nell’Oriente delle due Sicilie”. Nel 1767 la bella Maria Carolina, figlia di Maria Teresa d’Austria e di Francesco I di Lorena, sposa Ferdinando IV di Borbone. Il matrimonio serviva a legare, gradualmente, alla politica austriaca il Regno di Napoli, affrancando Ferdinando IV dall’influenza del Sovrano spagnolo che continuava, da lontano, a governare tramite l’astuto ministro Tanucci. L’arrivo della Regina a Napoli coincise con una nuova primavera massonica poiché «nelle logge si raccoglieva la nobiltà partenopea avversa al ministro toscano, nelle logge, più che altrove, si faceva sentire lo spirito dei tempi mutati, non disgiunto dalla frivolezza salottiera, così cara alla Regina e così avversata dal vecchio Re di Spagna». Nel 1770 per un accordo tra la Gran Loggia d’Olanda e quella d’Inghilterra tutte le logge del Regno di Napoli passavano sotto giurisdizione inglese e da Londra direttamente venne nominato Provincial Grand Master for the Kingdom of Naples, don Cesare Pignatelli, duca della Rocca e di San Demetrio. La decisione della Gran Loggia d’Inghilterra di incamerare il Regno di Napoli come “provincia” non favorisce certo l’attuazione dei piani della Regina e dell’Austria che individuavano nelle Logge una “forza politica autonoma” per realizzare una politica filoaustriaca e liberarsi del ministro Tanucci fiduciario del vecchio re di Spagna. A dare corpo al disegno austriaco fu S. A. d’Aquino, Principe di Caramanico, ufficiale dei Liparoti, favorito della Regina, in seguito nominato Viceré di Sicilia, già Maestro Venerabile di una Loggia inglese. Nel 1733 il principe Caramanico, convocati i fratelli piu’ rappresentativi, ritenendo sconveniente che “la libera nazione napoletana” dipendesse da Londra, con un colpo di mano, staccò dalla Gran Loggia d’Inghilterra, con il consenso della maggioranza dei fratelli, la Loggia “Gli Zelanti” e diede vita alla Gran Loggia Nazionale. Gran Maestro Nazionale fu eletto il Principe Caramanico; Deputato G.M. Giovanni Gironda, Principe di Cannito, 1° Gran Sorvegliante; Diego Naselli dei Principi d’Aragona; 2° Gran Sorvegliante; Eugenio di Sora; Gran Segretario: Felice Lioy. Tutto questo avviene, è utile sottolinearlo, mentre a Napoli s’insedia come ambasciatore imperiale il conte Josef Wilczek, esponente della Massoneria Austriaca. Non tutti però aderirono alla Gran Loggia Nazionale. Infatti, rimasero fedeli agli inglesi: la Loggia “Perfect Union” n° 433, la “Well Chosen Lodge” n°444, il Gran Maestro Provinciale Cesare Pignatelli Duca della Rocca e San Demetrio, S.A. Giuseppe Medici, Principe di Ottajano e molti altri. La Gran Loggia Nazionale poteva contare su tre logge già esistenti a Napoli: “La Stella”; “Gli Zelanti” e “la Vittoria”, e su tre logge fondate con bolla della Gran Loggia stessa: “La pace”, “L’uguaglianza” e “L’Amicizia”, su alcune logge a Palermo, e su logge a Messina, a Catania, a Caltagirone, in Puglia ed in Calabria. La Gran Loggia Nazionale aveva un carattere mondano e politico, allo stesso tempo convivevano lo spirito filoaustriaco ed antispagnolo della nobiltà della corte della Regina e lo spirito riformatore rappresentato da intellettuali e borghesi, come l’avvocato Lioy, il grecista Baffi, il prete scienziato Nicola Pacifico, Mario Pagano, Gaetano Filangeri ed altri. Il carattere innovativo delle logge napoletane tutte consistevano nell’affiancare agli antichi interessi umanistici ed esoterici, occultistici, un nuovo interesse: quello politico che si concretizzava in un sentimento filoaustriaco ed antiborbonico non privo di venature progressiste. Non è invece possibile stabilire quanto la Libera Muratoria partenopea fosse manipolata da certi ambienti di corte e quanto, invece, fosse una essa stessa portatrice di nuove istanze politico-sociali. La fioritura di nuove logge era, certamente, causata da contrasti ed ambizioni personali di aristocratici, legati al proprio prestigio e di morale disinvolta, ma era altresì testimonianza e indizio di elaborazione di un libero pensiero da parte di scienziati, uomini di legge, politici ed intellettuali borghesi di fine intelletto e di specchiata moralità. Dunque, accanto alla Gran Loggia Nazionale resta operante La Gran Loggia Provinciale Inglese, ma si forma anche una Loggia mista. Giuseppe Medici, principe di Ottajano, nel 1774 si stacca dalla Gran Loggia Inglese e su patente costitutiva ottenuta dal Duca di Lussemburgo, Grande Amministratore di tutte le logge di Francia, fonda una loggia intitolata “San Giovanni del segreto e della perfetta amicizia”, nella quale furono ammesse non senza scandalo, anche le donne. Tra le componenti di questa Loggia, oltre la moglie del Principe, si annoveravano la marchesa di San Marco, favorita della Regina, una madama di Belsinoir, l’attrice Antonia Bernasconi e, forse, la stessa Regina Maria Carolina. Sebbene non vi sia alcun documento che attesti l’appartenenza alla Massoneria della Regina, tuttavia le voci circolanti erano suffragate da testimoni degni di fede: l’astronomo Lalande; l’abate Barruel, scrittore antimassone, il Principe di Canosa ed infine, il cantore ufficiale della Libera Muratoria napoletana, il calabrese abate Antonio Jerocordes che scrisse: «Venne al Tempio l’augusta Regina/e ci disse i miei figli cantate./ Ma la legge, ma il rito serbate,/ma si accresca del soglio l’onor./Io vi salvo dall’alta ruina,/io distruggo le frodi, l’inganno,/io vi tolgo dal petto l’affanno,/io vi rendo la pace del cor». Si racconta, altresì che la “sorella” «Antonia Bernasconi, prima donna del San Carlo, cantando una sera, sul palcoscenico di quel teatro, salutò il pubblico con il segno di apprendista accettato Libero Muratore, riscotendo a scena aperta grandi applausi». E per completare il panorama massonico, sappiamo che a Napoli vi era anche una loggia mista di rito egiziano, fondata da Giuseppe Balsamo, cosiddetto Conte di Cagliostro, amico del Cavalier d’Aquino, fratello del Principe Caramanico. L’incontrollata proliferazione di logge tra il 1770 e il 1775 mise in allarme non solo il clero, ma soprattutto il Re di Spagna e il ministro Tanucci, suo alter ego a Napoli. Il Re di Spagna fece pressioni fortissime presso il figlio Ferdinando IV perché stroncasse la “satanica combriccola” ed il Tanucci sperava che un nuovo contrasto tra il Sovrano e la Massoneria lo aiutasse a liberarsi dai cortigiani filoaustriaci. Il 12 settembre 1775, Ferdinando IV con un Editto, rinnovò l’ostracismo contro la setta, ripetendo la condanna del ‘51. Il proclama venne accolto con indiffercnza e solo pochissimi affiliati si presentarono ad abiurare - sembra fossero 24 su 200 - purtroppo tra questi vi fu anche il Gran Maestro della Gran Loggia Nazionale, prontamente sostituito da Don Diego Naselli, Principe d’Aragona. Gli altri maestri venerabili rimasero ai loro posti e le riunioni massoniche continuarono in forma privata, protette dalla inviolabilità delle mura delle case patrizie. Il ministro Tanucci, considerato il risultato ottenuto dal Decreto e spinto dal vecchio Re di Spagna, decise di effettuare un’azione dimostrativa che fosse di chiaro monito ai nobili, ma che a pagarne le conseguenze, come al solito, fossero i borghesi. Così ordinò al Caporota Gennaro Palliante, uomo corrotto e di pochi scrupoli, di irrompere in una riunione massonica e di arrestare i trasgressori della legge, raccomandandosi, però, di evitare ai nobili l’onta dell’arresto. Palliante cercò di raggiungere il risultato richiestogli, ma non vi riuscì. Il capo-sbirri pensò, allora, di escogitare una trappola per cogliere “in flagrante crimine” ed arrestare alcuni massoni borghesi e soddisfare cosi le attese del ministro Tanucci. Palliante, assoldato un certo Giovanni Rho, libero muratore di una loggia irregolare, paggio disoccupato di mestiere, gli propose di inventarsi una riunione per l’ammissione di un nuovo fratello un certo Alberto Letwizki, polacco, cameriere, anche lui al soldo e rassicurato con una promessa di immunità e un premio di 200 ducati. La riunione venne organizzata dal “fratello” Rho in una villa alle porte di Napoli il 2 marzo 1776 e, non si sa come, vennero coinvolti alcuni onesti massoni regolari appartenenti ad alcune logge inglesi come il medico svizzero Brutschy, il medico Giacinto Benè, il tedesco Francesco Mayer medico del Principe Filippo, fratello del re, il matematico Felice Piccinini ed il grecista calabrese Pasquale Baffi. Mentre tutti si trovavano riuniti, escluso Giovanni Rho, il capo-sbirri Palliante, con alcuni poliziotti, irruppe nei locali ed al grido “viva il Re”, arrestò i presenti. II Palliante annunciò la buona novella al ministro Tanucci, il quale a sua volta recò il trionfale annuncio a Re Ferdinando IV contentissimo di avere dato una lezione esemplare e definitiva ai liberi muratori ed in modo particolare agli aristocratici senza però comprometterli. Il ministro Tanucci in una lettera al Re di Spagna, suo vero padrone, così commentava l’accaduto: «Il Re (Ferdinando IV) alla prima notizia che gli umiliai, del fatto se ne rallegrò infinitamente; oggi poi mi ha detto che è stato opportuno che il fatto era accaduto in persone di poco conto. Perché li Cavalieri rei si guardassero dalle riunioni e non potranno essere sorpresi.» I massoni caduti nella retata furono poi deferiti alla Giunta di Stato con l’imputazione di lesa maestà, reato che poteva comportare anche la pena di morte. Il Re e Tanucci pensarono di avere vinto ormai la partita, ma la situazione si complicò notevolmente perché la Regina e i magistrati subodorarono l’inganno che era stato commesso dal Palliante mentre personaggi influenti e d’opinione pubblica s’indignavano. I massoni in carcere non vennero reputati rei, ma piuttosto perseguitati e la stessa regina Maria Carolina fece pressioni sul debole Re Ferdinando IV perché li liberasse. Anche la cognata del re Maria Cristina ed il marito, il duca Alberto di Sassonia, figlio del re di Polonia, massone, di passaggio a Napoli in quei giorni, difesero apertamente i “fratelli perseguitati”, costretti in vincoli nelle segrete napoletane. Nel giugno del 1776 giunse a Napoli la duchessa di Cartey moglie di Luigi Filippo di Orleans, Gran Maestro della Gran Loggia di Francia ed ella stessa Gran Maestra delle logge femminili o di adozione. La duchessa perorò con passione la causa del “fratelli” in carcere, mentre vennero messe in circolazione varie copie di un libello anonimo, attribuito all’avvocato Felice Lioy, noto massone, che formulava una violenta accusa sull’operato del capo-sbirri Palliante e difendeva coraggiosamente gli arrestati e la Massoneria in genere considerata come associazione di uomini colti e di filantropi. La svolta definitiva del processo si ebbe verso la fine del 1776 quando Ferdinando IV, spinto dalle pressioni filomassoniche provenienti da ogni parte, licenziò il Tanucci e nominò ministro il marchese Sambuca, favorevole ai Liberi Muratori. Difatti, poco dopo gli incarcerati furono rimessi in libertà e s’innalzò un coro di lodi all’opera della Regina Maria Carolina; a Parigi, nell’aprile del 1777 gli fu intitolata una loggia, e l’abate Jerocades scrisse: «Se alla guerra, se all’aspra tempesta /già succede la pace e la calma; /Carolina riporta la palma, /che dell’empio sconfisse il furor». Il capo-sbirri Gennaro Palliante, dopo un processo con vicende alterne, venne graziato dal sovrano e andò in pensione, i massoni arrestati furono reintegrati nei loro posti, il polacco Letwiski morì misteriosamente, forse avvelenato, nel 1777. Finiva così la seconda repressione massonica partenopea ed ancora una volta a spese della borghesia: un avvocato, un professore di greco, qualche militare e qualche commerciante. «Capi espiatori certamente, ma anche esponenti di quel ceto borghese che nelle logge vede un modello di vita democratica determinata dalla uguaglianza di tutti gli associati, dalla eleggibilità e dalla temporaneità delle cariche». La libera muratoria diventa il veicolo delle idee antifeudali ed antiassolutistiche, aldilà della ritualità e delle solennità mondane nelle logge si alimenta uno spirito nuovo destinato a fare della Massoneria un partito progressista. Sebbene gli Illuministi, i riformatori operino fuori della Massoneria, tuttavia sono le logge a diffondere le loro idee ed ad organizzare un partito in lotta contro i privilegi della Chiesa e le strutture feudali. Tornando adesso alla Libera Muratoria nel Regno di Napoli, abbiamo già detto che dopo l’editto d’interdizione emanato da Ferdinando IV nel 1775, II Gran Maestro della Gran Loggia Nazionale, il principe di Caramanico, abiurò davanti alle autorità competenti, ma abbiamo motivo di credere che la sua apostasia fosse un fatto formale e politico, poiché il suo nome riaffiora in un elenco di Liberi Muratori siciliani nel 1711, periodo in cui era Viceré in Sicilia. In ogni modo dopo solo quattro mesi la Gran Loggia Nazionale si ricompose ed il 24 giugno del 1776 venne eletto Gran Maestro Don Diego Naselli dei Principi d’Aragona; suo deputato, l’abate Olivetano Kiliano Caracciolo, odiato dagli ecclesiastici, ma amato dalla Regina. Diego Naselli fu il classico rappresentante della aristocrazia napoletana colta e curiosa, nutriva aspirazioni spiritualiste e coltivava gli studi ermetici, fu molto interessato al sistema degli Alti Gradi. Ben presto Naselli e la maggior parte dei Grandi Ufficiali della sua Gran Loggia aderirono al sistema della Stretta Osservanza eseguendo così il distacco dalle logge inglesi e di conseguenza dalla Gran Loggia di Londra. L’adesione alla Stretta Osservanza venne sollecitata dal Barone vonEyben, diplomatico e rappresentante del Re di Danimarca a Napoli. A sollecitare l’adesione del Naselli fu certamente anche la Regina che approvava l’adesione ad un organismo dominato da elementi tedeschi. Il mito portante dell’Ordine della Stretta Osservanza era quello dei cavalieri templari. I tedeschi aggiunsero anche un collegamento dei cavalieri templari con i Canonici del Santo Sepolcro che a loro volta conservavano i segreti degli Esseni. Secondo questa poco credibile leggenda, nata nel sec. XVIII l’Ordine dei Templari si sarebbe perpetuato in seno alla Massoneria, di cui i cavalieri costituiscono l’ordine interno e dirigente, ignoto agli stessi affiliati. La leggenda riporta l’elenco dei Gran Maestri che clandestinamente si sarebbero susseguiti per 250 anni, conservando e trasmettendo i segreti dell’Ordine. Lo scopo del sistema era la ricostituzione dell’antico Ordine Templare ed il riacquisto delle antiche ricchezze Il fratello veniva armato “cavaliere”, con un rituale in lingua latina, scopiazzato dal culto cattolico. La Stretta Osservanza faceva capo al Duca Ferdinando di Brunswick e Lunenburg, cognato del Re di Prussica Federico II, di religione luterana. L’adesione della Gran Loggia Nazionale alla Stretta Osservanza era ben vista politicamente dalla Regina che considerava rafforzato il partito filoaustriaco, soddisfaceva le smanie dell’aristocrazia desiderosa di mistero e di novità ed aveva minore opposizione nella Chiesa Cattolica. Anzi, lo spiritualismo religioso che «animava la Massoneria Templare, con i suoi riti scimmiottanti quelli della Chiesa romana, con i suoi miti che per un verso o l’altro si rifacevano al medioevo cristiano, non senza precisi riferimenti a Roma, rappresentavano un’ottima premessa per battere il protestantesimo razionalista ed offrire un terreno d’incontro, tra spiritualisti evangelici e cattolici in cui quest’ultimi, con la loro ricca tradizione culturale avrebbero finito per prevalere. In quanto all’ermetismo occultista, coltivato comunque da piccoli nuclei d’iniziati... solo in apparenza sconfinava nell’eresia. In fondo, fino ai tempi di Alberto Magno e di san Tommaso d’Aquino, alchimia e magia, evocazione di spiriti benigni ed esorcizzazione di quelli maligni, avevano trovato un parziale diritto di cittadinanza anche in seno alla Chiesa Cattolica». Ben altra cosa era la Libera Muratoria Inglese che si presentava con un semplice sistema trigradale, che utilizzava un rituale essenziale e riuniva nobili, borghesi e militari e che veniva considerata politicamente e socialmente pericolosa per l’umanitarismo egualitarista, per le idee liberali e progressiste derivanti dal protestantesimo razionalista. La Massoneria Inglese era molto attiva e sorgevano logge un poco ovunque per tutto il Regno di Napoli. Continuando nella descrizione della geografia massonica del Regno di Napoli, procederemo con un sommario di quest’ultimo decennio che meriterebbe una trattazione più puntuale specialmente per gli eventi riguardanti le logge legati agli Alti Gradi della Stretta Osservanza, riformata dopo il Convento di Wilhelmsbad del 16 luglio 1782: molte notizie che riferirò sono, infatti, ricavate dall’epistolario e dagli scritti del brillante teologo luterano Friederich Munter, inviato in Italia dal Duca di Brunswick per ristrutturare e diffondere gli altri gradi. Sappiamo che in Calabria esistevano diverse logge: a Reggio Calabria, a Troppa, a Filadelfia, a Maida, a Catanzaro. Probabilmente queste logge furono fondate tra il 1773 e il 1883 dall’abate Jerocardes. Munter riferisce che «a Reggio Calabria c’era una loggia di costituzione inglese, i fratelli tenevano le loro agapi in un’osteria; sul loro conto si mormorava che fossero sodomiti e l’arcivescovo faceva violenti prediche contro di loro» .Munter a Reggio conobbe Agamennone Spanò, morto per mano del boia borbonico nel 1789, e Giuseppe Zurlo che scampato alla Rivoluzione fece una brillante carriera politica sotto Murat e partecipò ai moti del 1820. Fu Zurlo a mettere in contatto Munter con Domenico Cinilo, con Mario Pagano, con Gaetano Filangeri e con Donato Tommasi. Anche la loggia di Tropea, fondata ad interim con patente marsigliese, passò a far parte della Gran Loggia Provinciale Inglese. Delle altre logge calabresi non si sa nulla aldilà della loro esistenza. A Messina, nel 1780, esistevano due logge: la prima, esistente fin dal 1776, patentata dalla Gran Loggia Nazionale di Napoli, aveva come titolo “La Loggia dei Costanti”, ma scomparve, non si sa perché, nel 1782; nel 1778 sorse un’altra loggia, di cui non conosciamo il titolo, che aderì al sistema inglese. Anche W. Goethe parla di una loggia aperta nel suo “Viaggio in Italia”. A Palermo vi erano due logge: la prima era la vecchia loggia “San Giovanni di Scozia”, che dopo il 1776 aveva aderito al Regime Rettificato di Lione, seguendo l’esempio della Gran Loggia Nazionale; l’altra, invece, era nata con patente del Gran Maestro Provinciale del sistema inglese Cesare Pignatelli. Di questa loggia inglese faceva parte uno dei più colti aristocratici napoletani, il marchese Corrado Bajada, il giurista e letterato Giovanbattista De Stefano, il poeta Antonio Lucchesi dei principi di Campofranco, il poeta Giovanni Meli e diversi frati benedettini e domenicani. A Siracusa c’era stata un loggia fondata dal Principe Carlo di Lorena, ma in questo periodo aveva cessato ogni attività e vi erano solo fratelli sparsi. A Catania, invece, vi era una loggia molto efficiente, malgrado le persecuzioni del vescovo ed era diretta dal vecchio Principe Ignazio Paternò noto mecenate ed amato da tutti i fratelli per la sua gcntilczza. Dalla “Noticen für Geschichte” apprendiamo, inoltre, che in Sicilia ed a Napoli esisteva una società segreta, concorrente della massoneria chiamata “Gli Zappatori”. Questa società aveva come scopo quello di infiltrarsi nell’Ordine Massonico per poi tradirlo, rendendolo ridicolo e svelarne i segreti. Il loro simbolo era un albero presso il quale giaceva una scure ed un massone che correva a gambe levate. Nella loro società venivano ammesse anche le donne ed il loro capo era un certo Ignazio Wirtz, ufficiale di un reggimento, ex massone. Gli anni ottanta del diciottesimo secolo segnano un nuovo declino della Libera Muratoria nel Regno di Napoli, questa volta dovuto soprattutto a cause interne. Forse questa crisi era latente: la Gran Loggia Nazionale aderendo alla massoneria cavalleresca aveva in un certo qual modo segnato il suo destino, perché le nuove generazioni avevano istanze diverse, meno mistiche, meno spiritualistiche, più coerenti e politiche. Mentre le logge inglesi crescevano e si dilatavano e stavano ottenendo da Londra il permesso di erigere una Gran Loggia delle Due Sicilie. Tuttavia, anche queste logge erano in crisi perché depauperate dalla aristocrazia avevano poco peso politico. Ma la verità era che per tutta la Massoneria europea sembrava fosse giunta l’ora della crisi. In Germania la Massoneria veniva attaccata da “forze reazionarie, cattoliche ed occultistiche”. Lo stesso Imperatore d’Austria dubitava che la Libera Muratoria potesse essergli utile per i suoi fini politici. Iniziava a levarsi il vento della Rivoluzione, ed i sovrani nutrivano sospetti verso tutto e tutti. Di lì a poco a Napoli sarà pubblicato il terzo editto contro le società segrete, sicché molti liberi muratori entrarono in clandestinità dando vita a gruppi politici segreti. «Evidentemente la crisi della Massoneria non era crisi di sistemi o diritti, ma era qualcosa di ben più profondo. Ci si accorgeva ormai da parte degli stessi “fratelli” spiritualisti che il sorgere di una spiritualità non poteva essere opera di una organizzazione massiccia come la Massoneria, ma doveva essere frutto di opera individuale e di piccoli gruppi esoterici formati da eletti». Nel lento progredire dell’Istituzione accendeva speranze nei massoni razionalisti i quali ormai avevano capito che occorreva ricorrere alla lotta politica aperta, sensibilizzare più vasti ceti sociali per vedere concretizzarsi le aspirazioni costituzionali e gli ideali liberali.


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()