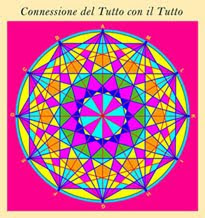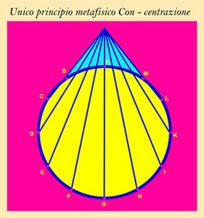28 aprile 2014
II tema di questo anno come, stabilito dal Presidente ad
inizio mandato, e l'armonia, tema fondamentale soprattutto nel nostro ordine
iniziatico che pone la centralità dell'afflato tra fratelli nelle proprie
attività e nei propri lavori. Minata a più non posso tutti i giorni l'armonia
tra le persone e una delle condizioni più difficili da mantenere salde in
quanto spesso preda di una serie di egoismi che non rispondendo più a leggi
naturali fraterne annulla quella concordia che risponde alle leggi universali.
Quando si parla di armonia non si può non far riferimento all'armonia musicale,
alla sua bellezza che, quando ben strutturata, si incastona a perfezione nell'ambito
universale insieme alle discipline altrettanto universali come la geometria la
matematica, ma, come queste discipline, deve assolutamente rispondere ai
dettami della perfezione sintattica, altrimenti, anche qualora ne fosse minimamente
alterato l'equilibrio, risulterebbe nettamente al contrario antiestetica e
repulsiva. Quindi considerando come assioma che la disarmonia e dettata dall'egoismo,
l'armonia e dettata, di contro, dall'altruismo? Non e proprio cosi l'armonia e
equilibrio e legata alla legge ben definita di "Non fare agli altri ciò
che non vorresti che a te sia fatto" che non e proprio lo spogliarsi dei
propri beni e regalarli agli altri ma il rispetto della persona che ci sta accanto
come se fosse, appunto, un fratello, cioè carne della nostra carne, anima della
nostra anima e spirito del nostro spirito che noi rievochiamo con la catena di
unione. Quello che ci dobbiamo chiedere e : "Perché e cosi difficile comportarci
da fratelli? Perché non riusciamo ad aprirci, ad accogliere il vicino a fare in
modo che ci si aiuti a vicenda, ho letto un concetto un po' originale per i
nostri tempi che mi e costato un po' di minuti per comprenderlo appieno ed
apprezzarlo: "la più alta forma di altruismo e dare la possibilità agli
altri di aiutarci" sembra ridondante, un paradosso ma l'arroganza e figlia
dell'egoismo, vuol dire io sono migliore di te, non ho bisogno del tuo aiuto io
non mi sottometto per chiederti aiuto! Quante volte il genitore ha avvertito
questa sensazione di frustrazione quando un figlio si e comportato in questo
modo? ”Cosa devo fare per amare il mio prossimo?” chiese il discepolo al
Maestro.
“Smetti di odiare te stesso” gli rispose il maestro.
Scelta complicata non odiare più se stesso, che non vuol
dire accaparrarsi beni terreni per vivere felice o sereno ma vuol dire
scegliere di essere ripagati con un'altra moneta ricevere e dare amore. Quindi
si sceglie: si sceglie di vivere votato verso l'amore o verso l'egoismo, verso
il bene o verso il male verso il bianco o verso il nero, si sceglie una società
di giusti o di iniqui. L'uomo può essere identificato come una "Fabbrica
delle scelte", la di cui vita e completamente definita da scelte e la
risultanza di tutte le scelte operate e proprio quell'uomo che noi riusciamo a
discriminare, a distinguere l'uno da un altro, e un risultato empatico,
armonico amabile e amato o il suo contrario, e l'uomo. II libero arbitrio e una
preziosa condizione sicuramente sottovalutata, che ci permette, senza nessun legaccio
di sorta, di operare una scelta anziché un'altra. II libero arbitrio, pero, e
una condizione insidiosa, e il presupposto per maturare o regredire, ci fa
aiutare gli altri o ci rende egoisti, ci fa diventare grandi uomini o persone chiuse
al mondo esclusivamente interessati alla propria personale sfera vitale, ben
attenti che nessuno la invada, oppure sinceri fratelli. Nessuna altra entità nell'universo
possiede il libero arbitrio al di fuori dell'uomo, per esempio la luna non può
decidere una rivoluzione intorno alla terra diversa da quella che svolge
naturalmente da milioni di anni, gli ovini non hanno la possibilità di scegliere
se mangiare l'erba o la carne, gli alberi non possono scegliere se perdere o no
le foglie in autunno e rigenerarsi in primavera.
II momento della scelta, in generale, e un momento magico in
cui tutte le forze, le convinzioni, le ideologie che si sono fatte proprie, le
esperienze, l'entusiasmo concorrono ad un risultato che può essere illuminante,
dare uno scopo alla propria vita o può costare caro e bene lo potrebbero testimoniare
i tanti eretici che spesso hanno sacrificato la propria vita per un'idea sulla
cui base posava la scelta fatale. Perché inserire gli eretici in questo contesto?
Perché la parola "scelta" e presente nell'etimologia della parola
"eresia". La parola eresia deriva dal greco αἵρεσις , derivato a sua
volta dal verbo αἱρέω ( "afferrare", "prendere" ma anche
"scegliere" o eleggere"). L'eretico non sarebbe altro che una
persona che sceglie, in contrapposizione con coloro che non scelgono, cioè chi
accetta supinamente, soprattutto i dogmi, nelle speculazioni religiose. II
rifiuto del dogma, e alla
base dell'azione dell'Eretico. Essere eretici non significa,
tuttavia, opporsi necessariamente all'eventuale dogma, ma vuol dire rivendicare
la liberta di avere un punto di vista critico e consapevole e un confronto
continuo tra opposti trovando una eventuale sintesi. II dogma si potrebbe anche
alla fine accettare, ma non incondizionatamente, solo dopo un'analisi critica,
si accetterebbe consapevolmente e non sarebbe stato recepito per imposizione o
per pigra convenzione sic et simpliciter. Per essere presente una eresia,
intesa, quindi, come scelta diversa dalla consuetudine, deve anche esistere una
ideologia o una ideologia usata strumentalmente come quella religiosa nel
passato, per cui ne deriva che, di un'ideologia si può esserne in disaccordo
pur rispettando le persone che la condividono, ma l'ideologia falsa e
strumentale e decisamente combattuta sicuramente da tutti gli illuminati e da
tutti gli onesti e i liberi pensatori. Gli eretici condannati, bruciati vivi,
fino al 1621 (dopo questa data si abbandono questo tipo di cruenta condanna) se
ne possono contare un migliaio riconosciuti storicamente divisi in : valdesi,
Luterani, anabattisti, protestanti, apostasi (Giovanna d'Arco), riformatori
(Savonarola), mennoiti, antitrinitari, millenaristi una vera strage per
difendere le posizioni di potere conquistate negli anni. Giordano Bruno, per
esempio, e stato uno degli esempi più significativi di eretico positivi. Era un
illuminato e, come tale, non poteva esimersi dal condannare il filone legato
strettamente al potere terreno della Chiesa che rispondeva a dettami
completamente diversi da quelli primigeni, era un grande religioso che
considerava l'entita suprema come fine ultimo della condizione terrena di un
uomo, a cui poteva giungere autonomamente, anche senza l'aiuto della Chiesa a
differenza del pensiero concepito all'epoca, in quanto Io spirito divino e in
ognuno di noi e quindi sta a noi saperlo ricercare e addivenire alla
"luce", anche senza l'intercessione della casta religiosa che, in
questo modo, veniva a perdere una larga fetta di potere. G. Bruno perde la vita
per un'ideologia. AI contrario Tommaso Campanella, non proprio per un'ideologia
ma per una serie di suoi scritti, che fu imprigionato nello stesso periodo di
G. Bruno, ha un comportamento completamente diverso da quello di Bruno, fa di
tutto per essere liberato fino a fingersi pazzo pur di non essere giustiziato.
Campanella ricorda nella "Citta del sole", opera
di carattere utopico in cui descriveva una citta ideale utopica governata dal
Metafisico, anche le sue terribili torture subite, proprio nelle ultime parole
dell'opera "Ma non trattenetemi oltre che ho da fare: Sai bene che ho gran
fretta. Continuerò un'altra volta. Sappi solo questo ancora: che essi credono
sommamente al libero arbitrio e sostengono che se dopo un supplizio di 40 ore
un uomo non si convince a parlare se ha deciso di tacere neanche l'influsso degli
astri può forzarlo" Tommaso Campanella si salva grazie a uno stratagemma.
Giusto per dovere di completezza aggiungerei un altro grande
personaggio sempre del periodo e sempre sospettato di eresie accusato di voler
sovvertire la filosofia naturale aristotelica e le Sacre Scritture, Galileo
Galilei, che, a sua volta, pur di potere continuare i suoi studi e i suoi
esperimenti dovette far appello all'abiura, altra scelta diversa dai primi due.
Galileo Galilei si salva attraverso un pensiero ragionato. La
liberta arbitraria dei tre personaggi su descritti ha fatto in modo di
apportare degli importanti cambiamenti nelle conoscenze scientifiche;
immaginate se Galileo Galilei avesse scelto di sacrificarsi o che Bruno avesse
optato per l'abiura.. chissà dopo quanti anni avremmo fatto le scoperte
galileiane e forse Giordano Bruno non sarebbe altro che uno dei tanti pensatori
dimenticati nei meandri della storia. Tornando un po' indietro nel tempo con Erasmo
da Rotterdam la teoria sul libero arbitrio diventa un importante tema di
discussione ad altissimo livello addirittura vedeva contendenti lo stesso
Erasmo contro Martin Lutero, esaminando la problematica attraverso due trattati
il "De libero arbitrio "di Erasmo e "II servo arbitrio" di
Lutero. II concetto di Erasmo parte da un considerazione di base :
"Nascita sviluppo e esito finale". Di cui il primo e ultimo elemento riguardavano
"la Grazia" e il centro era questo il percorso che poi faceva
sfociare l'anima di un essere umano verso la Grazia o verso la perdizione, era
guidato proprio dal libero arbitrio cioè quell'elemento che rende la vita di un
uomo significativa, al contrario di ciò che affermava Lutero che tutto era
guidato da Dio e quindi con una accezione prettamente predeterminata era il
destino già scritto che guidava la vita di ogni uomo. Le scelte “tout court” vanno
cosi a configurarsi in un ambito universale come un elemento importante
dell'armonia. L'armonia, sia ben inteso, per esprimersi al meglio, ha bisogno
di elementi disuguali, ma non per questo contrari. L'armonia si esprime al
meglio in un ambito complementare che bene viene enucleato nell'ambito musicale
in cui le sette note, che possono sembrare poche ma che nelle diverse
combinazioni aumentano esponenzialmente il loro numero, nella sequenza armonica
una nota che e in armonia in un particolare contesto con un'altra risulta
completamente dissonante in una determinata tonalità ma, invece, completamente
in sintonia con la stessa nota in un'altra tonalità ancora. Nei gruppi sociali avviene
ne più ne meno la stessa cosa una persona in un determinato momento risulta in
armonia con un altro, mentre in un altra occasione a distanza di qualche tempo
risulta in completa dissonanza. Mentre le note rispondono a un disegno definito
dal compositore, l'uomo risponde a un disegno tracciato dalla volontà umana in
cui si può scegliere di essere tolleranti o indisporre, di accettare la
provocazione o comprenderne la ragione. Bene, detta cosi potrebbe essere anche abbastanza
semplice se non ci fossero gli altri liberi arbitri delle altre persone agenti
con i due contendenti, per cui, come nella musica, non si tratta di fare un
intervallo armonico consonante con due sole note, ma bisogna fare ciò che in
musica si definisce accordo. Gli accordi, per stare bene in sequenza devono
seguire comunque una melodia il tema tracciato che se e comune Io schema melodico
funziona ma, se il tema, in altre parole l'obiettivo e diverso un accordo che
poteva essere consonante con una melodia risulta dissonante con un'altra suonata
contemporaneamente, fuori da metafora, e la divergenza dei fini che crea quella
disarmonia di cui tanto soffriamo nel mondo moderno che dobbiamo cercare di
debellare. In parole povere, se io lavoro per produrre e far crescere l'azienda
nella quale svolgo il mio compito e un altro lavora solo per portare a casa lo stipendio
impegnandosi il meno possibile, siamo completamente divergenti e quindi
difficilmente armonici, non seguiamo lo stesso disegno melodico di cui sopra,
se, invece, siamo due persone che hanno lo stesso obiettivo, possiamo essere
d'accordo e complementari raggiungendo insieme e meglio l'obiettivo comune
senza conseguenze non intenzionali, evitando l'eterogenesi dei fini teorizzata
da Della Porta o altri tipi di inquinamenti devianti.
Si potrebbe obiettare cosa centra tutto cioè con
l'esoterismo e la massoneria? Gli obiettivi comuni, la linea melodica, quella
traccia che fa in modo che ognuno scelga, secondo il proprio punto di vista, di
apportare un contributo alla causa, di pensare e fare il bene per l'umanità,
anche eventualmente a discapito del proprio e di ricercare il proprio
miglioramento, e l'energia comune il fil rouge, la melodia comune che,
seguendola tutti, anche nella molteplicità di idee e di ottiche diverse, produce
quella consonante armonia cui tanto aspiriamo ci fa sentire uniti ci fa sentire
uomini ci fa sentire fratelli.
M. B.
Note:
1 Gli Anabattisti non usarono mai questo nome per
definirsi credenti, tra loro si chiamavano semplicemente "Fratelli in
Cristo" o "Fratelli". II termine "anabattista" fu
coniato dai loro nemici con intento mistificante: quando gli
"anabattisti" battezzavano i credenti, non intendevano, infatti,
"ribattezzare", perché per loro il battesimo dei neonati, un battesimo
ricevuto per volontà altrui e per interposta persona, era nullo.
2 I Mennoniti costituiscono la più numerosa delle
chiese anabattiste. Devono il loro nome a Menno Simons (1496-1561), che assicurò,
riorganizzandoli, la sopravvivenza degli anabattisti olandesi dopo che questi stavano
attraversando un periodo di gravissima crisi, in seguito agli eventi di
Milinster (1535). Ad oggi si contano più di un milione e mezzo di mennoniti nel
mondo, soprattutto negli Stati Uniti, sulle coste caraibiche in Honduras, in
Paraguay (soprattutto tra i discendenti degli immigrati tedeschi), in Canada,
in Africa e in India.
- FRATELLO MOZART
Maestro
Venerabile, Fratelli all’Oriente,
più
che una tavola su Mozart e la sua musica massonica, la mia vuole essere una
riflessione su “Mozart Musicista”, che ha composto musica per i suoi Fratelli
di Loggia e per i nostri Architettonici Lavori.
Tutti
sappiamo che Mozart era un Fratello; egli, infatti, entrò in Massoneria il 14
dicembre di 229 anni fa, nella Logga viennese “La Beneficenza”, all’età di 28
anni, quand’era già all’apice della sua fama internazionale e le sue opere, le
sue sinfonie e i suoi concerti erano i più eseguiti in tutti i teatri d’Europa.
Mozart,
quindi, prima ancora che massone, era un grandissimo musicista.
La
musica richiede un punto di vista: un musicista non può nascondersi dietro la
falsa modestia e dire: “io non sono nulla, la musica è tutto”.
Il
musicista deve avere un punto di vista, ma un punto di vista che non sia basato
su un modo arbitrario di scrivere o di leggere la musica, perché il musicista
deve comprendere – o permettere agli altri di comprendere – tutte le
informazioni stampate sulla pagina, capire tutte le diverse relazioni che
vengono espresse attraverso questi segni, e conoscere le modalità di
espressione di tutti gli elementi a sua disposizione: il ritmo, la melodia, il
volume, l’armonia, la velocità, etc.
Quando
parliamo di musica, parliamo della nostra reazione musicale.
Ho
avuto modo di leggere tantissime definizioni di musica e alla fine ho capito
che ce n’è soltanto una che esprime veramente la musica, ed è una definizione
molto precisa e obiettiva del pianista e musicologo Ferruccio Busoni, il quale
scriveva che: “la musica è aria sonora”.
Se
Busoni ha ragione e la musica è aria sonora, dobbiamo cercare di capire che
cosa sia quest’aria sonora, insomma è solo l’insieme di bei suoni?
Il
suono di per sé non ha un significato, ma nel contesto musicale assume un
significato perché tutta la musica scritta dai grandi compositori ha,
ovviamente, un elemento umano.
Mozart,
Bach, Beethoven, e altri compositori, non sono solo maestri di armonia e
contrappunto, essi hanno anche qualcosa di importante da esprimere e lo fanno
attraverso il suono; perciò è molto interessante sia per il musicista che per
l’ascoltatore, cercare di capire cosa sia questo elemento del suono e quando
smette di essere un puro fenomeno fisico per assumere altre connotazioni.
Come
nasce il suono? Da dove viene il suono?
I
violinisti appoggiano l’archetto sulle corde e i fiati soffiano nei loro
strumenti per produrre un suono, ma cos’è questo suono? E cosa gli succede quando
arriva all’orecchio? Perché, ovviamente, non esisteva prima che i violini
suonassero e, poi, quando sollevano l’archetto dalle corde, non esiste più? Non
so dove sia, ma è comparso ed è scomparso, perciò è effimero, non rimane.
Ciò
significa che noi lo produciamo fisicamente, non metafisicamente.
Non
si possono avere dei suoni senza il silenzio, perché il primo suono è ciò che è
in relazione al silenzio che l’ha preceduto e l’ultimo suono è in relazione col
silenzio che lo segue; perciò dobbiamo sempre pensare al silenzio e usarlo in
diversi modi.
A
volte lo si usa per interrompere la musica, altre volte si usa la musica per
interrompere il silenzio, altre volte, ancora, il silenzio può creare
l’illusione di un suono più forte di ciò che l’ha preceduto per via della sua
intensità.
Ci
sono, quindi, centinaia di modi di usare il silenzio, ma una cose è certa: esso
è sempre presente!
E
Mozart, proprio perché massone, era ben consapevole dell’importanza del
“Silenzio” e della sua costante presenza, tanto da lasciarcene testimonianza in
molteplici sue composizioni; basti ricordare per tutte la famosa “Musica
funebre massonica – K 477” ,
in cui fin dalle prime battute alterna magistralmente note musicali e silenzi.
Fa
iniziare il brano quasi dal nulla e nel nulla lo fa terminare, per questo
motivo è importante seguire il suono fino all’ultimo istante, fino all’ultimo
respiro, prima che arrivi il silenzio finale, quel silenzio che rappresenta
l’ultimo momento di musica fisica, ma il primo anelito di speculazione
interiore.
Mozart,
attento conoscitore dell’animo umano, ben sapeva che la musica è un fattore
indispensabile per i nostri lavori nel Tempio: essa tocca i nostri cuori ed
arricchisce l’essenza dei nostri Rituali, ogni nota, ogni accordo, ogni pausa
si mescolano alchenicamente tra loro guidandoci in un universo immaginifico che
facilita e permette, a ciascuno di noi, di intraprendere quel viaggio interiore
che ci fa guardare e tendere verso l’infinito, pur rimanendo con i piedi ben
saldi a terra.
L’ascolto
è un sentire ragionato, e quando durante i Lavori si ascolta la musica del
Fratello Mozart, si sente, in quel
preciso momento, la tensione del suono
in tutta la sua Forza, in tutta la sua Bellezza, è come se il Fratello
ascoltatore venisse preso dalla prima nota e trasportato in un viaggio fuori
dalla realtà, che gli consente di accedere alla sfera della meditazione e della
trascendenza, ma è proprio in quel viaggio che egli trova un’altra realtà.
Mozart,
conscio di tutto ciò, considera la musica composta per i lavori di Loggia,
“Musica Sacra”, alla stregua di quella scritta per la Chiesa, ma dove egli, a
differenza di quest’ultima, si sente completamente libero, non dovendo
soddisfare alcuna esigenza prestabilita: è musica pura, composta da un Fratello
per i Fratelli.
Tra
i diversi brani massonici composti da Mozart e che usiamo durante i nostri
Architettonici Lavori, quello che, forse, maggiormente testimonia il suo senso
di appartenenza all’Ordine e di forte e sentita fratellanza è la cantata:
"Lasst uns mit geschlungnen Händen" (Fratelli andiamo mano nella
mano), tratta dalla “Piccola cantata massonica K 623” del 1791, composta pochi
giorni prima del suo passaggio all’Oriente Eterno, espressione della sua
raggiunta maturità massonica.
Tale
cantata è un’accorata esortazione che Mozart rivolge ai Fratelli che insieme
hanno lavorato in Loggia:
"
Fratelli finiamo questo lavoro mano nella mano in suoni di letizia.
Questa
catena circondi l’intero globo terrestre come questo sacro Tempio.
Onorare la virtù e l’umanità, insegnare a noi
stessi e agli altri, l’Amore sia sempre il nostro primo dovere.
Poi
non solo all’Oriente splenderà la luce non solo all’Occidente, ma anche a
Mezzogiorno e a Settentrione”
Mozart
fa cantare al coro “l’Amore sia sempre il nostro primo dovere”, quell’Amore che
“move il sole e l’altre stelle”, quell’Amore che spinge l’Uomo Iniziato – non
l’uomo ordinario, l’uomo che non vuole porsi troppe domande a cui, poi, deve
dare scomode risposte – alla ricerca della Ragione, alla ricerca della
Bellezza, alla ricerca della Sapienza, alla ricerca della propria identità, di
quell’Io più profondo che nasconde la Verità.
Se
la musica è, quindi, un linguaggio universale che accomuna razze, lingue e
culture diverse, al di là della conoscenza tecnica, ancor di più lo è per i
Massoni la musica del Fratello Mozart, perché essa rappresenta un quid in più
che consente a tutti noi, Uomini Liberi – capaci ancora di stupirsi come dei
bambini davanti alla meraviglia del creato e di coltivare la propria
sensibilità – di entrare in un rapporto aggregante che permette, senza la
necessità di fare ricorso all’uso della parola, di raggiungere la migliore
rappresentazione dell'Armonia Universale, intesa come unificazione ed
equilibrio degli opposti elementi.
I.F.
Pubblicato da
Nicola Ferraro
alle
16:22
1 commenti
![]()
Etichette: Esoterismo, Filosofia, Massoneria, Simboli
21 aprile 2014
- Isaac Newton ultimo magus.
Non
so cosa possa sembrare al mondo, ma a me stesso sembra di essere stato solo
come un ragazzo, che gioca sulla riva del mare e che si diverte a trovare di
quando in quando un ciottolo più liscio o una conchiglia più bella del solito,
mentre il grande oceano della verità si stende tutto sconosciuto davanti a me”.
(Isaac
Newton)
Chi
era veramente sir Isaac Newton? Molti di noi conservano l’immagine che di lui
ci hanno consegnato gli studi liceali, quella del ricercatore razionale, arido
e un po’ misantropo, il fondatore del modello di scienziato modernamente
inteso, tutto formule matematiche ed esperimenti rigorosi. Altri lo ricordano
sotto la sbrigativa formula dell’ ”Hypothesis non fingo”, che immortalava
la sua propensione alla pura descrizione dei fenomeni che osservava e la sua
presunta diffidenza verso ogni commistione della scienza con la cultura
generale, con la filosofia o, peggio, con la religione.
E
se invece fosse stato, come dicono alcuni, un profondo conoscitore di culture
iniziatiche, un esperto di segreti alchemici?
E
come potrebbero conciliarsi in una stessa persona il volto del grande iniziato
con quello del grande scienziato razionale?
Ma
stiamo ai documenti. Che il professor Newton fosse un avido divoratore di testi
alchemici e iniziatici è un fatto: lesse l’antologia sugli alchimisti inglesi
scritta dal suo amico Elias Ashmole, studiò i testi rosicruciani di Michael
Meier e quelli dell’alchimista francese Pierre Jean Fabre. Ma soprattutto fu
membro e, per lungo tempo, presidente della prestigiosa Royal Society di
Londra, un’associazione culturale che raccoglieva il fior fiore del mondo
scientifico inglese, che fu la culla delle più avanzate ricerche scientifiche,
ma che ospitava anche molti esponenti di punta della cultura iniziatica
dell’epoca. E per molto tempo su questo argomento non si seppe altro. Non
dimentichiamoci che quelli erano tempi assai difficili per gli uomini di
scienza e, come ci raccontano le cronache dell’epoca, dai pulpiti dei
predicatori e dalle pagine dei giornali si tuonava spesso contro i membri della
Royal Society, la folla nelle strade li dileggiava, persino Oxford e Cambridge
consideravano le loro teorie troppo “avanzate” e spesso non osavano ospitare i
loro corsi. Non parliamo poi delle autorità ecclesiastiche anglicane che, in
quanto a tendenze inquisitorie non erano da meno rispetto alla tanto odiata
Chiesa cattolica romana.
Tuttavia
altre notizie ci sono arrivate in tempi molto più recenti e dalla fonte più
inaspettata: una cassa di documenti che l’’insigne economista inglese John
Maynard Keynes acquistò da Sotheby’s nel 1936. Dentro quella cassa egli trovò
una raccolta di carte segrete, scritte di pugno da sir Isaac, tenute
accuratamente nascoste per secoli ai rigori della censura religiosa e di
quella, ancor peggiore, della scienza ortodossa. Questa preziosa raccolta era
stata rifiutata qualche anno prima dall’Università di Cambridge perché ritenuta
di nessun valore scientifico. Dalle carte autografe del professore, che
contenevano oltre un milione di parole sull’alchimia emerge tutta la sua
passione per la cultura alchemica, come del resto per lo studio della Bibbia.
Grazie a questi documenti, oggi sappiamo con certezza che le ricerche di Newton
nel campo dell’alchimia esercitarono un influsso fondamentale sulle sue
scoperte scientifiche con cui egli cambiò il mondo. Come nella migliore
tradizione alchemica, i suoi studi iniziatici e scientifici furono
indistricabilmente legati. Del resto, un discorso identico può essere fatto
anche per Boyle, che praticava l’alchimia tanto quanto la chimica e si servì di
molti aspetti della prima per far progredire le frontiere teoriche della
seconda.
La
cosmogonia alchemica rappresentò per Newton una potente fonte di ispirazione: è
dalla configurazione del Tempio di Salomone che egli sviluppò le leggi di
gravitazione (e non perché gli cadde una mela sul naso…). Newton descrive il
centro del Tempio come un focolare per offrire sacrifici, perpetuamente acceso
e attorno al quale i credenti si riuniscono. L’immagine di un focolare al
centro e dei discepoli disposti attorno fu quella su cui si basò per sviluppare
il concetto di gravitazione universale. Anche la teoria dell’attrazione a
distanza nacque da ispirazioni alchemiche: per formularla, probabilmente egli
mutuò il concetto di “spirito” che, secondo la dottrina degli alchimisti,
è principio di attrazione. Newton annota la seguente frase tratta da
Sendivogius:”…il mercurio attrae i semi di antimonio e il magnete attrae la
siderite. E la “nostra acqua” viene attratta dal piombo per forza della
siderite che si trova nel ventre di Ares (il ferro)” .
Ed
è dall’etica alchemica che Newton attinge quella dedizione e quel rigore morale
che hanno caratterizzato la sua personalità: “Io tengo l’argomento costantemente
di fronte a me finché, a poco a poco, le vaghe luci dell’alba lentamente si
aprono nel pieno chiarore del giorno”.
Newton
è anche un profondo conoscitore della scuola pitagorica e, nei
suoi Principia mathematica, compie un esplicito tentativo di riscoprire
l’aspetto esoterico della cosmologia pitagorica, nascosto sotto i “discorsi
volgari” della musica delle sfere. In realtà, il grande “philosophus
naturae”, come egli stesso si definiva, riteneva che la conoscenza fondamentale
del mondo, la cosiddetta prisca sapientia, fosse già stata rivelata da Dio
ai primi uomini e incisa su due colonne, riscoperte dopo il diluvio universale
da Pitagora ed Ermete Trismegisto, che ne inglobarono la verità nelle proprie
filosofie esoteriche.
Sono
illuminanti, per la comprensione della reale personalità di Newton, le parole
che pronuncia Keynes nel 1942, in occasione di una conferenza al Royal Society
Club: “Nel diciottesimo secolo, e poi da allora in avanti, Newton prese ad
essere considerato come il primo e il più grande degli scienziati dell’età
moderna: un razionalista, uno che ci insegnò a pensare seguendo i principi del
ragionamento freddo e imparziale. Io non lo vedo in questa luce. Credo che
nessuno di coloro che hanno meditato sui materiali contenuti in quella cassa,
da lui stesso riempita quando lasciò Cambridge nel 1696 – materiali che,
sebbene in parte dispersi, sono giunti fino a noi – possa considerarlo in quel
modo. Newton non fu il primo scienziato dell’età della ragione. Piuttosto fu
l’ultimo dei maghi, l’ultimo dei babilonesi e dei sumeri, l’ultima grande mente
soffermatasi sul mondo del pensiero e del visibile con gli stessi occhi di
coloro che cominciarono a costruire il nostro patrimonio intellettuale poco
meno di diecimila anni fa.”
In
realtà, Newton e altri grandi della scienza animano un momento storico che
credo vada analizzato attentamente per comprendere quanto sia stato importante
l’influsso dell’alchimia e, più in generale, delle dottrine esoteriche nella
nascita della scienza moderna, la fase a cavallo fra il XVI e il XVII secolo.
Questa epoca rappresenta una sorta di cerniera fra il vecchio e il nuovo,
poiché in essa hanno operato uomini impregnati di una cultura scientifica
proveniente dal medioevo e da prima ancora. Questi stessi uomini hanno fondato
la scienza moderna e hanno aperto la porta alla prima grande irruzione
del nuovo pensiero scientifico nella storia del mondo occidentale: la
rivoluzione industriale. E’ questa l’epoca in cui Galileo inizia a tradurre i
fenomeni scientifici in linguaggio matematico, quello che lui chiama “la lingua
di Dio” e, riprendendo l’insegnamento di Leonardo, comincia a rivolgere precise
domande alla natura usando gli esperimenti. E’ l’epoca in cui Francis
Bacon rifonda il ragionamento induttivo aristotelico ripulendolo dalla
sua impostazione dogmatica. E’ l’epoca in cui Newton e Boyle unificano in sé le
idee di Galileo e Bacone e fondano la scienza moderna. Dirà Newton di sé: “Se
io ho visto più lontano è perché mi sono levato sulle spalle di Giganti”.
In
quest’epoca, l’influsso delle correnti iniziatiche ha esercitato un ruolo
fondamentale nello sviluppo del pensiero scientifico, che non può essere
ignorato ma che è ora di iniziare a studiare con grande attenzione.
-
Paolo Maggi - Elogio dell’Induzione… e della
Magia -
Pubblicato da
Nicola Ferraro
alle
11:10
0
commenti
![]()
Etichette: Alchimia, Astrologia, Cabala, Ermetismo, Esoterismo, Filosofia, Massoneria, Simboli
- Raimondo De Sangro e gli Arcana Arcanorum. -
Pubblicato da
Nicola Ferraro
alle
11:02
0
commenti
![]()
Etichette: Alchimia, Esoterismo, Filosofia, Massoneria, Simboli
Iscriviti a:
Commenti (Atom)