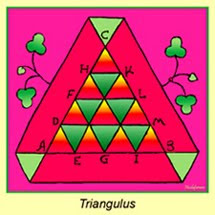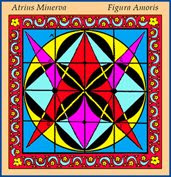30 aprile 2012
Johann Wolfgang von Goethe (Francoforte sul Meno 1749 - Weimar 1832), poeta, drammaturgo, romanziere e scienziato tedesco. Figlio di un funzionario dell'amministrazione imperiale, dal 1765 al 1768 studiò diritto a Lipsia, dove maturò in lui l'interesse per la letteratura e la pittura, e dove conobbe le opere drammatiche di Friedrich Gottlieb Klopstock e Gotthold Ephraim Lessing. La sua prima produzione poetica e drammatica, che risente dell'influenza di questi autori, trasse spunti anche dall'amore per la figlia di un oste, che gli ispirò la commedia pastorale Capriccio d'innamorati (1767). Dello stesso periodo è una tragedia in versi, I complici (1768). Nel 1768, ammalatosi gravemente, fece ritorno a Francoforte e, superata la fase critica della malattia, durante la convalescenza si dedicò a studiare occultismo, astrologia, alchimia. L'amicizia con Susanne von Klettenberg, un'amica della madre, attiva pietista, lo accostò al misticismo religioso. Dal 1770 al 1771 Goethe visse a Strasburgo dove accanto alle discipline giuridiche, coltivò lo studio della musica, dell'arte, dell'anatomia, della chimica.
Prime influenze : A Strasburgo ebbe due incontri che sarebbero stati molto importanti nella sua vita e determinanti per la sua opera letteraria. Il primo fu quello con Friederike Brion, figlia di un pastore protestante, che Goethe amò e che avrebbe fornito il modello per vari suoi personaggi femminili, compreso quello di Margherita nel Faust. Il secondo fu l'incontro con il filosofo e critico letterario Johann Gottfried von Herder con cui strinse amicizia: Herder, fra l'altro, lo portò a sottrarsi all'influenza del classicismo francese, ligio alla concezione aristotelica dell'unità di tempo, di luogo e di azione, cui doveva attenersi la tragedia, e lo introdusse all'opera di Shakespeare, in cui proprio il mancato rispetto delle tradizionali unità contribuisce all'intensità drammatica. Herder, inoltre, indusse Goethe ad approfondire il significato della poesia popolare tedesca e delle forme dell'architettura gotica quali fonti di ispirazione letteraria. Gli insegnamenti di Herder si tradussero nella tragedia Götz di Berlichingen (1773), che Goethe scrisse a Francoforte, dove era tornato una volta conclusi gli studi giuridici. L'opera, che prende a modello Shakespeare, ha come protagonista un cavaliere del Cinquecento, in rivolta contro l'autorità dell'imperatore e della Chiesa, e anticipa i fremiti libertari che sarebbero stati l'anima del movimento Sturm und Drang, antesignano del romanticismo tedesco. Quando nel 1771 si trasferì da Strasburgo a Wetzlar, per fare pratica presso il tribunale, Goethe visse una fase d'irrequietezza sentimentale: nel 1774 dedicò a un amore impossibile il romanzo epistolare I dolori del giovane Werther, che ebbe vasta eco non soltanto sullo sviluppo del romanzo tedesco, ma anche nel mondo letterario del tempo (vi si ispirò Ugo Foscolo, quando nel 1798 scrisse la prima versione delle Ultime lettere di Jacopo Ortis); analoghe ispirazioni pervadono i drammi Clavigo (1774) e Stella (1775). Negli stessi anni, Goethe compose numerosi saggi letterari e teologici, varie liriche, e soprattutto la prima versione del Faust, il cosiddetto Urfaust ("Faust originario").
Gli anni di Weimar : Nel 1775 il diciottenne Karl August, duca di Weimar chiese a Goethe di fargli da precettore. Nel primo decennio a Weimar Goethe dimostrò straordinarie capacità di organizzatore e amministratore, rendendo la piccola capitale un vivace centro culturale dove affluirono alcuni fra i migliori ingegni del tempo, tra cui Herder e Christoph Martin Wieland; inoltre si dedicò allo studio di varie scienze (botanica, mineralogia, osteologia, ottica), continuò a elaborare il Faust, compose la prima stesura della Vocazione teatrale di Wilhelm Meister e iniziò la versione in prosa dell'Ifigenia in Taurine, che avrebbe riscritto in versi nel 1787. A Weimar infine ebbe un'appassionata storia d'amore con Charlotte von Stein, moglie di un ufficiale e donna di grande fascino e intelligenza, che gli ispirò liriche e ballate.
Il viaggio in Italia : Tra i diversi motivi che nel 1786 indussero Goethe a partire per l'Italia vi fu il desiderio di allontanarsi dalla corte di Weimar e da Charlotte von Stein, ma soprattutto la brama di trovare nuovi stimoli e di dare nuovi orizzonti alla sua vena poetica, al contatto dell'arte e della cultura italiana, in particolare di quella classica. Dopo aver visitato le città dell'Italia settentrionale, la Sicilia e Napoli, Goethe si stabilì a Roma dove rimase fino al 1788. Si dedicò con fervore a studiare l'arte, l'architettura e la letteratura della Grecia, di Roma e del Rinascimento, che gli suggerirono forme di mirabile equilibrio per esprimere il fremito e la tensione della passione autentica. Di questo incontro resta affascinante testimonianza Il viaggio in Italia, che venne pubblicato molti anni dopo (1816 e 1829). Risalgono al soggiorno italiano e alle sue suggestioni la versione in giambi dell'Ifigenia in Taurine, i drammi Egmont (1788) e Torquato Tasso (1790); le Elegie romane (1789); gli Epigrammi veneziani (1790) e alcune scene del Faust.
Al ritorno a Weimar (1788) Goethe trovò un'atmosfera ostile nei circoli letterari, mentre a corte mal si accettava la sua relazione con Christiane Vulpius, una giovane che nel 1789 gli diede un figlio e che egli avrebbe sposato nel 1806. Malgrado tutto rimase a Weimar, trattenuto da due motivi d'interesse: la direzione del teatro ducale, che tenne dal 1791 al 1813, e la possibilità di perseguire meglio che altrove gli studi scientifici, cui si dedicò con rinnovato ardore. Risalgono a questi anni vari scritti di anatomia comparata (1784), di botanica (1790) e due volumi di ottica (1791 e 1792). Fu l'amicizia con Friedrich von Schiller a riavvicinare Goethe alla letteratura e dalla loro collaborazione, durata dal 1794 alla morte di Schiller nel 1805, scaturirono numerose composizioni liriche ed epiche, l'idillio in esametri Arminio e Dorotea (1797), il dramma La figlia naturale (1802), la seconda versione del romanzo Gli anni di noviziato di Wilhelm Meister (1796), che avrebbe costituito un modello narrativo per la successiva produzione letteraria tedesca, inaugurando il genere del romanzo di formazione e soprattutto, su incoraggiamento di Schiller, la versione definitiva del Faust (la prima parte fu pubblicata nel 1808).
Gli ultimi anni : Dal 1805 e fino alla morte, Goethe visse anni di intensa creatività. I grandi avvenimenti storici della sua epoca - la Rivoluzione francese, che considerò con un certo sospetto vedendovi non tanto l'espressione di un'istanza di libertà quanto lo scoppio incontrollato di forze oscure e disordinate; la fortuna di Napoleone, che ammirava; gli sforzi per l'unificazione della Germania, considerati con indifferenza, se non con ostilità - trovarono in lui un osservatore attento ma non appassionato. Fra gli scritti di questi anni sono il romanzo Le affinità elettive (1809); Gli anni di pellegrinaggio di Wilhelm Meister (1821, riveduto nel 1829); l'autobiografia Dalla mia vita. Poesia e verità (in 4 voll., 1811-1833); una raccolta di liriche, Divano occidentale-orientale (1819), dai toni mistici ed erotici, licenziosi e ambigui; la seconda parte del Faust (pubblicata postuma nel 1832).
GOETHE E LA NATURA
Il concetto di "natura" rappresenta certamente uno dei grandi temi del Romanticismo, specie di quello tedesco. Infatti l'amore ed il fascino per essa, che affondano le loro radici nel clima culturale dello "Sturm und Drang" e si alimentano della riscoperta del pensiero di Spinoza, costituiscono uno dei dati più caratteristici del movimento. E Goethe non è estraneo a questo influsso. Alla base della concezione goethiana della natura vi è un fondamentale panteismo , che gli deriva dalla lettura di Plotino, di Bruno e di Spinoza, a favore del quale si esprime intervenendo nella cosiddetta 'disputa sul panteismo' tipica di quegli anni. La natura è natura vivente, inizialmente considerata, secondo i parametri dello Sturm und Drang, come un'inesauribile forza primigenia, dalle mille trasformazioni e dai mille volti, compresi quello umano e quello divino. Successivamente, questa visione letteraria si trasforma in una concezione più scentifica, che considera la natura come la sede dell'evoluzione, per complicazione successiva, di un unico fenomeno originario ( Urphänomenon ). Nel suo viaggio in Italia, a Palermo, Goethe credette di aver scoperto la forma della pianta originaria ( Urplanz ): uno stelo dal quale si dipartono i rami e le foglie. La stessa struttura la si ritrova nella costituzione fisica dell'uomo, come colonna vertebrale da cui si diramano gli arti. L'intenzione di Goethe è quella di costruire una morfologia della natura , ovvero uno studio qualitativo delle forme naturali, condotto attraverso l'intuizione e l'osservazione diretta dei 5 sensi: la sua indagine della natura diverge dunque nettamente da quella della scienza moderna (newtoniana), fondata sulla riconduzione dei fenomeni a elementi quantitativi, misurabili matematicamente attraverso procedure sperimentali oggettive. L'avversione di goethe per la fisica newtoniana, improntata al meccanicismo causale, affiora anche nella sua teoria dei colori : servendosi di un prisma di cristallo, Newton aveva scoperto che la luce bianca è scomponibile in raggi ai cui differenti indici di rifrazione corrispondono, nella percezione soggettiva, i diversi colori. Goethe, al contrario, sostiene che la luce è un fenomeno semplice e i colori derivano dalla contrapposizione polare tra chiaro e scuro, cioè tra bianco e nero. Per quanto infondata, la teoria goethiana dei colori si inserisce nella generale tendenza romantica a spiegare i fenomeni naturali come effetti della polarità, cioè a ricondurre la molteplicità delle manifestazioni ad un'unica legge fondamentale della natura. Per Goethe nella Natura non esiste puro divenire, caotico ed anarchico, ma una serie continua di manifestazioni plastiche, attraverso le quali l'Essere si rende percepibile ai nostri occhi. Metamorfosi significa trasformazione, o meglio una serie di trasformazioni in cui una essenza perenne si manifesta via via con modalità esteriormente differenti: la forma, che si concretizza biologicamente nel «tipo», a sua volta, non costituisce una realtà statica, ma una attività plasmatrice, che solo l'occhio esperto riesce a ricondurre all'Unità, attraverso la catena dell'Essere, scorgendo l'Eterno nel transitorio. Che tutto ciò non si sia risolto in una semplice speculazione teorica, ma abbia dato risultati concreti, lo dimostra il fatto che Goethe, seguendo tale paradigma, attraverso «il metodo genetico, il metodo della comparazione anatomica ed embriologica, conosciuto oggi come morfologia comparata», poté conseguire tre notevoli scoperte scientifiche, tuttora valide nella loro essenza: l'origine fogliare delle differenti strutture del fiore: sepali, petali, stami, pistilli; l'origine del cranio da vertebre trasformate; l'esistenza dell'osso intermascellare, o incisivo, nel cranio umano, tanto che la sutura corrispondente, situata tra il canino ed il secondo incisivo, e stata chiamata ufficialmente, in suo onore, sutura incisiva goethei. Goethe è profondamente convinto, sulla scia di gran parte del pensiero romantico, che la natura costituisca un tutto organico, di cui l'uomo è solo manifestazione; l'errore dell'uomo, come già aveva detto Spinoza, sta nel non riconoscere di essere parti del tutto, di questa totalità che è la natura, ma di pretendere di esistere come individualità. Così scrive Goethe a proposito:
' Natura! Noi siamo da essa circondati e avvinti, senza poter da essa uscire e senza poter entrare in essa più profondamente. Non invitati e non avvertiti, essa ci prende nel giro della sua danza e ci attrae nel vortice, finché, stanchi, cadiamo nelle sue braccia. Essa crea eternamente nuove forze: ciò ch'è ora non era ancora, ciò che era non torna; tutto è nuovo, e nondimeno è sempre antico. Noi viviamo nel mezzo di essa, e le siamo estranei. Essa parla incessantemente con noi, e non ci palesa il suo segreto. Noi operiamo costantemente su di essa, e tuttavia non abbiamo su di essa nessun potere. Pare che la natura tutto abbia indirizzato verso l'individualità, eppure non sa che farsene degl'individui. Artista incomparabile, senza apparenza di sforzo passa dalle opere più grandi alle minuzie più esatte. [...] È intera, e nondimeno è sempre incompiuta. Non conosce passato e futuro; il presente è la sua eternità '.
IL FAUST
In quest'opera, che è il suo indiscusso capolavoro, Goethe riprese il soggetto di una leggenda popolare molto diffusa in Germania e che in Inghilterra era già stata soggetto di una rielaborazione teatrale da parte del poeta elisabettiano Christopher Marlowe. La storia ha come protagonista uno studioso, Johann Faust, che, ormai vecchio, tentato dal demonio Mefistofele, vende la propria anima in cambio di giovinezza, sapienza e potere. Ora Faust, onnipotente, può disporre delle sorti altrui: porta alla follia e alla morte una povera fanciulla, Margherita; poi inizia a esercitare la sua influenza diabolica presso le corti principesche del gran mondo. E benché tutto sembri congiurare alla dannazione di Faust, la pietà divina riconosce il desiderio di bene che è stato all'origine di tanto peccare: la stessa Margherita intercede per Faust, simbolo ormai dell'umanità stessa e del suo cammino verso la redenzione. L'opera, allegoria della vita umana nell'intera gamma delle passioni, delle miserie e dei momenti di grandezza, afferma il diritto e la capacità dell'individuo di voler conoscere il divino e l'umano, la capacità dell'uomo di essere "misura di tutte le cose", e mostra il cammino percorso da Goethe dagli anni inquieti dello Sturm und Drang fino alla compostezza classica delle forme e alla saggezza della maturità. E' il mito della superbia della ragione illuministica, dell'uomo che vuole essere il signore del mondo. Faust è un medico-scienziato, uomo rispettabilissimo, che svolge la sua attività con un aiutante (Wagner). Conosciuto tutto il possibile, Faust si sente insoddisfatto e si rivolge alla magia, che gli si presenta come vero e proprio spirito della magia, incarnato dalla diabolica figura di Mefistofele. Quest'ultimo era già comparso nel 'prologo in cielo' per sfidare il Signore che riuscirà a dannare Faust. Faust e Mefistofele siglano un patto: Faust ottiene la giovinezza in cambio della propria anima. Dopo di che, Faust si innamora della bella popolana Margherita e riesce a conquistarla: ella è indotta da Faust a somministrare un sonnifero alla propria madre per potersi così incontrare con l'amante. Il sonnifero, però, porta la madre alla morte. Margherita, uccisa la madre e anche il proprio fratello (Valentino), commette un altro omicidio: toglie infatti la vita al suo bambino (affogandolo), figlio di Faust, e viene arrestata. Nel frattempo Faust vive con Mefistofele nuove avventure: viene infatti introdotto alla conoscenza dei mondi infernali e condotto ad una Sabba (il concilio di streghe e potenze demoniache). Nell'ultima scena dell'opera la ritroviamo in carcere, in preda a forti allucinazioni: invoca a gran voce il perdono di Dio. Faust, accortosi di quanto sta accadendo, impone a Mefistofele di liberare Margherita, la quale, però, si rivela impaurita dalla figura di Mefistofele: ha colto in tale figura la presenza del diabolico, il male. Margherita viene comunque dichiarata salva da una voce celeste. Questa è la trama generale dell'opera. Due sono le grandi tematiche del Faust: il patto-scommessa e lo Streben (il cercare): Mefistofele sfida Dio, dimostrando che Faust, pur affannato alla ricerca di nuovi ed elevati saperi, è in realtà pur sempre disponibile ad un piacere che proviene dall'abbandono della sapienza. Il Signore tira in ballo il concetto di Streben dicendo che ' erra l'uomo finchè cerca '. La parola 'streben' caratterizza il protagonista, il suo continuo sforzo di superare i limiti, di non appagarsi mai in nessuna situazione; rappresenta anche lo spirito della borghesia, la sua forza innovativa e rivoluzionaria. Faust, nel primo prologo, è disperato: il sapere cui è pervenuto non gli permette di conoscere l'intima essenza della Natura (tema sentitissimo in Goethe) e decide dunque di darsi alla magia, evocando Mefistofele. Faust è salvato in extremis dal suicidio: sente la campane della pasqua e la gioia che da esse deriva. In Faust, va sottolineato, convivono due anime in contrasto: la prima tende al potere-sapere, l'altra ad un legame con il mondo.
27 aprile 2012
- Intuizione e ragione
A tutto ciò che ci capita di contemplare con compiacimento, provando il cosiddetto piacere estetico, siamo soliti dare il nome di Bello, senza chiederci troppo sottilmente che cosa esso sia realmente. Eppure la nozione di Bello ha intrigato i pensatori fin dall'antichità; i quali peraltro, più che interrogarsi sulla sua natura, sembravano essere soprattutto interessati a scoprire se tale nozione esista solo nel nostro spirito oppure sia un’Idea assoluta indipendente da noi; e a tali domande hanno risposto in maniera diversa a seconda che fossero idealisti o realisti, con un approccio simile a quello assunto di fronte al problema del Vero o del Bene. Mi pare utile un brevissimo excursus su come sia stato elaborato il concetto di Bello nella storia, chiedendo preventivamente venia agli esperti per le eventuali inesattezze.
E' noto che per Platone la Bellezza esiste in sé, del tutto indipendente dal nostro spirito, nel perfetto "mondo delle idee" che potremo conoscere solo dopo la morte; ogni forma sensibile di Bellezza che si può ammirare sulla terra non è che imitazione imperfetta dell'Idea di lassù; per il neoplatonico Plotino, la Bellezza coincide addirittura con la Verità e con Dio. Baumgarten, nel '700, fu il primo a considerare l'attività estetica come attività autonoma e a valorizzare la conoscenza sensibile come dotata di una propria validità conoscitiva, indipendente dalla conoscenza logica, unificando nella sua Estetica il Bello dell'arte ed il Bello naturale, che da questo momento sembrano venir considerati senza distinzione. Nella sua "rivoluzione copernicana" Kant sostiene che il Bello, al pari del Buono, è un giudizio aprioristico, quindi non esiste al di fuori di noi; ma, piuttosto che spiegarne la natura e le origini, si dilunga sui suoi attributi ed effetti: diversamente dal Bene, che ha in sé una norma finalistica dettata dalla morale, il Bello è causa di un godimento necessario e universale, del tutto disinteressato. Per l'idealismo, e per Hegel in particolare, la conoscenza del Bello è il primo momento di quella autocoscienza dello Spirito Assoluto che trova la sua autentica e totale realizzazione solo nella filosofia. Anche per Croce l'intuizione estetica è un atto originario dello spirito, carico dunque d'una sua intrinseca necessità, ma, perfezionando l'idea kantiana dell'a-priori, precisa che l'intuizione prende forma ed espressione compiuta solo per il tramite di un linguaggio (codice di simboli) che plasma un materiale fisico (marmo, colori, suono, parola ecc).
Come si vede, l'estetica e la linguistica hanno finito per coincidere, poiché è solo la formulazione linguistica ciò che dà espressione compiuta all'intuizione, ciò che permette non solo di veicolare ai propri simili le immagini che si hanno del mondo, ma addirittura di farle esistere consapevolmente nella stessa mente di chi le ha concepite; tutto il resto circola nell'inconscio sotto specie di oscure ed informi pulsioni istintuali incomunicabili, il cosiddetto sentimento, cui, quando affiora per la prima volta consapevolmente nella mente, si è soliti dare il nome ambiguo di intuizione. L'ambiguità di questo termine risiede nel fatto che in realtà il materiale conoscitivo può trovarsi nella mente soltanto in due stati, corrispondenti a due tempi cronologicamente distinti: o in quello informe e confuso di sentimento di benessere o malessere che precede la sua formulazione (ed è per conseguenza inconoscibile dalla ragione), oppure in quello immediatamente successivo alla sua formulazione, per cui è potuto emergere alla superficie della coscienza e diventare conoscibile. Questa ambiguità è il punto di partenza delle nostre presenti riflessioni.
Prima di tutto, se è vero che il linguaggio è lo strumento che consente di dar forma ed espressione compiuta a ciò che si sente confusamente dentro, sembra evidente che i concetti di espressione e di formulazione debbano valere anche oltre il fatto estetico e costituiscano anzi una caratteristica generale di tutta la linguistica e la comunicazione, quando questa segua le vie comuni e non sia paranormale o telepatica; anche quella dunque del pensiero razionale e scientifico creativo, dato che anche questo viene formulato e comunicato come espressione compiuta di confusi contenuti, anche questi chiamati solitamente intuizioni, provenienti dai meandri della mente che li ha concepiti. Insomma, tutti i contenuti cui diamo espressione mediante un linguaggio diventano – attraverso questa operazione di formulazione – razionali, dato che il linguaggio è per definizione una sintassi ordinatrice razionale, oggettiva e universale, comune a tutti gli uomini.
Ma se il linguaggio è una sintassi ordinatrice delle oscure pulsioni che premono dentro di noi per uscire alla luce della coscienza, siano esse o no di natura estetica, non è possibile che la formulazione linguistica sia presente e attiva solo nell'atto creativo; lo stesso meccanismo sintattico dev'essere necessariamente funzionante sia nella trasmissione come nella ricezione, quindi anche in ogni atto puramente conoscitivo: la conoscenza consapevole di una porzione del mondo non è infatti che la creazione nella nostra mente di un'immagine linguistica di esso, una rappresentazione razionale ottenuta dando forma ed espressione ai dati grezzi ed informi che i sensi ci forniscono dall'esterno stimolandone l'elaborazione a livello di coscienza, cioè la formulazione mediante una sintassi linguistica razionale. Si può dire dunque che ogni atto conoscitivo cosciente, che siamo abituati a considerare passivo, sia invece sempre un atto creativo, indistinguibile – come aveva capito Baumgarten – da quello cui siamo soliti dare il nome di espressione artistica, sia essa opera poetica, pittorica o altro. Prendere infatti conoscenza e coscienza di una persona, di un luogo, di un fatto, significa vagliare e organizzare razionalmente i materiali sensibili che ci giungono, creando un'immagine ordinata e soddisfacentemente coerente, quale è per noi la rappresentazione di quella persona, di quel luogo, di quel fatto. A questa forma di conoscenza, che produce un piacere estetico o comunque una soddisfazione simili a quelli della creazione artistica, ho già avuto più volte occasione di dare il nome di rappresentazione estetica della realtà .
Per quanto ciò possa suonare sgradito, vuoi agli scienziati che si credono depositari della verità, vuoi ai poeti che non ammettono contaminazioni con la logica e tanto meno con la scienza, si dovrà accettare la conclusione che ogni attività conoscitiva – sia essa estetica, logica, o scientifica – dipende da un medesimo processo mentale, comune a tutte le attività dello spirito, la creazione artistica come anche la semplice contemplazione cosiddetta "passiva" dell'opera d'arte. A questo punto dovrebbe essere chiaro che le inveterate distinzioni fra conoscenza intuitiva e conoscenza logica sono prive di significato; infatti, non appena si crede di avere un'intuizione, cioè non appena se ne ha consapevolezza, essa cessa ipso facto di essere intuizione e diventa, attraverso la formulazione cosciente – che è sempre linguistica – conoscenza logica e razionale. Esistono solo due mondi: quello dell'inconscio (inconoscibile e incomunicabile) e quello della coscienza (verbale, quindi conoscibile e comunicabile). L'intuizione, dunque, come atto conoscitivo consapevole, non esiste in realtà nemmeno allo stato nascente. Perfino i sogni esistono solo come immagini-sensazioni inesprimibili; quando da svegli si cerca di descriverli, dobbiamo fatalmente assoggettarli ad una operazione di organizzazione verbale assolutamente razionale. Purché si tenga presente questa realtà, si potrà continuare ad usare nella pratica quotidiana il termine intuizione per nominare quello stato nascente, più teorico che reale perché occupa un tempo fisiologico solo virtuale, quello in cui la mente lavora per trarre dall'inesprimibile l'immagine linguistica che cerca.
Probabilmente, la confusione che da sempre è stata fatta fra conoscenza intuitiva e conoscenza logica è stata, fin dal suo nascere, di tipo... "corporativo", in quanto ciascuna di esse faceva capo a delle "lobbies" che si sono sempre guardate in cagnesco: da una parte, quella dei vati e dei poeti che più o meno si dicevano ispirati dalla divinità; dall'altra, quella dei solidi pensatori razionalisti asserragliati nella loro torre d'avorio. Ognuno sventolava la propria bandiera, chi dell'intuizione e chi della logica, per potersi tenere ben distinto dal "rivale" e salvare la propria identità e il proprio onore.
Veniero Scarselli
Pubblicato da
Nicola Ferraro
alle
16:01
0
commenti
![]()
Etichette: Ermetismo, Esoterismo, Filosofia, Massoneria, Simboli
18 aprile 2012
- L’esoterismo di René Guénon
Per la serietà e la sicurezza delle vedute, per una preparazione veramente particolare in fatto di tradizioni religiose, miti e simbolismi e specialmente di dottrine orientali, per una costante cura nell’affrontare tutti i dettagli pur mantenendo sempre un punto di vista di sintesi, l’opera del Guénon non è da paragonarsi a quella di altri che hanno trattato problemi consimili.
La posizione del Guénon è una posizione di blocco. Si tratta di accettare o meno un dato sistema di riferimento: ma aderendovi è difficile non seguirlo nelle deduzioni che ne trae.
I vari libri del Guénon obbediscono ad un piano prestabilito, che essi vanno ordinatamente svolgendo, il compito iniziale è puramente negativo e se ne può chiarire il senso come segue. Chiuso nella tenaglia del materialismo, l’Occidente negli ultimi decenni è stato preso da un èmpito confuso verso qualcosa di «altro», non sapendo però giungere che a forme equivoche, superstiziose e inconsistenti le quali, contraffacendo la vera «spiritualità», hanno costituito, alla fine, un pericolo altrettanto reale quanto quello del materialismo contro cui erano partite. È così che il Guénon, per primo, ha creduto opportuno prendersela con i «neospiritualismi» più in voga, eseguendone una demolizione sistematica e, a nostro avviso, salutare.
Primo a cadere sotto i suoi colpi è stato lo spiritismo. Il suo libro L’Erreur Spirite, del 1923, merita veramente di esser letto, perché in nessun altro si trova una mise au point del genere. Bisogna, a questo proposito, comprendere l’attitudine del Guénon: egli non contesta la realtà dei fatti, ritenendosi anzi fondato ad ammettere molto più di quel che non possa qualsiasi spiritista. Quel che egli afferma, conformandosi all’opinione di chi, come gli Orientali, pur tuttavia erano così addentro in fatto di fenomeni psichici – quel che egli afferma è che tali fatti (medianità, ecc.) non hanno nessun valore spirituale; che ogni interesse extrasperimentale per essi è malsano e incentivo di degenerescenza; che l’ipotesi spiritica oltre che arbitraria, è in sé stessa contraddittoria e che è soltanto aberrante la pseudoreligione che in certi ambienti ne deriva. Spiragli oltre il «normale» possono pur aprirsene, ma con ben altri metodi e con ben altra attitudine interiore, se si deve parlare di «spiritualità».
Il secondo colpo cade sulla teosofia anglo-indiana e le sue derivazioni più o meno «occultistiche», per le quali vien proposto il termine di «teosofismo» (Le Théosophisme. Histoire d’une pseudo-réligion, 1921). Il Guénon si dimostra terribilmente informato di tutti i retroscena privati del movimento. Simultaneamente, se pur non sistematicamente (e per questo il primo volume è migliore), egli si dà a mostrare quanto, nel teosofismo, si risolva in una morbosa divagazione di menti confuse, mista a singolari travisamenti di dottrine orientali per opera dei peggiori pregiudizi occidentali. Ed anche qui, come l’antispiritismo del Guénon, non vuol dire filisteismo materialista, ma proprio il contrario, così pure il suo antiteosofismo parte unicamente dal bisogno di difendere certe posizioni e dottrine spirituali e tradizionali a cui lo stesso teosofismo vorrebbe rifarsi, non giungendo invece che a delle contraffazioni più dannose.
Ma l’opera negativa del Guénon non si arresta a tanto. Dopo le velleità «neospiritualiste» ecco che l’intera cultura dell’Occidente diviene l’oggetto dei suoi attacchi (Orient et Occident, 1924; La crise du monde moderne, 1927; ed anche: Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues, 1921). Più semplicemente, si tratta di ciò a cui l’Occidente ha dato luogo partendo, ad un dipresso, dall’Umanesimo e dalla Riforma. Guénon non esita a riconoscere la perversione più completa di ogni ordine ragionevole di cose. Per chi voglia seguire il Guénon, qui il terreno comincia a farsi difficile, perché difficile, per i più, è il rendersi conto del punto di riferimento assunto dall’ autore.
Il Guénon sostiene che la causa della crisi del «mondo moderno» risiede principalmente in un perduto contatto con la «realtà metafisica» e nel conseguente estinguersi di tradizioni che avessero il deposito di un corrispondente corpus di principi di valori e di insegnamenti.
Per la comprensione del termine «realtà metafisica» come l’usa Guénon, è d’uopo retrocedere a dottrine «premoderne» e «superare», nell’opinione della moderna filosofia: alla scolastica, per esempio, o a Plotino o alle grandi scuole speculative orientali. Di là da tutto ciò che è spaziale e temporale che è soggetto a cangiamento, che è intriso di particolarità, di individualità e di sensibilità, esisterebbe un mondo di essenze intellettuali, ma non come ipotesi o come astrazione della mente, sibbene come la più reale delle realtà. L’uomo potrebbe «realizzarlo», cioè averne un’esperienza diretta così certa, come quella datagli dai sensi fisici, quando riesca ad elevarsi ad uno stato «soprarazionale» di «intellettualità pura», cioè ad un atto trascendente dell’intelletto scisso da ogni elemento propriamente umano, psicologistico, affettivo-soggettivo e così pure «mistico» e individualistico; ed è in relazione a ciò, e non nel riferimento ad una speculazione filosofica, che viene usato il termine: «metafisico».
Cose, come ognuno vede, tutt’altro che nuove. Ma il Guénon a priori si dichiara avversario irriducibile di tutto ciò che è «nuovo» e «moderno»; e nell’idea che l’esser «originale» e «personale», anzi che l’esser vera, decida dell’importanza di una dottrina, egli accusa una delle più singolari deviazioni della mentalità contemporanea.
Dal contatto con la «realtà metafisica» l’uomo, come si è detto, ricaverebbe un insieme di principi, che renderebbero possibile una visuale non-umana per considerare e ordinare le cose umane: avrebbe dei punti fermi, da cui per adattazione ai vari piani potrebbero esser dedotti principi per conoscenze particolari e varie, ma sempre ordinate «gerarchicamente» intorno ad un asse unico sovrannaturale. Questo, per il Guénon, sarebbe stato il carattere delle «scienze tradizionali» conosciute negli antichi cicli di cultura, in opposto alle scienze moderne, induttivo-esterioristiche, particolaristiche, prive di un punto unitario di riferimento, incapaci di conoscere oltre che di «sapere», puramente «profane».
D’altra parte, trasportata sul piano dell’azione, la «conoscenza» relativamente alla «realtà metafisica» darebbe dei punti di vista superiori, dei principi per dirigere gli interessi terreni, per inquadrare le attività mondane, per prolungare, insomma, la «vita» in qualcosa che è più che «vita».
E a questa seconda applicazione non va dato un valore puramente ideale o contrappuntistico: ciò che non comincia né finisce nell’elemento «uomo», proietta dei precisi rapporti di distinzione e di «dignità» nelle forme di vita; e così nasce la possibilità di quella «gerarchia», che antiche organizzazioni sociali conobbero: nell’India, nell’Estremo Oriente, anche nei centri paleomediterranei sino a quel medioevo cattolico-feudale al quale il Guénon, rivendica uno speciale significato di valore. Invece che un gioco di forze esterne, sarebbe dunque stata l’azione universale e, diciamo così, «catalittica» della «conoscenza metafisica» a instaurare simili strutture d’ordine sin nella vita concreta e politica. Per la sua natura non-umana, una tale «conoscenza» avrebbe un carattere universale, di una universalità concreta basata sopra un’esperienza trascendente, ripetiamolo, e non astratta o comunque razionale. E come secondo antiche teorie, la potenza del fuoco esisterebbe sempre e ubiqua, per quanto non si manifesti visibilmente che quando siano presenti dati determinismi e ora sotto questa o quella forma contingente, così pure la conoscenza metafisica avrebbe per sue manifestazioni il corpus degli insegnamenti di varie tradizioni e religioni, varie secondo il tempo e il luogo, ma pure riconducibili all’«invariante» di una Tradizione unica o «primordiale», espressione, questa, da prendersi però non in senso temporale e storico, ma in senso metafisico e spirituale.
Dall’Umanesimo in poi, il Guénon vede costituirsi una cultura «involutiva» in quanto basata unicamente sull’«umano». Sono le facoltà razionali che prendono il posto dell’«intellettualità pura»: l’astrazione filosofica si sostituisce alla conoscenza metafisica, l’immanenza alla trascendenza, l’individuale all’universale, il movimento alla stabilità, l’antitradizione alla tradizione. Simultaneamente il polo materiale e pratico della vita si ipertrofizza, si ispessisce, prende la mano su tutto il resto. Nuove manifestazioni dell’«umano», il moralismo, il sentimentalismo, l’esaltazione dell’«io», dell’incomposto agitarsi (attivismo), della tensione senza luce («volontarismo») balenano dappertutto nel mondo moderno, fra una completa mancanza di «principi», fra un caos sociale e ideologico, fra una contaminazione mistica della «vita» e del «divenire» che batte il ritmo ad una specie di corsa verso l’abisso, sotto il cielo arimànico di una grandiosità puramente meccanica e materialistica. E dall’Europa il male si estende altrove come una nuovissima barbarie: l’antitradizione insinua dappertutto il suo standard of living, «modernizzando» quelle civiltà che, come l’Islam, l’India e la Cina, sia pure in lontani riflessi ancora conservano valori dell’altro ordine. Onde – giustamente, a parer nostro – il Guénon dice contro Massis che, se mai, non di un «pericolo orientale» per l’Occidente, bensì di un «pericolo occidentale» per l’Oriente si deve parlare. E gli scatti di reazione, si è visto già dove conducono, in Occidente: sono le deviazioni neospiritualistiche e spiritistiche che esse stesse, riflettono la tirannia delle facoltà infraintellettuali e l’incomprensione per una realtà che si può esser talvolta mostrata, per spiragli luciferinamente socchiusi. E quand’anche non si tratti di teosofismi, spiritismi e simili, la stessa riviviscenza cristiana in sette e in «ritorni» è la più lontana di tutto dal senso di quel severo contenuto di conoscenza ascetica e simbolica, che attraverso il cristianesimo, potrebbe condurre ad un rinnovato contatto con la «realtà metafisica» e con la «Tradizione», al titolo di una liberazione e di una reintegrazione dell’io.
Il panorama dell’«età moderna» si presenta dunque al Guénon in modo non troppo luminoso. Né egli ammette transazioni: dice no allo spirito occidentale preso in blocco e dubita che si sia ancora in tempo per arrestare la corsa che forse già precipita verso un epilogo di catastrofe. Ad ogni modo, a ciò si richiederebbe anzitutto formare delle élites, nelle quali si ridesti il senso della realtà metafisica. Ma fra queste élites (che, fra l’altro, potrebbero già esistere, più o meno fra le quinte) e le grandi masse della società moderna, come si può pensare che si stabilisca una comunicazione? E allora, anche fatto questo passo, la «Tradizione», in senso grande, non resterebbe nuovamente un problema?
Il tentativo di partire da una delle tradizioni ancora esistenti e da là procedere per «integrazione», forse avrebbe migliori possibilità. A questo riguardo, lo sguardo del Guénon si è portato sul cattolicesimo. Egli, come si è detto, ritiene che, più di ogni altra, la tradizione cattolica abbia avuto in Occidente il deposito della «Tradizione primordiale»: deposito anzitutto ricevuto in una forma religiosa e poi, al giorno d’oggi, passato allo «stato latente» come corpo di simboli e di dottrine, nella cui comprensione non entra ormai niente più di metafisico. Occorrerebbe invece che nel cattolicesimo si formasse una élite capace di tanto; e alla reintegrazione, secondo il Guénon, potrebbe servire la conoscenza di dottrine orientali che, come quella vedantina di cui il Guénon ha dato una buona esposizione: L’homme et son devenir selon le Vedanta, 1925, conserverebbero tuttora l’insegnamento «ortodosso» in una forma più pura e più metafisica. Allora il cattolicesimo potrebbe rianimarsi e costituirsi come un principio positivo contro la crisi del mondo moderno.
Quanto siano chimeriche speranze del genere, qui non staremo a rilevarlo: e il Guénon lascia quasi comprendere una certa sua delusione dopo certe «esperienze» personali in proposito. Ma, in ogni caso, resterebbe questo problema: sino a che punto lo stesso cattolicesimo, anche così reintegrato, si può pensare che possa riorganizzare nell’unità di una Tradizione universale il mondo moderno? Come «base», non bisogna illudersi: il cattolicesimo ormai è estraneo al centro del mondo moderno: ed anche là dove ancora domina, il suo dominio è tutto in superficie e non impedisce che la direzione principale della vita e degli interessi miri a tutt’altra cosa, sia laica e antitradizionale.
Diciamo di più: la stessa comprensione della realtà metafisica, come il Guénon la presenta, è tale da essere essa stessa in contrasto con lo spirito dell’Occidente non pure post-umanistico, ma altresì classico, nordico-germanico, ellenico; onde il Guénon deve forzatamente vedere una via senza uscita e ridursi ad un verdetto di condanna privo di effetti. Tuttavia ci si può chiedere: il modo con cui il Guénon concepisce il metafisico è forse l’unico possibile e legittimo?
Qui siamo al punto fondamentale ove la cinta di difesa del Guénon lascia una zona scoperta. Si è che il termine di «intellettualità pura» usato dal Guénon per l’organo della «conoscenza metafisica» cela un equivoco, anzi un paralogismo, perché effettivamente esso vuol dire «realizzazione» e ogni «realizzazione» comprende due aspetti, due possibilità che sono: azione e contemplazione. Il Guénon surrettiziamente identifica il punto di vista metafisico con quello in cui la contemplazione domina sull’azione, laddove è di uguale dignità l’altro, in cui l’azione invece domina sulla contemplazione e viene a fornire essa stessa una via e una testimonianza della trascendenza, così come nelle tradizioni di sapienza eroica degli kshatriya (guerrieri) conosciute dallo stesso Oriente, se pure in frequente contrasto con quelle più predominanti dei brahmana, alle quali si rifà l’attitudine del Guénon. Ma dal punto di vista brahmano, l’antitesi con l’Occidente si fa aspra ed irriducibile, perché lo spirito dell’Occidente ha appunto una tradizione essenzialmente guerriera, epperò rivela possibilità di latenti vie di reintegrazione solamente quando gli si vada incontro partendo dai principi e dalla comprensione del metafisico che sono propri ad una sapienza guerriera: e quei valori occidentali, come quelli dell’affermazione individuale, della pluralità, della libera iniziativa e dell’immanenza, più che negazione, apparirebbero come elementi allo stato materiale da elevare ad un piano spirituale, secondo l’anima di una tradizione veramente occidentale, cioè guerriera.
Si può dunque dire che l’opera del Guénon è positiva nella sua parte negativa e negativa nella sua parte positiva, perché qui la sua leva manca del punto d’appoggio necessario per poter agire su quella realtà, su cui vorrebbe agire. È invece comprendendo la radice guerriero-eroica che tuttora sta dietro alle forme oscure del mondo moderno e mostrando per quale via si possa liberarla da tale piano e condurla a riaffermarsi in un ordine superiore – quelle antiche tradizioni, in cui l’Eroe, il Signore e il Re apparivano simultaneamente come portatori di valori e di influenze non-umane potrebbero, a questo proposito, insegnarci più di una cosa – che si può giungere in Occidente a qualcosa, più che ad una sterile negazione, che ne disconosce la fisionomia.
A Guénon resta comunque il merito di aver affermata la necessità del ritorno ad un punto di vista «non-umano» nel senso più integrale, chiaro e virilmente ascetico e soprarazionale del termine: giacché questo è il principio, ciò che, anzitutto, importa e senza di cui il problema dello spirito moderno sarebbe condannato a rimanere tale.
Julius Evola
Pubblicato da
Nicola Ferraro
alle
20:51
0
commenti
![]()
Etichette: Ermetismo, Esoterismo, Filosofia, Massoneria
14 aprile 2012
- Mircea Eliade esoterico
La casa editrice “Settimo Sigillo” di Roma ha da poco pubblicato un libro, Mircea Eliade esoterico, che credo farà discutere parecchio. Più in particolare, i contenuti del volume potranno essere apprezzati e dibattuti dagli studiosi di storia delle religioni e dai cultori di studi tradizionali. L’autore, Marcello De Martino, docente di Lingua e Letteratura latina presso l’Università di Harvard, nelle pagine in questione, mette a frutto pienamente la propria specifica preparazione accademica, ma mostra, altresì, di essere attento esegeta di tematiche storico-religiose e di storia dell’esoterismo, in particolare delle sue correnti novecentesche. L’autore, mosso, peraltro, da un particolare gusto per l’ambito artistico letterario, riesce a proporci una ricostruzione significativa della biografia intellettuale di Eliade, il grande storico delle religioni romeno, facendo chiarezza, finalmente, sui suoi “non detti” che, come ben sa l’avveduto lettore, riguardano i rapporti con il tradizionalismo e le scelte politiche giovanili a favore del Movimento Legionario della “Guardia di ferro”, capeggiato da Corneliu Zelea Codreanu. L’importanza del libro è da individuarsi nel fatto che pone fine alla vexata quaestio, inaugurata in Italia nel 1973 da Furio Jesi, dapprima nella voce “Mito”, da questi redatta per l’enciclopedia Isedi e, successivamente, ripresa nelle pagine del suo Cultura di destra, relativa alla prossimità di Eliade alle posizioni della Destra tradizionale. A parere di Jesi, il pensatore romeno, tanto nelle opere scientifiche, quanto nella vasta produzione letteraria, avrebbe mostrato la sua aderenza alla cultura della “Bachofen Renaissance” degli anni ‘20, accettando, fino in fondo, la sostanzialità del mito. In questa prospettiva, attribuendo sostanza metafisica ai racconti mitologici, Eliade avrebbe aderito a una sorta di mistica della morte, in grado di spiegare la sua adesione al movimento dell’estrema destra romena.
Il libro di De Martino conferma la prossimità di Eliade agli autori della tradizione come Evola, Guénon, Coomaraswamy ma inverte di segno il giudizio di Jesi. In qualche modo, nella descrizione e nella elaborazione del giudizio sul mondo arcaico, vera e propria pars construens dell’opera di interprete delle religioni, Eliade è debitore alla visione del mondo prodotta dai pensatori della tradizione e dagli esoteristi. De Martino dimostra tutto ciò, alla luce di una documentazione ineccepibile: traduce direttamente dal romeno i testi eliadiani, in particolare quelli diaristici e letterari nei quali l’autore, come si comprende facilmente, era libero dai vincoli scientifici dell’accademia e poteva esprimersi direttamente, innanzitutto sul proprio mundus imaginalis, cosa che si evince dai romanzi, nonché sui propri interessi, letture e frequentazioni, cose che si desumono, compiutamente, solo dalle pagine diaristiche. Inoltre, il libro presenta l’iter formativo di Eliade, dal periodo giovanile a Bucarest, durante il quale all’università fu suo maestro Nae Ionescu che ebbe, in quanto metafisico e Guardista, un ruolo centrale nella formazione del giovane, al periodo parigino: è nella capitale francese che il pensatore romeno frequenta casa Hunwald, dove incontra, tra gli altri, Eugène Canseliet, considerato negli ambienti degli esoteristi europei l’unico discepolo di Fulcanelli, grazie al quale matura l’interesse eliadiano per l’ermetismo e l’alchimia. Ed è sempre a Parigi che Eliade, a contatto con i surrealisti di Breton e Daumal che, come si sa, avevano propensione per l’introspezione psicologico-onirica, ma anche per le variazioni degli stati di coscienza studiati e realizzati dalle correnti esoteriche, sviluppa quella concezione alla luce della quale la letteratura svolge, per l’uomo contemporaneo, la stessa funzione che, nel mondo tradizionale, era svolta dal mito: la lettura come momento ritualmente propedeutico al recupero del tempo delle origini. E’ questa tesi eliadiana a spiegare l’esegesi esoterica della Finnegans Wake di Joyce, oltre che la passione per Inferno di Strindberg e Séraphita di Balzac, che De Martino ci propone: per lo storico delle religioni l’opera dell’irlandese era, nei suoi effetti, comparabile ai miti australiani del Tempo del Sogno (non casualmente crediamo, riproposti negli ultimi anni da Bruce Chatwin in forma romanzata), in quanto riposizionavano il lettore nel tempo mitico. L’apparente banalità dei personaggi di Joyce e il loro insensato e giornaliero peregrinare, rappresentano la trasposizione contemporanea di quanto significato negli antichi miti dei popoli australi. Eliade, su quest’argomento, si esprime molto semplicemente: “Noi ci meravigliamo e ammiriamo, proprio come gli australiani, che Leopold Bloom si fermi in un bar e ordini una birra” (p. 138).
Vengono, inoltre, analizzati e approfonditi in appositi capitoli, le relazioni che lo studioso romeno intrattenne nonchè le influenze intellettuali che ricevette nel periodo indiano, durante la permanenza, dapprima, presso Dasgupta e, successivamente, presso il guru Swami Shivananda. In India, lo studio e la pratica dello yoga, conducono Eliade a incontrare il tantrismo, della qual cosa ci rendono edotti le pagine di Notti a Serampore, di La luce che si spegne, nonché quelle de Il Segreto del dottor Honigberger, romanzi che manifestano come l’interesse del romeno non fosse semplicemente scientifico ma realizzativo. Altro momento significativo di questa biografia intellettuale è da individuarsi nell’incontro ad Ascona con Olga Frobe-Kapteyn e, soprattutto con Jung. De Martino si sofferma ad analizzare le pagine di diario di Eliade in cui questi annotò dei sogni lucidi avuti ad Ascona, che lo studioso stesso interpretò come sogni sciamanici, divinatori, dai quali sarebbe emersa la corrispondenza psiche/realtà teorizzata da Jung. Si tratta della scoperta del tema della sincronicità del tempo, che renderebbe possibile la divinazione. Di essa Eliade tratta, ancora una volta, nelle pagine di un romanzo, L’indovino delle pietre. Insomma, dalla lettura complessiva dell’opera letteraria di Eliade, supportata da molte pagine di diario e dall’epistolario, emerge chiaramente, come sostiene De Martino, che indubitabilmente lo studioso romeno possa essere definito esoterico. Nelle opere scientifiche, questo legame con la cultura “segreta” e i suoi maestri, è meno evidente, sempre ben celato dalla prudenza accademica che fino agli ultimi giorni condizionò tanto lui, quanto il suo discepolo Culianu. Questi, comunque, seppe la verità su tali temi, sia per la prossimità di vita, almeno per un certo periodo, con il maestro, sia per gli studi che, a seguito della pubblicazione della bio-bibliografia su Eliade, aveva condotto sulla storia della Romania tra le due guerre. Probabilmente, dopo la morte del maestro, se non fosse stato brutalmente assassinato in circostanze misteriose all’Università di Chicago, avrebbe potuto chiarire, fino in fondo, il caso Eliade.
Comunque, va fatto rilevare, solo una volta, nell’opera scientifica del pensatore danubiano, si fa diretta professione di vicinanza all’esoterismo: si tratta dello scritto del 1937, Il folclore come strumento di conoscenza. Chiunque legga questo testo può rendersi conto di come lo studioso credesse, tra l’altro, possibile l’acquisizione di “poteri”, in grado di concedere un controllo magico sulla realtà. Il libro che stiamo analizzando è una vera miniera di informazioni sulla cultura del Novecento, più in particolare su quella tradizionale. Abbiamo pertanto scelto, tra i molti percorsi di lettura possibili, di spendere qualche parola in più sul rapporto Eliade-Evola. Innanzitutto, De Martino dimostra, ponendosi sulle tracce di Culianu, che il personaggio indicato dalle lettere J. E., nel romanzo Il segreto del dottor Honigberger, è sicuramente Julius Evola, inoltre, individua in un personaggio del romanzo La luce che si spegne, Manuel, lo stesso esoterista romano: qui, infatti, Manuel si fa propugnatore di un idealismo magico che ha, come De Martino mette in luce attraverso la comparazione dei testi eliadiani di questo romanzo con quelli filosofici di Evola, prossimità non solo contenutistica ma addirittura espressivo-lessicale con il filosofo dell’Individuo assoluto. Per di più, nelle pagine di diario, diverse volte lo studioso romeno fa riferimento a un saggio da lui scritto nel dicembre del 1928, sulla nave che lo portava da Porto Said a Colombo, intitolato significativamente Il fatto magico, poi andato smarrito: possiamo arguire che questo scritto era di argomento evoliano poiché a esso Eliade fa riferimento nella recensione a Rivolta contro il mondo moderno del 1935, in cui affermava di aver trattato della filosofia magica del tradizionalista ma che, tale studio, era rimasto allo stadio di manoscritto. In ogni caso, Eliade ravvisava nella filosofia magica una struttura logica compiuta, in grado di dar luogo a un sistema filosofico in sé completo. Nella stessa recensione egli scrisse che considerava Teoria e Fenomenologia dell’individuo assoluto: “Il libro più serio sull’Idealismo magico che sia stato scritto fino a questo momento” (p. 269).
Per Eliade è la filosofia di Evola a rappresentare il cuore del sistema di pensiero del romano che, per di più, in quanto idealismo magico, non è in contraddizione con i successivi sviluppi che il pensatore dette alle proprie produzioni intellettuali e al proprio percorso di vita. Per il romeno, come per Evola, il mondo è un dato creato magicamente dall’Io per eliminare la propria insufficienza, mondo che sempre si ripropone come ostacolo, come nuova necessità da superare. Cosa, questa, notata già da Gino Ferretti sulle pagine de L’Idealismo realistico, come puntualmente ricorda lo stesso De Martino. E’ certo che l’aspetto magico è da considerarsi il discrimine che Eliade pose tra il contemplativo Guénon e l’attivo Evola e che, in qualche modo, gli fece valutare più positivamente il contributo teorico-pratico fornito da quest’ultimo. Ma è altresì il medesimo aspetto magico, che emerge dalla lettura che Evola sviluppò dei misteri di Dioniso, intesi a far sì che l’io si imponga in termini divini, ad allontanare, ambiguamente, Eliade da Evola. Infatti se il personaggio Manuel-Evola giunge a sostenere: “ Dio non esiste, occorre che l’individuo lo crei, facendosi divino” (p. 282), Eliade coglie, nelle pagine di diario, proprio in ciò l’aspetto luciferino dell’esoterista romano e attribuisce alle sue pratiche rituali la stessa paralisi che, come si sa, colpì il filosofo al termine del secondo conflitto mondiale.
Lo storico delle religioni, così come emerge dalle stimolanti pagine di questo libro, ci pare un ossimoro vivente che si rapportò alla tradizione spinto da un rapporto di amore – odio. Ciò è spiegabile, certo, come mostrano le lettere che Evola gli scrisse il 15 Dicembre e il 31 Dicembre del 1951, all’interno di un progetto culturale, mirante a introdurre la cultura tradizionale nella cittadella accademica. In quest’ottica l’opera scientifica eliadiana avrebbe svolto la funzione di “cavallo di Troia”, insediatosi oltre le mura nemiche; oppure, quest’ambiguità, potrebbe certamente rinviare alla necessaria prudenza politica cui un personaggio come Eliade doveva attenersi, per ragioni strategiche, all’interno dell’Accademia statunitense, non tenera nei confronti di chi avesse sostenuto pubblicamente, sia pure molti anni prima, la causa dei fascismi europei. Ma in realtà, per noi, la ragione più profonda di quest’ambiguità di fondo, la si evince dai diari. Riportiamo la seguente citazione tra le tante possibili, perché estremamente sintetica e significativa. “di fatto la tragedia della mia vita si può ridurre a questa formula: sono un pagano, un perfetto pagano classico che cerca di cristianizzarsi. Per me i ritmi cosmici, i simboli …. esistono di più e più immediatamente del problema della redenzione” (pp.424-425). Eliade si colpevolizza, alla luce della originaria educazione ortodossa, della sua struttura interiore non cristiana. Questa la lacerazione spirituale che spiega le apparenti contraddizioni rispetto alla filosofia della tradizione, da parte del pensatore. In fondo, egli da sempre interessato a ogni tipo di soteriologia, dall’ermetismo rinascimentale, allo sciamanesimo, allo yoga popolare ha mirato alla realizzazione della coincidentia oppositorum, anche nel proprio percorso esistenziale. La sua esperienza di pensiero ha, a nostro giudizio, il nucleo vitale nella cosmizzazione dell’individuo, e quindi, in definitiva, mette capo a un’antropologia filosofica della tradizione, in grado di restituire vitalità alla staticità di certa scolastica tradizionalista, soprattutto di matrice guénoniana, che non coglie il carattere dinamico dei valori. Eliade, sostiene De Martino, non fa della tradizione una controcultura ma: “introietta il sapere tradizionale in un campo più vasto, e cioè quello lato sensu della Cultura” (p. 384). Merito certamente importante, dal nostro punto di vista, da attribuire allo studioso romeno! In forza di tale posizione, egli capì perfettamente l’inanità dei tentativi iniziatici nella modernità: infatti, l’uomo contemporaneo vive nelle dimensione storica aperta dal giudeo-cristianesimo e, nonostante i nostri sforzi, nessuno di noi, se sincero, non può, parafrasando Croce, non dirsi giudeo-cristiano. Tutti, infatti, siamo immersi nell’orizzonte storico, in esso l’iniziazione può essere attivata casualmente, come capirono Eliade, Jung e ancor prima Neumann, attraverso il “rituale del destino”. È la storia stessa che ci sottopone a prove, a “ordalie” iniziatiche, come fece rilevare Culianu. Una tradizione quella eliadiana che muove, quindi, non dalla preconcetta esclusione del moderno, pur essendo internamente motivata da una tensione ultramoderna, attenta al qui e ora, aperta e colloquiante con la realtà perché cosciente di quanto intuito da un originale interprete della storia contemporanea, che pur di Eliade si interessò, il filosofo Augusto del Noce. Questi ebbe a scrivere: “La linea che oggi propongo intende porsi al di là della posizione modernista come dell’antimodernista. Il moderno e l’antimoderno sono in certa guisa veramente gemelli, così che talvolta riesce difficile distinguere la punta estrema della modernità dell’antimoderno: è il caso di Heidegger” (Modernità, p. 41).
E’ per questa stessa ragione che il libro in questione, propone al lettore una sorta di prossimità tra la tradizione e gli sviluppi della scienza, in particolare della fisica olistica. De Martino affronta i temi sviluppati dalla gnosi di Princeton, ma avrebbe potuto avvalersi, allo scopo, anche del proficuo rapporto prodottosi nel secondo dopoguerra tra Heidegger e Heisenberg. Ed è sempre alla luce delle precedenti considerazioni che Eliade giunse a riconoscere un ruolo privilegiato tra i tradizionalisti a Coomaraswamy, considerato una sorta di antesignano di “scienziato” della tradizione. Personalmente, riteniamo che in tutto ciò si corra il rischio di confondere il sacro con il profano e perciò, a tanto, non ci spingiamo. Pensiamo però che, a chiusa di questa recensione, sia bene riportare due versi di Michelangelo, sui quali Eliade tornò a riflettere molte volte. Essi presentano in poche parole la condizione umana nello stesso senso in cui fu mirabilmente colta da Platone con il concetto di metaxy, in-tra: “Al sole aspira e l’alte torri pianta / Per aggiunger al ciel, e non lo vede”. Conclusivamente, la qualità della tradizione in Eliade è eminentemente platonica, tanto in relazione al tema degli archetipi, come in merito a quelli della gnosi e dell’antropologia. Ma qui il discorso, per dirla con Clavino, si farebbe davvero interminabile.
Giovanni Sessa
Pubblicato da
Nicola Ferraro
alle
19:14
0
commenti
![]()
Etichette: Ermetismo, Esoterismo, Filosofia, Massoneria, Simboli
11 aprile 2012
- DIONISO O LE BEATITUDINI RITROVATE
Epifanie ed occultamenti di un dio "nato due volte"
Dopo più di un secolo di ricerche, Dioniso resta ancora un enigma. Per l'origine, la sua natura, e il tipo di esperienza religiosa cui dà l'avvio, si distingue dagli altri grandi dèi greci. Secondo il mito, è figlio di Zeus e di una principessa, Semele, figlia di Cadmo, re di Tebe. Mossa dalla gelosia, Era le tende un tranello e Semele chiede a Zeus di poterlo contemplare nella sua vera forma di dio celeste. L'incauta viene incenerita, avendo partorito prima del tempo. Ma Zeus cuce il bambino nella sua coscia, e dopo qualche mese Dioniso viene al mondo. È proprio 'nato due volte'. Molti miti delle origini fanno derivare i fondatori di famiglie reali dall'unione tra dèi e donne mortali. Ma Dioniso è nato la seconda volta da Zeus, perciò lui è solo dio. P. Kretschmer ha cercato di spiegare il nome di Semele con il termine traco-frigio Semelo, che indica la dea Terra, e questa etimologia è stata accettata da studiosi di chiara fama come Nilsson e Wilamowitz. Ma tale etimologia, sia o non sia corretta, non aiuta affatto nella comprensione del mito. Innanzitutto è difficile concepire uno hieros gamos tra il dio celeste e la Terra Madre che si concluda con la combustione di quest'ultima. D'altra parte, e questo è il punto essenziale, le più antiche tradizioni mitologiche insistono sul fatto che Semele, mortale, abbia generato un dio. Era proprio questa dualità paradossale di Dioniso a interessare i greci, perché essa sola poteva spiegare il paradosso della sua natura. Nato da una mortale, Dioniso non apparteneva di diritto al pantheon degli dèi olimpici; ma riuscì, nonostante questo, a farvisi accettare e alla fine ad introdurvi anche sua madre Semele. Omero lo conosceva, come dimostrano molti accenni nelle sue opere, ma né il rapsodo né il suo pubblico s'interessavano a questo dio ‘straniero', così diverso dagli Olimpî. È stato tuttavia proprio Omero a trasmetterci la testimonianza più antica su Dioniso. Nell' Iliade si riporta un celebre episodio: l'eroe tracio Licurgo insegue le nutrici di Dioniso, «e tutte insieme gettarono a terra gli strumenti del loro culto», mentre il dio «assalito da spavento, balzò nei flutti del mare e Teti lo ricevette nel suo seno tremante: un brivido terribile l'aveva colto alle urla del guerriero». Ma Licurgo «si attirò la collera degli dèi»: Zeus «lo rese cieco», ed egli non visse più a lungo «perché si era inimicato tutti gli dèi immortali». Possiamo scorgere in questo episodio, in cui si parla di un inseguimento da parte di un ‘uomo lupo' e di un tuffo nel mare, il ricordo di un antico sfondo iniziatico. Tuttavia all'epoca in cui Omero lo cita, il senso e lo scopo del mito sono diversi. Esso ci rivela uno dei tratti specifici del destino di Dioniso, la sua ‘persecuzione' da parte di personaggi antagonisti. Ma il mito testimonia anche che Dioniso è riconosciuto come membro della famiglia divina, perché non solo Zeus, suo padre, ma anche tutti gli altri dèi si sentirono lesi dal gesto di Licurgo. La ‘persecuzione' esprime in modo drammatico la resistenza contro la natura e il messaggio religioso del dio. Perseo si rivolse con il suo esercito contro Dioniso e contro le ‘donne del mare' che l'accompagnavano; secondo un'altra tradizione, egli gettò il dio in fondo al lago di Lerna (Plutarco, De Iside, 35); e lo stesso tema della persecuzione si ritrova nelle Baccanti di Euripide. Si è tentato di interpretare tali episodi come ricordi mitizzati dall'opposizione incontrata dal culto dionisiaco. La teoria che ne sta alla base presuppone che Dioniso sia arrivato molto tardi in Grecia e che, implicitamente, sia un dio ‘straniero'. Dopo Erwin Rohde, la maggioranza degli studiosi considera Dioniso come un dio tracio introdotto in Grecia o direttamente dalla Tracia, oppure dalla Frigia. Walter Otto ha però insistito sul carattere arcaico e pan-ellenico di Dioniso, e il fatto che il suo nome -di-wo-nu-so-jo- si ritrovi in un'iscrizione micenea sembra dargli ragione. D'altra parte non è meno vero che Erodoto considerava Dioniso come un dio «introdotto tardivamente»; e nelle Baccanti Penteo parlava di «quel dio venuto più tardi, chiunque esso sia».
Qualunque sia la storia della penetrazione del culto dionisiaco in Grecia, i miti e i frammenti mitologici che alludono all'opposizione da esso incontrata hanno un significato più profondo: ci ragguagliano allo stesso tempo sull'esperienza religiosa dionisiaca e sulla struttura specifica del dio. Dioniso doveva incontrare resistenza e persecuzioni, perché l'esperienza religiosa da lui propugnata minacciava tutto uno stile d'esistenza e un universo di valori. Si trattava certo della supremazia insidiata della religione olimpica e delle sue istituzioni, ma l'opposizione tradiva anche un dramma più intimo, e che è del resto ampiamente attestato nella storia delle religioni: la resistenza contro ogni forma di esperienza religiosa assoluta, che si può effettuare solo negando il resto (qualunque nome gli si dia: equilibrio, personalità, coscienza, ragione, ecc.). Walter Otto ha colto molto bene la correlazione tra il tema della ‘persecuzione' di Dioniso e la tipologia delle sue diverse epifanie. Dioniso è un dio che si mostra improvvisamente e che scompare poi in modo misterioso. Alle feste Agrionie di Cheronea, le donne lo cercavano invano, e ritornavano con la notizia che il dio era presso le Muse, che l'avevano nascosto (Otto, Dionysos, p. 79). Scompariva tuffandosi nel lago di Lerna o nel mare, e riappariva come nella festa delle Antesterie in una barca sui flutti. Le allusioni al suo ‘risveglio' in culla indicano il medesimo tema mitico. Queste epifanie e questi occultamenti periodici collocano Dioniso tra gli dèi della vegetazione. In effetti egli mostra una certa affinità con la vita delle piante; l'edera e il pino sono quasi diventati suoi attributi, e le sue feste più popolari s'inseriscono nel calendario agricolo. Ma Dioniso è in rapporto con la totalità della vita, come mostrano le sue relazioni con l'acqua e i germi, il sangue o lo sperma, gli eccessi di vitalità che si manifestano nelle sue epifanie animali (toro, leone, capro). Le sue comparse e scomparse inattese riflettono in certo qual modo l'apparizione e l'occultamento della vita e della morte e, in ultima analisi, la loro unità. Non si tratta però di un'osservazione ‘obiettiva' di questo fenomeno cosmico la cui banalità non poteva suscitare nessuna idea religiosa, né produrre alcun mito. Attraverso le sue epifanie e le sue occultazioni, Dioniso rivela il mistero e la sacralità dell'unione tra la vita e la morte. Rivelazione di natura religiosa, perché si realizza grazie alla presenza stessa del dio. Infatti queste apparizioni e scomparse non sono sempre in relazione con le stagioni: Dioniso si mostra durante l'inverno, e scompare nella stessa festività primaverile in cui si realizza la sua epifania più trionfale. ‘Scomparsa' e ‘occultamento' sono espressioni mitologiche della discesa agl'Inferi, dunque della ‘morte'. In effetti a Delfi si mostrava la tomba di Dioniso e anche ad Argo si parlava della sua morte. D'altronde, quando nel rituale argolico Dioniso è richiamato dal fondo del mare (Plutarco, De Iside, 35), riemerge proprio dal paese dei morti. Secondo un inno orfico, quando Dioniso è assente si ritiene ch'egli si trovi presso Persefone. Ed infine il mito di Zagreus-Dioniso di cui ci occuperemo tra poco narra della morte violenta del dio; ucciso, smembrato e divorato dai Titani. Tali aspetti, multipli, ma complementari di Dioniso, sono ancora percepibili nei suoi rituali pubblici, malgrado le inevitabili ‘purificazioni' e reinterpretazioni.
L'arcaicità di alcune feste pubbliche
A partire da Pisistrato, si celebravano ad Atene quattro feste in onore di Dioniso. Le ‘Dionisie campestri', che si svolgevano in dicembre, erano feste dei villaggi e consistevano nel portare in processione un fallo di grandi dimensioni con accompagnamento di canti. Cerimonia tipicamente arcaica e ampiamente diffusa in tutto il mondo, la falloforia ha certamente preceduto il culto di Dioniso. Altri divertimenti rituali prevedevano gare e contese, e soprattutto sfilate di maschere o di personaggi travestiti da animali. Anche qui i riti hanno preceduto Dioniso, ma si può intuire come il dio del vino sia giunto a mettersi alla testa del corteo di maschere. Molto di meno sappiamo invece sulle feste lenee, che si svolgevano in pieno inverno. Una citazione di Eraclito precisa che la parola Lenai e il verbo ‘far le Lenai' venivano usati come equivalenti di ‘baccanti' e di ‘fare la baccante'. Il dio era evocato mediante il daduchos. Secondo una glossa di un verso di Aristofane, il sacerdote eleusino, «con una torcia in mano, esclama: Chiamate il dio! e gli astanti gridano: Figlio di Semele, Iacchos, dispensatore di ricchezze!». Le Antesterie erano celebrate approssimativamente in febbraio-marzo, e le ‘Grandi Dionisie', d'istituzione più recente, in marzo-aprile. Tucidite considerava le Antesterie la più antica festa in onore di Dioniso. Era anche la più importante. Il primo giorno si chiamava Pithoigia, apertura dei vasi d'argilla (pithoi) nei quali si conservava il vino dopo il raccolto autunnale. Si portavano i vasi al santuario di ‘Dioniso della palude' per compiere le libagioni al dio, e in seguito si gustava il vino nuovo. Nel secondo giorno (Choes, le brocche) si svolgeva una gara di bevitori: erano forniti di una brocca che veniva riempita di vino e, al segnale, ne trangugiavano il contenuto il più velocemente possibile. Proprio come certe gare delle ‘Dionisie campestri' (per esempio l' askoliasmos, in cui i giovani cercavano di mantenersi il più a lungo possibile in equilibrio su di un otre previamente oliato), anche questa competizione si articola nello scenario ben noto delle gare e dei giochi di ogni specie (sportivi, oratorî, ecc.) che tende al rinnovamento della vita. Ma l'euforia e l'ebbrezza anticipano in un certo qual modo la vita di un aldilà che non assomiglia più al triste mondo omerico. Lo stesso giorno delle Choes si formava un corteo che raffigurava l'arrivo del dio nella città. Poiché si riteneva venisse dal mare, il corteo comprendeva una barca trasportata su quattro ruote di carro, in cui si trovava Dioniso con un grappolo d'uva in mano e due satiri nudi che suonavano il flauto. La processione comprendeva parecchi personaggi probabilmente mascherati, e un toro sacrificale preceduto da un suonatore di flauto e da portatori di ghirlande che si dirigevano verso l'unico santuario aperto quel giorno, l'antico Limnaion. Là si svolgevano diverse cerimonie, a cui partecipavano la Basilimna, la ‘Regina' cioè la moglie dell'Arconte-Re, e quattro dame di alto rango. A partire da questo momento, la Basilimna, erede delle antiche regine della città, era considerata la sposa di Dioniso. Saliva accanto a lui nel carro e un nuovo corteo, di tipo nuziale, si dirigeva verso il Boukoleion, l'antica residenza reale. Aristotele precisa (Cost. di Atene, 3, 5) che la ierogamia tra il dio e la regina si consumava nel Boukoleion (lett. ‘stalla del bue') e la scelta di questo luogo indica che l'epifania taurina di Dioniso era ancora ben nota. Si è cercato di interpretare quest'unione in senso simbolico, o supponendo che il dio venisse personificato dall'Arconte. Ma W. Otto sottolinea giustamente l'importanza della testimonianza di Aristotele. La Basilimna riceve il dio nella casa del suo sposo, l'erede dei re - e Dioniso si rivela in quanto re. È probabile che questa unione simboleggi il matrimonio del dio con la città nel suo complesso, con le conseguenze faste che si possono immaginare. Ma è un atto caratteristico di Dioniso, divinità dalle epifanie brutali, che richiede la proclamazione pubblica della sua supremazia. Non si conosce nessun altro culto greco in cui si ritiene che un dio si unisca con la regina. I tre giorni delle Antesterie, soprattutto il secondo, quello del trionfo di Dioniso, sono però giorni nefasti, perché segnati dal ritorno delle anime dei morti, e insieme a loro dei keres, portatori di influenze malefiche del mondo infero. A loro era consacrato l'ultimo giorno delle Antesterie. Si pregava per i morti, si preparavano le panspermie, poltiglie di diversi grani cereali che dovevano essere consumate prima del cader della notte. E, arrivata la notte, si gridava: «Fuori i keres/ Finite le Antesterie!». Lo sfondo rituale è ben noto, ed è attestato un po' ovunque nelle civiltà agricole. I morti e le potenze dell'oltretomba governano la fertilità e le ricchezze, e ne sono i dispensatori. «Dai morti è scritto in un trattato ippocratico ci vengono nutrimento, crescita e germe». In tutte le cerimonie a lui dedicate, Dioniso si rivela al tempo stesso il dio della fertilità e della morte. Eraclito diceva già che «Ade e Dioniso sono un'unica e medesima persona». Abbiamo già ricordato il rapporto di Dioniso con le acque, l'umidità e la linfa vegetale. E dobbiamo anche segnalare i ‘miracoli' che accompagnano le sue epifanie, o le annunciano: l'acqua che sgorga dalla roccia, i fiumi che si colmano di latte e miele. A Teos, nel giorno della sua festa, una sorgente fa sgorgare vino in abbondanza (Diodoro Siculo, III, 66, 2). A Elide, tre scodelle vuote, lasciate durante la notte in una camera sigillata, all'indomani vengono ritrovate piene di vino. ‘Miracoli' di questo tipo sono attestati anche altrove; il più famoso tra questi era quello delle ‘vigne di un giorno', che fiorivano e riproducevano uva in poche ore, ‘miracolo' che avveniva in diversi luoghi, perché ne parlano parecchi autori.
Euripide e le orge dionisiache
Simili ‘miracoli' sono specifici del culto sfrenato ed estatico di Dioniso che riflette l'elemento più originale, e probabilmente più antico, del dio. Nelle Baccanti di Euripide troviamo una testimonianza inestimabile di ciò che ha potuto rappresentare l'incontro tra il genio greco e il fenomeno delle orge dionisiache. Lo stesso Dioniso è il protagonista delle Baccanti, fatto senza precedenti nell'antico teatro greco. Offeso perché il suo culto era ancora ignorato in Grecia, Dioniso arriva dall'Asia con un gruppo di Menadi e si ferma a Tebe, città natale di sua madre. Le tre figlie del re Cadmo negano che la loro sorella, Semele, sia stata amata da Zeus e che abbia generato un Dio. Dioniso le rende ‘folli' e le sue zie, con le altre donne di Tebe, corrono verso la montagna a celebrarvi riti orgiastici. Penteo, che era succeduto al trono a suo nonno Cadmo, aveva proibito il culto e, malgrado gli avvertimenti ricevuti, si ostinava nella sua intransigenza. Travestito da officiante del proprio culto, Dioniso è catturato e imprigionato da Penteo. Ma riesce miracolosamente a fuggire e persino a persuadere Penteo ad andare a spiare le donne durante le loro cerimonie orgiastiche. Le Menadi scoprono così Penteo e lo fanno a pezzi: sua madre Agave ne porta in trionfo la testa, credendo che si tratti della testa di un leone.
Qualunque fosse l'intento di Euripide nello scrivere le Baccanti, questo capolavoro della tragedia greca costituisce nello stesso tempo anche il documento più importante del culto dionisiaco, in cui il tema «resistenza, persecuzione e trionfo» trova la sua illustrazione più evidente. Penteo si oppone a Dioniso perché è uno «straniero, un predicatore, un mago dai bei boccoli biondi e profumati, guance di rosa, con negli occhi la grazia di Afrodite. Con il pretesto di insegnare le dolci e seducenti pratiche dell' evoé, corrompe le fanciulle». Le donne vengono incitate ad abbandonare la loro casa e a correre, la notte, per i monti, danzando al suono dei timpani e dei flauti. E Penteo teme soprattutto l'influenza del vino, perché «con le donne, se il liquor d'uva figura sulla mensa, non promette nulla di buono in queste devozioni». Tuttavia non è il vino a provocare l'estasi delle baccanti. Un servo di Penteo, che le aveva sorprese all'alba sul Citerone, le descrive vestite di pelli di cerbiatto, coronate d'edera, cinte di serpenti, che recavano in braccio, allattandoli, cerbiatti o lupacchiotti selvatici. Abbondano i ‘miracoli' tipicamente dionisiaci: le baccanti toccano la roccia con i loro tirsi e subito ne scaturisce l'acqua o ne sgorga il vino; grattano la terra e trovano polle di latte, mentre i tirsi cinti d'edera stillano gocce di miele. «Certo continua il servo se tu fossi stato là, questo dio che tu disprezzi, ti saresti convertito a lui, rivolgendogli le tue preghiere, dopo un tale spettacolo». Sorpreso da Agave, poco mancò che il servo e i suoi compagni venissero dilaniati. Le baccanti si gettarono allora sugli animali che pascolano nel prato e, «senza nessun ferro in mano» li fanno a brani. «Sotto l'opera delle mille mani delle fanciulle», tori minacciosi sono dilaniati in un batter d'occhio. Le Menadi si abbattono in seguito sulla pianura. «Vanno a strappar via i bambini dalle case. Tutto ciò che si caricano sulle spalle, pur senza esservi attaccato, vi aderisce senza cadere nel fango; anche il bronzo, anche il ferro. Sui loro boccoli il fuoco trascorre senza bruciare. Infuriati per essere stati assaliti dalle baccanti, si corre alle armi. Ed ecco il prodigio che tu, Signore, avresti dovuto vedere: le frecce che si lanciavano contro di loro non facevano sgorgare sangue, ed esse, scagliando il loro tirso, li ferivano...». Inutile sottolineare la differenza tra questi riti notturni, sfrenati e selvaggi, e le feste dionisiache pubbliche, di cui abbiamo parlato prima. Euripide ci presenta un culto segreto, specifico dei Misteri. «Che cosa sono, secondo te, questi Misteri?» s'informa Penteo. E Dioniso risponde: «La loro segretezza vieta di comunicarli a coloro che non sono baccanti». «Qual è la loro utilità per coloro che li celebrano?» - «Non ti è lecito apprenderlo, ma sono cose degne di essere conosciute». Il Mistero era costituito dalla partecipazione delle baccanti all'epifania totale di Dioniso. I riti vengono celebrati di notte, lontano dalla città, sui monti e nelle foreste. Attraverso il sacrificio della vittima per squartamento (sparagmos) e la consumazione della carne cruda (omofagia) si realizza la comunione con il dio, perché gli animali fatti a brani e divorati sono epifanie, o incarnazioni, di Dioniso. Tutte le altre esperienze la forza fisica eccezionale, l'invulnerabilità al fuoco e alle armi, i ‘prodigi' (l'acqua, il vino, il latte che scaturiscono dal suolo), la ‘dimestichezza' con i serpenti e i piccoli delle bestie feroci sono resi possibili dall'entusiasmo, dall'identificazione con il dio. L'estasi dionisiaca significa anzitutto il superamento della condizione umana, la scoperta della liberazione totale, il raggiungimento di una libertà e di una spontaneità inaccessibili ai mortali. Che tra queste libertà ci sia stata anche la liberazione dalle proibizioni, dalle regole e dalle convenzioni di tipo etico e sociale, sembra essere certo; e questo spiega in parte l'adesione massiccia delle donne. L'esperienza dionisiaca però raggiungeva livelli più profondi. Le baccanti che divoravano le carni crude ritornavano a un comportamento rimosso da decine di migliaia di anni; sfrenatezze di questo tipo rivelavano una comunione con le forze vitali e cosmiche che si poteva interpretare soltanto come una possessione divina. E non stupisce che la possessione sia stata confusa con la ‘follia', la mania. Dioniso stesso aveva conosciuto la ‘follia', e la baccante si limitava a condividere le prove e la passione del dio, e questo era, in definitiva, uno dei mezzi più sicuri per comunicare con lui. I Greci conoscevano altri casi di mania provocata da una divinità. Nella tragedia Eracle di Euripide, la follia dell'eroe è opera di Era: nell' Aiace di Sofocle è Atena a produrre lo sconvolgimento psichico. Il ‘coribantismo', che gli antichi del resto accostavano alle orge dionisiache, era una mania provocata dalla possessione dei Coribanti, e tale esperienza sfociava in una vera e propria iniziazione. Ciò che tuttavia contraddistingue Dioniso e il suo culto non sono le crisi psicopatiche, ma il fatto che esse fossero valorizzate in quanto esperienza religiosa: sia come una punizione sia come una grazia del dio]. In ultima analisi, l'interesse di un confronto tra riti e movimenti collettivi apparentemente similari per esempio certe danze sfrenate del Medioevo o l'omofagia rituale degli Aissaua, una confraternita mistica dell'Africa del Nord sta nel fatto che esso fa emergere l'originalità del dionisismo. È raro che un dio giunga all'epoca storica pregno di un'eredità così arcaica; riti con maschere teromorfiche, falloforia, sparagmos, omofagia, antropofagia, mania, enthousiasmos. Il fatto più notevole è che, pur conservando quest'eredità, residuo della preistoria, il culto di Dioniso, dopo essersi integrato nell'universo spirituale dei Greci, non ha cessato di creare nuovi valori religiosi. Certo, la frenesia provocata dalla possessione divina la ‘follia dava da pensare a molti autori, e spesso incoraggiava l'ironia e la derisione. Erodoto riferisce l'avventura di un re scita, Skylas, che si era fatto «iniziare ai riti di Dioniso Baccheios» a Olbia sul Boristene (Dniepr). Durante la cerimonia (telete), posseduto dal dio, faceva «il baccante e il folle». Con molta probabilità si trattava di una processione in cui gli iniziati, «sotto il dominio del dio» si lasciavano trascinare da una frenesia che gli astanti, e anche gli stessi posseduti, consideravano come ‘follia' (mania). Erodoto si limitava a riferire una storia che gli era stata raccontata a Olbia. Demostene, con l'intenzione di mettere in ridicolo il suo avversario Eschine, ci rivela però in realtà, in un suo celebre passo, certi riti dei piccoli tiasi (Bacchein) celebrati, nell'Atene del IV secolo, dai fedeli di Sabazios, dio tracio omologo di Dioniso. (Gli antichi lo consideravano d'altra parte come Dioniso tracio nel suo nome indigeno). Demostene si riferisce ai riti seguiti da letture di ‘libri' (probabilmente un testo scritto, contenente hieroi logoi); parla di ‘nebrizzare' (allusione alla pelle del cerbiatto, la nebride; si trattava forse di un sacrificio con la consumazione dell'animale crudo), di ‘craterizzare' (il bacile in cui si mescolavano l'acqua e il vino, la ‘pozione mistica'), di ‘purificazione' (catharmos), consistente in specie nello sfregare l'iniziato con argilla e farina. Alla fine l'accolito faceva rialzare l'iniziato dalla sua posizione prona o supina, e questi ripeteva la formula: «Sono sfuggito al male e ho trovato il meglio». E tutta l'assemblea esplodeva in ololyge. All'indomani si svolgeva la processione degli adepti, col capo coronato di finocchio e di fronde di pioppo bianco. In testa camminava Eschine brandendo serpenti e gridando: «Evoé, misteri di Sabazios!», e danzando al grido di Hyés, Attés, Attés, Hyés. Demostene parla anche di un cesto di forma di vaglio, il liknon, il ‘vaglio mistico', la culla primitiva di Dioniso bambino. Sotto le forme più diverse si trova comunque, al centro del rituale dionisiaco, un'esperienza estatica di una frenesia più o meno intensa: la mania. Questa ‘follia' costituiva in qualche modo la prova della ‘divinizzazione' (entheos) dell'adepto. L'esperienza era certamente indimenticabile, perché si partecipava alla spontaneità creatrice e alla libertà inebriante, alla forza sovrumana e all'invulnerabilità di Dioniso. La comunione con il dio faceva esplodere per un certo tempo la condizione umana, ma non giungeva affatto a cambiarla. Non ci sono allusioni all'immortalità nelle Baccanti, neppure in un'opera tardiva come le Dionisiache di Nonno. Ciò è sufficiente a distinguere Dioniso da Zalmoxis, con cui lo si confronta, e a volte lo si confonde, in seguito agli studi di Rohde; infatti questo dio dei Geti ‘immortalizzava' gli iniziati nei suoi misteri. Ma i Greci non ardivano ancora colmare la distanza infinita che, ai loro occhi, separava la divinità dalla condizione umana.
Quando i Greci riscoprirono la presenza del dio...
Pare ormai assodato il carattere iniziatico e segreto dei tiasi privati, benché almeno una parte delle cerimonie (per esempio le processioni) siano state pubbliche. È difficile precisare quando, e in quali circostanze, i riti segreti e iniziatici dionisiaci abbiano assunto la funzione specifica alle religioni dei Misteri. Eminenti studiosi quali Nilsson e Festugière contestano l'esistenza di un Mistero dionisiaco, perché mancano precisi riferimenti alla speranza escatologica. Ma si potrebbe obiettare che, soprattutto per il periodo antico, disponiamo di scarsissime conoscenze dei riti segreti, per non dire poi del loro significato esoterico (che senza dubbio esisteva, dato che i significati esoterici dei riti segreti sono attestati ovunque nel mondo, a tutti i livelli di cultura). Non si deve inoltre limitare la morfologia della speranza escatologica alle espressioni rese familiari dall'orfismo o dai Misteri dell'epoca ellenistica. L'occultamento e l'epifania di Dioniso, le sue discese agli Inferi (paragonabili a una morte seguita da risurrezione) e soprattutto il culto di Dioniso fanciullo, con riti celebranti il suo risveglio pur tralasciando il tema mitico rituale di Dioniso Zagreus, su cui ritorneremo tra breve indicano la volontà, e la speranza, di un rinnovamento spirituale. Il fanciullo divino è pregno, in tutto il mondo, di un simbolismo iniziatico relativo al mistero di una ‘rinascita' d'ordine mistico. (Per l'esperienza religiosa è più o meno indifferente che tale simbolismo sia o non sia ‘compreso' intellettualmente). Ricordiamo che il culto di Sabazios, identificato con Dioniso, presentava già la struttura di un mistero («Sono sfuggito al male!»). È vero che le Baccanti non parlano d'immortalità, ma la comunione, anche se provvisoria, con il dio non mancava di influire sulla condizione post mortem del bacchos. La presenza di Dioniso nei Misteri d'Eleusi fa supporre il significato escatologico perlomeno di alcune esperienze orgiastiche. Il carattere ‘misterico' del culto si precisa soprattutto a partire da Dioniso - Zagreus. il mito dello smembramento del fanciullo Dioniso - Zagreus ci è pervenuto soprattutto attraverso autori cristiani. Come prevedibile, essi ce lo presentano evemerizzato, incompleto e in modo piuttosto tendenzioso. Ma proprio perché erano liberi dalla proibizione di parlare apertamente di cose sante e segrete, gli scrittori cristiani ci hanno comunicato molti particolari preziosi. Era invia i Titani, che attirano Dioniso - Zagreus con alcuni balocchi (ninnoli, crepundia, uno specchio, un gioco di aliossi, una palla, una trottola, un rombo), lo massacrano e lo fanno a pezzi. Fanno cuocere i pezzi in un calderone e, secondo certe versioni, lo divorano. Una dea - Atena, Rea o Demetra riceve, o salva, il cuore e lo pone in un cofanetto. Venuto a sapere del delitto, Zeus folgora i Titani. Gli autori cristiani non accennano alla resurrezione di Dioniso, ma questo episodio era noto agli antichi. L'epicureo Filodemo, contemporaneo di Cicerone, parla delle tre nascite di Dioniso, «la prima da sua madre, la seconda dalla coscia e la terza quando, dopo lo squartamento da parte dei Titani, ritorna in vita dopo che Rea ne ha ricomposto le membra». Firmico Materno conclude aggiungendo che a Creta (dov'egli ambienta la sua storia evemerizzata) l'assassinio veniva commemorato da riti annuali, che ripetevano ciò che il «fanciullo aveva compiuto e subìto al momento della morte»: «nel profondo della foresta, emettono strani clamori e simulano la follia di un essere furioso», facendo credere che il delitto è stato compiuto in preda a follia e «dilaniano coi denti un toro vivo». Il tema mitico - rituale della passione e risurrezione del fanciullo Dioniso - Zagreus ha suscitato interminabili controversie, soprattutto a causa delle sue interpretazioni ‘orfiche'. In questa sede è sufficiente precisare che le informazioni trasmesse dagli autori cristiani sono confermate dagli autori più antichi. Il nome di Zagreus viene menzionato per la prima volta in un poema epico del ciclo tebano, Alcmeone e significa ‘gran cacciatore', in riferimento al carattere selvaggio e orgiastico di Dioniso. Per quanto riguarda il delitto dei Titani, Pausania ci ha trasmesso un'informazione che resta preziosa, malgrado lo scetticismo di Wilamowitz e di altri studiosi: Onomacrito, che viveva ad Atene nel VI secolo, al tempo dei Pisistrati, aveva scritto un poema sul seguente soggetto: «Avendo desunto il nome dei Titani da Omero, aveva fondato alcune orgia di Dioniso, facendo dei titani gli autori delle sofferenze del dio». Secondo il mito, i Titani si erano avvicinati al fanciullo divino impiastricciati di gesso per non essere riconosciuti. Orbene, nei misteri di Sabazios celebrati ad Atene, uno dei riti iniziatici consisteva nel cospargere i candidati con una polvere o con del gesso e questi due fatti sono stati accostati sin dall'antichità. Si tratta di un rituale arcaico d'iniziazione, ben noto nelle società ‘primitive': i novizi si sfregano sul viso polvere o cenere, allo scopo di assomigliare ai fantasmi; in altri termini, subiscono una morte rituale. Per quanto riguarda i ‘balocchi mistici', essi erano conosciuti già da tempo; in un papiro del II secolo a. C., trovato a Fayyûm (Gouroub), disgraziatamente mutilo, si citano la trottola, il rombo, gli aliossi e lo specchio. L'episodio più drammatico del mito e cioè il fatto che, dopo aver squartato il fanciullo, i Titani ne abbiano gettato i pezzi in un calderone, dove li hanno fatti bollire e poi arrostire era noto, in tutti i suoi particolari, già nel IV secolo e, fatto ancor più significativo, si ricordavano questi particolari in relazione con la ‘celebrazione dei Misteri'. Jeanmaire aveva opportunamente ricordato che la cottura in pentola o il passaggio attraverso il fuoco costituiscono riti iniziatici che conferiscono l'immortalità o il ringiovanimento (le figlie di Peleo fanno a pezzi il padre e lo cuociono in una pentola). Aggiungiamo che i due riti smembramento e cottura o passaggio attraverso il fuoco caratterizzano le iniziazioni sciamaniche. Nel ‘delitto dei Titani' si può dunque riconoscere un antico scenario iniziatico di cui si era perduto il significato originario. I Titani si comportano da Maestri d'iniziazione, vale a dire ‘uccidono' il novizio, allo scopo di farlo ‘ri-nascere' a un tipo superiore di esistenza (nel nostro esempio si potrebbe dire che essi conferiscono divinità e immortalità al fanciullo Dioniso). Ma, in una religione che proclamava la supremazia assoluta di Zeus, i Titani potevano svolgere soltanto un ruolo demoniaco e perciò furono fulminati. Secondo alcune varianti, gli uomini sono stati creati dalle loro ceneri e questo mito ha svolto un ruolo considerevole nell'orfismo.
Il carattere iniziatico dei riti dionisiaci si può scorgere anche a Delfi, quando le donne celebravano la rinascita del dio. Infatti il vaglio delfico «conteneva un Dioniso smembrato e pronto a rinascere, uno Zagreus», come dice Plutarco (De Iside, 35), e questo Dioniso «che rinasceva come Zagreus era allo stesso tempo il Dioniso tebano, figlio di Zeus e di Semele». Diodoro Siculo sembra riferirsi ai Misteri dionisiaci, quando scrive che «Orfeo ha trasmesso nelle cerimonie dei misteri lo smembramento di Dioniso». E in un altro passo Orfeo viene presentato come un riformatore dei Misteri dionisiaci: È per questo che le iniziazioni dovute a Dioniso sono chiamate orfiche». La tradizione trasmessa da Diodoro è preziosa in quanto conferma l'esistenza dei Misteri dionisiaci. Ma è probabile che già nel V secolo questi Misteri avessero mutuato alcuni elementi ‘orfici', e in effetti Orfeo era proclamato «profeta di Dioniso» e «fondatore di tutte le iniziazioni». Più ancora degli altri dèi greci, Dioniso sorprende per la molteplicità e la novità delle sue epifanie, per la varietà delle sue trasformazioni. È in perenne movimento; penetra ovunque, in tutti i paesi, presso tutti i popoli, in tutte le religioni, pronto ad associarsi a divinità diverse, anzi perfino antagoniste (per esempio Demetra, Apollo). È, senza dubbio, l'unico dio greco che, rivelandosi sotto aspetti differenti, affascina e attrae tanto i contadini che le élites intellettuali, i politici e i contemplativi, gli orgiastici e gli asceti. L'ebbrezza, l'erotismo, la fertilità universale, ma anche le esperienze indimenticabili suscitate dal ritorno periodico dei morti, o dalla mania, dallo sprofondare nell'incoscienza animale o dall'estasi dell'enthousiasmos - tutti questi terrori e rivelazioni hanno un'unica origine: la presenza dei dio. La sua natura esprime l'unità paradossale della vita e della morte. Per questo, Dioniso costituisce un tipo di divinità radicalmente diverso dagli Olimpî. Era forse, tra tutti gli dèi, il più vicino agli uomini? In ogni caso ci si poteva avvicinare a lui, si giungeva a incorporarlo, e l'estasi della mania dimostrava che la condizione umana poteva essere oltrepassata.
Questi rituali erano suscettibili di sviluppi inattesi. Il ditirambo, la tragedia, il dramma satirico sono, in modo più o meno diretto, creazioni dionisiache. È appassionante seguire la trasformazione di un rito collettivo, il dithyrambos, implicante la frenesia estatica, in spettacolo e infine in genere letterario. Se, da un lato, certe liturgie pubbliche sono diventate spettacoli e hanno fatto di Dioniso il Dio del teatro, altri rituali invece, segreti e iniziatici, si sono evoluti in Misteri. Perlomeno indirettamente, l'orfismo è debitore alle tradizioni dionisiache. Più di tutti gli altri dèi olimpici, questo dio giovane non cesserà di gratificare i suoi fedeli con nuove epifanie, messaggi inattesi e speranze escatologiche.
Mircea Eliade
Pubblicato da
Nicola Ferraro
alle
20:21
0
commenti
![]()
Etichette: Ermetismo, Esoterismo, Filosofia, Massoneria, Simboli
Iscriviti a:
Post (Atom)