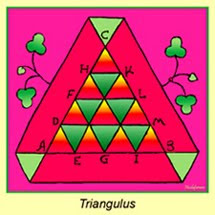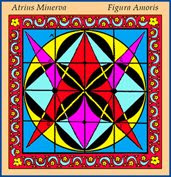30 marzo 2012
Affrontare la tematica dei rapporti tra Dante e i Fedeli d'Amore vuol dire calarsi in una complessa realtà storica, sociale culturale, politica e religiosa e vuol dire anche e soprattutto venire a contatto con una "Organizzazione" a carattere esoterico. La realtà medievale è lo sfondo scenico sul quale si muovono i personaggi che ci interessano.
Le forze animatrici di questo mondo emergente dalla grande crisi della "romanità", sono:
- da una parte, il potere della Chiesa cattolica che, oltre che sul piano spirituale, si dispiegava anche sul piano temporale e si caratterizzava, perciò, non solo per l'imposizione della dottrina cattolica in termini rigorosamente dogmatici, sotto il terribile controllo dell'Inquisizione (istituita da Gregorio IX [Ugo de'Segni 1227-1241] nel 1231), ma anche per la sua ingerenza in tutti gli affari pubblici e privati;
- da un'altra parte, il potere imperiale, che proprio nel periodo da noi considerato, seconda metà del XIII secolo, attraversava una grave crisi, che sfociò in una prolungata vacanza del trono con tutte le conseguenze, relative al frammentarsi delle influenze politiche e al deterioramento e decadimento dei concetti basilari del neouniversalismo del Sacro Romano Impero;
- da un'altra parte, infine, le autonomie comunali che si andavano affermando, destreggiandosi con alterna fortuna tra le due grandi Istituzioni della Chiesa e dell'Impero.
In questa composita realtà andremo insieme a ricercare, per ben individuarli, i rapporti tra Dante e i Fedeli d'Amore. Scopriremo insieme i frammenti di quelle concezioni iniziatiche, manifestatesi in un originale fenomeno, fecondo di stimoli rinnovatori dei tempi e che oltre al suo peculiare contributo di idee, ha dato all'Italia una nuova, durevole e unitaria espressione d'arte e di linguaggio che va sotto il nome di "Dolce Stil Novo". Allo stato attuale degli studi in materia, i rapporti tra Dante e i Fedeli d'Amore sono ancora molto poco conosciuti. Si constata, per altro, che la storia della letteratura italiana, particolarmente nei suoi riflessi scolastici, sia universitari che di livello inferiore, non solo non si occupa minimamente della "questione" dei Fedeli d'Amore, ma ne sottace qualunque sia pure elementare riferimento. L'esistenza dei Fedeli d'Amore, ad onta delle reticenze dubbiose di molti critici accademici, è, tuttavia, incontrovertibile, giacché lo stesso Dante ne fa menzione in ben sette occasioni, a dire solo di quelle riscontrabili nel componimento "Vita Nova". Invero, direttamente connessa alle vicende dei Fedeli d'Amore, si svolse una cospicua parte della vita di Dante e di numerosi altri personaggi, noti nella letteratura italiana, tra i quali citiamo, solo per fornire qualche esempio: Jacopo da Lentini (metà XIII sec.), Pier delle Vigne, Guido Guininzelli (1240 c. – 1300 c.), Guido Cavalcanti (1260 c. – 1300), Lapo Gianni (1260c. – 1320c.), Dino Frescobaldi 1271 – 1316), Gianni Alfani (1270c. – 1340c.), Dante da Maiano, Cino da Pistoia (1270 – 1336), Cecco d'Ascoli, Bonagiunta Orbiciani, ecc.
Da poco meno di un secolo la voce "Fedeli d'Amore" comincia a trovare specificazione in qualche enciclopedia e in qualche volume di storia della letteratura solo per essere definita a livello di "setta ereticale" e segreta, dalla dubbia esistenza, senza ulteriori, maggiori particolari. Le stesse biografie di Dante non riferiscono nulla in proposito e il problema storico-letterario, lungi dall'essere più o meno indagato, è stato del tutto ignorato. Non sono, invece, ignorate alcune e piuttosto numerose questioni interpretative delle Opere di Dante. A tal proposito, anzi, quando le soluzioni proposte si rivelano palesemente insufficienti, la critica ufficiale si trae dall'imbarazzo, definendo semplicisticamente "oscure" le espressioni in esame, adducendo a sostegno dei miseri risultati il logoro argomento di presunti condizionamenti mistici e superstiziosi, tipici dell'epoca dantesca, senza mai ammettere alla base delle "oscurità" la benché minima relazione con l'esistenza, la concezione e le convenzioni dei Fedeli d'Amore. A dispetto dell'indirizzo biografico e storiografico corrente, una piccola, ma agguerrita, schiera di studiosi ha combattuto e combatte un'ammirevole battaglia con lo scopo d'informare l'opinione pubblica e, specialmente, il mondo culturale, circa la complessa vicenda dei Fedeli d'Amore e dei particolari rapporti intercorsi tra loro e Dante e la rilevanza di tali rapporti nella concezione e nell'Opera del Sommo Poeta. La "questione" dei Fedeli d'Amore fu posta per la prima volta all'attenzione della cultura letteraria da Gabriele Rossetti (1783-1854), il quale, a partire dal 1826, in numerose sue opere come, "Spirito Antipapale", "Il Mistero dell'Amore Platonico nel Medioevo", "Commento alla Divina Commedia" e "La Beatrice di Dante", sostenne la singolare e coraggiosa tesi che nel filone della poesia stilnovista venisse usato un gergo convenzionale che nascondeva le idee iniziatiche dei Fedeli d'Amore. A questa tesi, nella quasi generale indifferenza della critica accademica, si interessarono personaggi della statura di Giosuè Carducci, Francesco Perez, Giovanni Pascoli, Luigi Valli, Alfonso Ricolfi ed altri. In Francia, l'argomento ebbe una considerevole risonanza a seguito dell'Opera pubblicata da tale Eugenio Aroux il quale, sembra, come c'informa l'Alessandrini, essendo editore del Rossetti, si sia appropriato di un ennesimo studio, elaborato da quest'ultimo, giacente, per altro, in fin di vita a Londra, e lo abbia divulgato a proprio nome. Se le Opere rossettiane hanno il merito di aver posto organicamente il problema della "Questione dei Fedeli d'Amore", mettendo in evidenza anche numerosissimi e convincenti elementi, relativi all'esistenza, alle origini, e alla natura di quella Organizzazione, bisogna pur dire che, sebbene frammentariamente, qualche indizio di ricerca, ovvero di interpretazione originale, non soggiacente al conformismo imperante nella critica dantesca, si era già avuto fin dal 1700 in poi, specialmente in riferimento al personaggio di Beatrice, ad iniziativa di Anton Maria Biscione e di Ugo Foscolo (1778 – 1827), i quali, tutti, avevano in qualche modo percepito la natura simbolica di Beatrice. Ai giorni d'oggi, per merito di Luigi Valli, strenuo sostenitore e divulgatore delle tesi di Gabriele Rossetti ed arguto esegeta dell'Opera dantesca, nonché, per gli ulteriori approfondimenti svolti dal Ricolfi, particolarmente sulla cultura provenzale e sul complesso mondo delle Corti d'Amore, l'esistenza dei Fedeli d'Amore è un dato definitivamente acquisito. Tommaso Ventura, Mario Alessandrini e numerosi altri insigni studiosi, partendo dagli indirizzi indicati dal Valli, hanno continuato ai giorni nostri l'opera di informazione e di ulteriore chiarificazione della "questione". Purtroppo, c'è da dire che questi studi sono stati approfonditi da un punto di vista storico-letterario e non altrettanto da un punto di vista esoterico, il che, data la natura dell'argomento, avrebbe certamente accresciuto il nostro interesse. I contributi esegetici degli Autori fin qui menzionati e quelli di parecchi altri che, per economia di trattazione, non citiamo, consentono di collocare storicamente i Fedeli d'Amore tra le varie organizzazioni esoteriche, venute in esistenza verso la fine del Medioevo. Secondo alcuni studiosi, tra i quali per primo il Keller, i Fedeli d'Amore, come d'altra parte tutte le altre Organizzazioni simili e coeve, si rifacevano a precedenti modelli organizzativi, noti come le Unioni Culturali umanistiche, sorte in Roma intorno al II secolo a.C. Per altri, tra i quali possiamo ricordare Alfonso Ricolfi e Carlo de Ryski, i Fedeli d'Amore sarebbero fioriti in Provenza dando luogo a sodalizi fraternali a carattere neoplatonico-gnostico e antipapale. Presumendo la stessa origine provenzale e collegandone le ideologie anche ai locali fermenti cataro-albigesi, secondo altri studiosi, tra i quali René Guenon, i Fedeli d'Amore corrisponderebbero all'Associazione della Fede Santa che sarebbe un Ordine di filiazione templare, i cui dignitari portavano, oltre ai colori "bianco e rosso", propri dei Templari, il titolo di Kadosh, termine ebraico che significa "Santo", che, tra l'altro, nel XVIII secolo fu recuperato per designare un alto grado rituale massonico. Quali che siano le loro origini, tali Organizzazioni, come è facile immaginare, furono inevitabilmente definite eretiche dall'allora imperante Chiesa Cattolica Romana la quale in esse vedeva una possibile turbativa al suo dogmatismo e al suo monopolio culturale. I Fedeli d'Amore, in particolare, a causa della loro dottrina che li portava alla affermazione di alti valori umani, ad una concezione religiosa, ispirata alla purezza evangelica e contro il dogmatismo religioso, nonché, alla ricerca di un rinnovamento civile, erano fatalmente esposti alla incomprensione delle autorità cattoliche. Essi, dunque, per sfuggire alle persecuzioni dell'Inquisizione e al rogo, secondo la dotta esegesi intrapresa dal Rossetti, dal Valli, dal Ricolfi e dagli altri, avrebbero opportunamente velato i loro pensieri iniziatici con un linguaggio poetico a chiave segreta. Il linguaggio tipico degli innamorati, per il suo carattere universale, sarebbe stato ritenuto adatto alla bisogna. Ogni Iniziato sarebbe stato, quindi, obbligato a servirsi della poesia, la più raffinata possibile per trasmettere il suo pensiero. Gli studi svolti al riguardo, provano ampiamente l'esattezza dell'ipotesi. Il linguaggio amatorio a doppio senso, cioè usato in senso anfibologico, secondo alcuni, quasi a mò di gergo, ebbe origine in Provenza con il singolarissimo "Roman de la Rose", di Guglielmo de Lorris (Prima Parte:1234 c.)e di Giovanni di Meung (Seconda Parte: 1275-80), poco dopo la feroce persecuzione, promossa da Innocenzo III contro gli "eretici" di Alby, detti Albigesi. Dalla Provenza, il linguaggio d'Amore, divenuto caratteristica delle cosiddette Corti d'Amore, si diffuse in Sicilia. Qui trovò fertile terreno presso la corte di Federico II, favorito dalla benevola considerazione e dal magnanimo appoggio dell'onnipotente ministro Pier delle Vigne. Jacopo da Lentini (1240 c. – 1300 c.), nell'ambito della Poesia Siciliana, ne fu uno dei più ragguardevoli utilizzatori. Dopo la caduta in disgrazia di Pier delle Vigne, dall'ambiente svevo, la Corte d'Amore si trasferì a Bologna, dove il linguaggio d'Amore che, sotto le simboliche parole di "Rosa" o "Fiore", ecc., nascondeva il concetto della "Sapienza Santa", ebbe ad affermarsi prontamente per il decisivo impulso che gli dette il giurista e filosofo Guido Guininzelli (1240 c.-1300). Essendosi, tuttavia, eccessivamente stilizzato nelle formule sin qui usate dalla Poesia Siciliana e dal lucchese Bonagiunta Orbiciani, questo particolare linguaggio rischiava spesso di lasciar facilmente trasparire l'argomento iniziatico per cui doveva fungere da schermo. Pertanto, Guido Guininzelli, affermando che "ciò che 'om pensa non de' dire", mutò le "maniere de li piacenti detti de l'Amore". Il Guininzelli, dunque, mutava quello che taluno ha definito un "gergo", sostituendo i simboli precedenti "Rosa", "Fiore", ecc., ricchi di elementi sensuali, con un simbolo più degno: da quel momento, la "Sapienza Santa", o la "Sapienza Iniziatica" fu rappresentata da una donna angelicata, ricca delle più elevate virtù che, ciò non di meno, davanti al volgo e, soprattutto, davanti all'Inquisizione, conservasse nome e dimensione umana. Guido Guininzelli arricchì il vocabolario anfibologico in uso e definì con precisi significati convenzionali i nuovi termini, come per esempio: "Amore" per indicare l'amore per la "Sapienza Iniziatica", o la stessa "Sapienza Iniziatica"; "Donne" per indicare gli Iniziati; "Saluto" per indicare l'atto formale d'Iniziazione;
"Piangere" per indicare il simulare fedeltà alla Chiesa di Roma; "Pietra" per indicare la Chiesa corrotta; "Dormire" per indicare di essere nell'errore; e così di seguito. Ai nomi convenzionali di "Rosa", o di "Fiore" o di "Stella", ormai facilmente decifrabili, consigliò di sostituire il Nome proprio di una donna. Da ciò, per Guido Guininzelli la "Sapienza Iniziatica" si chiamò "Lucia", "Giovanna" per Guido Cavalcanti, "Beatrice" per Dante, "Selvaggia" per Cino da Pistoia, "Lagia" per Lapo Gianni, tanto per fare degli esempi. Naturalmente, tutte rappresentavano la stessa cosa. Sembra, dunque, legittimo attribuire a Guido Guininzelli, non solo il merito di aver promosso ed introdotto un linguaggio anfibologico a chiave segreta, più adatto a consentire lo scambio di idee tra i Fedeli d'Amore, ma anche quello di aver stimolato l'affermazione di una nuova maniera di esprimersi che diventava sempre più rilevante come manifestazione non solo d'arte ma anche linguistica in sé e che cominciò ad esser noto specificamente come "Dolce Stil Novo". Lo stesso Dante, riconoscendo al Guininzelli questi specifici meriti, in un sonetto di "Vita Nova" (Cap.XX), lo chiamò "il Saggio": "Amore e 'l cor gentile sono una cosa/ sì come il Saggio in suo dittare pone" e, ulteriormente insistendo nello stesso senso, nel De Vulgari Eloquaentia (I,15) lo esaltò chiamandolo "maximus Guido" e nel XXVI Canto del Purgatorio (vv.97-99) ebbe a definirlo: "il padre/ mio e degli altri miei miglior, che mai rime d'Amor usár dolci e leggiadre" Quando Dante Alighieri venne a contatto per la prima volta con i Fedeli d'Amore, la loro Organizzazione, da Bologna, si era da poco diffusa anche a Firenze, dove aveva trovato in Guido Cavalcanti la più bella espressione poetica e il più vigoroso spirito organizzativo. L'Organizzazione dei Fedeli d'Amore, come ci informa Luigi Valli, comprendeva sette gradi iniziatici in analogia con i sette cieli planetari e con le sette Arti Liberali. Le Iniziazioni avevano luogo a Pasqua (la Divina Commedia, non a caso, si svolge nell'epoca di Pasqua). Le espressioni "Terzo Cielo" (Cielo di Venere), "Terzo Loco" e "Terzo Grado" indicavano il terzo grado della gerarchia in cui si riceveva il "Saluto". Questo importante rito, simile ad una confermazione, consisteva nella vera e propria investitura a Fedele d'Amore e avveniva, di solito, all'epoca di Ognissanti. L'essenza della dottrina d'Amore è ben sintetizzata in una terzina del XXIV Canto del Purgatorio (vv.52-54) in cui Dante, rispondendo a Bonagiunta Orbiciani, diceva: "Ì mi son un che, quando/ Amor mi spira, noto, ed a quel modo/ ch'è ditta dentro vo significando". È la dottrina della Verità nel senso più elevato. È l'affermazione della iniziatica ricerca in contrapposizione con tutte le dottrine fideistiche e dogmatiche. Iniziato proprio da Guido Cavalcanti ai Misteri d'Amore, Dante seppe penetrare ed assimilare talmente la dottrina iniziatica che la sua presenza e la sua personalità s'imposero ben presto nella Organizzazione. L'Opera di Dante in cui, più che altrove, è evidente il riferimento ai Fedeli d'Amore è "Vita Nova". L'esame di quest'Opera, scritta parte in prosa e parte in versi, oltre a farci conoscere, un complesso ed importante periodo della vita del Sommo Poeta, con particolare riferimento al suo Amore, per Beatrice, ci consente anche di volgere lo sguardo su di uno spaccato, quanto mai vivo ed espressivo, della vicenda dei Fedeli d'Amore in Firenze, con i quali il Poeta fu in stretta relazione. Tenendo presenti le informazioni fin qui date sui Fedeli d'Amore, poiché in "Vita Nova" Dante descrive proprio i rapporti intercorsi con la loro Organizzazione, l'attenta lettura dell'Opera e il giudizio che se ne può trarre, non consentono di accettare la semplicistica definizione data al Componimento dalla critica letteraria accademica come di un ingenuo racconto d'amore giovanile, o come, recentemente la indica, da storico, Indro Montanelli: "una piccola e vaga autobiografia in cui sono notati solo - e per allusioni - gli episodi che sentimentalmente lo [cioè, Dante] toccavano" . Prima di diffonderci nell'esame dei suddetti rapporti intercorsi tra Dante e i Fedeli d'Amore, è opportuno intrattenerci brevemente sul principale personaggio del racconto dantesco e, cioè, su Beatrice. La Beatrice della "Vita Nova", come è stato significativamente sostenuto da preclari commentatori, quali per esempio: Anton Maria Biscione, Francesco Perez, Adolfo Bartoli, Giovanni Pascoli, Luigi Valli, ecc., va considerata come un'astrazione, un vero e prorio simbolo e, quantunque sull'identità di tale simbolo non tutti concordino, tutti convengono che esso trascende il comune significato della donna vera di carne ed ossa. Per quanto si tenti, Beatrice non può essere indicata se non con parole di significato generale, cioè, non si sa se abbia occhi neri, o azzurri; non si percepisce il colore dei suoi capelli; non ha alcuna fisionomia; il suo sguardo non è languido, né ardente, né altro; ella non si manifesta che ricca di qualità angelicate, come purezza e volto "color di perla" (Cap.XIX). Dante la definisce: "non figliola di uomo mortale, ma di deo" (Cap.II), "non è femmina, anzi è uno de li bellissimi angeli del cielo" (Cap.XXVI), "cosa venuta/ da cielo in terra a miracol mostrare" (Cap.XXVI). Nata in cielo, ella è "venuta in terra a miracol mostrare", ella non fa tremare soltanto il cuore di Dante, ma il cuore di chiunque essa saluti: "ov'ella passa, ogn'om ver lei si gira, e cui saluta fa tremar lo core..." (Cap.XXI). In contrasto con quello che si sà circa l'educazione femminile del tempo, Beatrice è "sapientissima" distributrice di dottrina, è la "gloriosa donna de la (mia) mente" (Cap.II), è "l'eterna Luce, che vista sola, sempre Amore accende" (Par.V). Davanti a lei che "saluta", "ogne lingua deven tremando muta/ e li occhi non l'ardiscon di guardare." (Cap.XXVI). A Beatrice, inoltre, è collegato il numero perfettissimo e misterioso "nove", quadrato del "tre". Beatrice, dunque, non è una donna.
L'insieme di tutte le caratteristiche della Beatrice di Dante ci permette di individuare il suo vero significato simbolico, facendocela identificare con la "Sapienza vera", la "Sapienza Iniziatica", piuttosto che con la "Fede", o con la "Grazia", simboli pretesi più appropriati da quella piccola parte della critica accademica che riesce a sottrarsi alla concezione della "Beatrice donna", identificata in Beatrice Portinari. Coloro che danno per storica Beatrice, basandosi sulle affermazioni di Giovanni Boccaccio e di Pietro di Dante, entrambi, per altro, Fedeli d'Amore, sono semplicemente vittime d'ingenuità. Se, infatti, da quelli fosse stata svelata la vera identità di Beatrice, sia la "Vita Nova", che la Divina Commedia avrebbero fatto la stessa fine del De Monarchia, che fu bruciato, senza dimenticare che un altro Fedele d'Amore, Francesco Stabili, detto Cecco d'Ascoli, per le sue temerarie concezioni, ritenuto eretico, fu arso vivo dall'Inquisizione. Chiarito il significato di Beatrice, si può, a questo punto, con sufficiente obbiettività, affermare che il sentimento che lega Dante a questo personaggio è di natura squisitamente intellettuale e, più che i sensi, o il cuore, coinvolge unicamente la mente. A questa conclusione, per la verità, non si perviene solo per forza logica, bensì, è lo stesso Dante che ci guida. Nella Canzone "E’ m'incresce di me sì duramente" (Rime XXIX, p.436), Dante ricorda il primo turbamento sentito per Beatrice e afferma che Beatrice agì su di lui incosciente, molto prima che si incontrassero fanciulli e precisamente, il giorno della nascita di lei: "Lo giorno che costei nel mondo venne/... la mia persona pargola sostenne/ una passion nova,/ tal ch'io rimasi di paura pieno;/ ch'a tutte mie virtù fu posto un freno/ subitamente, sì ch'io caddi in terra,/ per una luce che nel cor percosse...". Questa è la miglior prova a sfavore della realtà umana e storica di Beatrice. Infatti, se si vuole interpretare in modo letterale, non vi è chi non giudichi perfino sciocco il pensare che una neonata possa provocare tale passione, senza dire, poi, che il destinatario di tale passione sarebbe un "pargolo", in cui non si è formata ancora una coscienza. Non resta, dunque, che interpretare simbologicamente il passo e tradurre l'immagine in un concetto più coerente e, cioè, che il nascere di Beatrice corrisponde al raggio della Sapienza che giunse a Dante nell'età, simbolicamente infantile (nove anni) della sua Iniziazione ai Misteri dei Fedeli d'Amore. Quando, con l'Iniziazione, Dante ebbe un contatto più diretto con la "Sapienza Iniziatica", Beatrice, che la simboleggiava, gli si mostrò in "giovanissima etade", cioè bambina, perché Dante non l'aveva ancora approfondita e gli si mostrò vestita di rosso sanguigno a ricordo delle cruente persecuzioni di cui era stata vittima (Cap.II). La "Vita Nova", dunque, per la presenza di Beatrice, caratterizzata dal suo valore simbolico-iniziatico, per le implicazioni dell'Organizzazione iniziatica dei Fedeli d'Amore, è la storia della vita iniziatica di Dante. Con l'iniziazione, infatti, si cominciava una vita nuova. Il modo convenzionale in cui "Vita Nova" fu scritta non avrebbe impedito, come di fatto non impedì, ai Fedeli d'Amore, unici destinatari dell'Opera, di recepirne il profondo ed iniziatico significato. Ciò ci viene confermato dallo stesso Dante nel commento al sonetto "Con altre donne mia vista gabbate" in cui dichiara che un certo suo pensiero sarebbe stato comprensibile solo a chi fosse stato "in simil grado Fedele d'Amore" (Cap.XIV). Alcune Organizzazioni iniziatiche davano l'età di "tre" anni al primo grado; altre davano l'età di "nove" anni allo stesso grado.
Nella tradizione iniziatica questi numeri, come è noto, indicano stati di perfezione e, poiché con l'Iniziazione si perviene al primo gradino della perfezione, ecco spiegato l'uso di età infantili. Perciò Dante, secondo l'uso praticato dai Fedeli d'Amore, scrisse di avere "nove" anni quando si avvicinò a Beatrice. In "Vita Nova" il numero nove ricorre fatalmente nove volte e solo in particolarità che riguardano Beatrice. Dante meritò l'investitura a Fedele d'Amore solo dopo "nove" anni, naturalmente convenzionali, di noviziato. Come traspare dal racconto, l'investitura, simboleggiata dal "Saluto" che Beatrice, in presenza di due Fedeli d'Amore, per la prima volta indirizzò a Dante, ebbe carattere solenne: "…compiuti li nove anni... avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo a due gentili donne e... mi saluto e molto virtuosamente, tanto che me parve allora vedere tutti li termini de la beatitudine. L'ora che lo suo dolcissimo saluto mi giunse, era fermamente nona di quello giorno… " (Cap.III). Dante sottolinea allegoricamente l'importanza della investitura descrivendo una "meravigliosa visione" che ebbe in "una nebula di colore di fuoco, dentro la quale io discernea una figura d'uno segnore... e pareami… che mirabil cosa era; e ne le sue parole dicea molte cose, le quali io non intendea se non poche; tra le quali intendea queste :"Ego dominus tuus". Nelle sue braccia mi parea vedere una persona dormire nuda, salvo che involta mi parea in un drappo sanguigno… la quale io guardando... conobbi ch'era la donna della salute, la quale m'avea lo giorno dinanzi degnato di salutare. E ne l'una de le mani mi parea che questi tenesse una cosa la quale ardesse tutta, e pareami che mi dicesse queste parole: "Vide cor tuum". E... pareami che disvegliasse questa che dormia e... le facea mangiare questa cosa che in mano li ardea, la quale ella mangiava dubitosamente. (E poco dopo) … la sua letizia si convertia in amarissimo pianto; e così piangendo, si ricogliea questa donna nelle sue braccia, e con essa mi parea che si ne gisse verso lo cielo..." (Cap.III). Il significato di questa allegorica visione è chiaro all'interprete del linguaggio d'Amore: l'"Amore", che è il fine ultimo della "Sapienza iniziatica" e che Dante definisce "Dominus" suo, e che ha in braccio l'Organizzazione dei Fedeli d'Amore, involta in un drappo rosso, significante le persecuzioni e la rigenerazione, possiede a tal punto il cuore dell'adepto che lo fa simbolicamente mangiare alla stessa Organizzazione in segno di totale simbiosi spirituale.
Avvenuto questo pasto ideale, pregno di intensissimo significato esoterico, il "Dominus", piangendo amarissimamente, cioè simulando grande devozione alla Chiesa, si ritrae andandosene verso il cielo, luogo della suprema beatitudine. Investito Fedele d'Amore, Dante indirizzò, secondo il costume, a tutti i membri del Sodalizio il sonetto: "A ciascun'alma presa e gentil core" (Cap.III). Come si praticava fare col primo sonetto di ciascun Investito, gli risposero: Guido Cavalcanti, col sonetto "Vedeste, al mio parere, onne valore" (Cap.III); Cino da Pistoia, col sonetto "Naturalmente, ch'era ogni amadore"; Dante da Maiano, col sonetto "Di ciò che stato sei dimandatore". Di tutti questi Dante volle ricordarne solo uno, quello di Guido Cavalcanti, il capo dei Fedeli d'Amore di Firenze. Seguendo i metodi della Organizzazione, per sfuggire a persecuzioni inquisitorie, Dante si finse devoto ed ossequiente della Chiesa. Tale comportamento, però, non fu apprezzato e Dante, accusato di essere un seguace della Chiesa, fu messo da parte: “… E per questa cagione… quella gentilissima, la quale fue distruggitrice di tutti li vizi e regina delle virtudi, passando per alcuna parte, mi negò lo suo dolcissimo salutare" (Cap.X). Fu in questo periodo che una grave crisi si manifestò nell'animo di Dante. Egli sentì proprio in questo momento il maggiore bisogno di conforto da parte dell'Organizzazione ("Amore, aiuta lo tuo Fedele") (Cap.XII) e cercò di farsi perdonare con un'altra composizione: "Ballata i’ voi che tu ritrovi Amore/ e con lui vade a madonna davante,/ sì che la scusa mia, la qual tu cante,/ ragioni poi con lei lo mio segnore." (Cap.XII). Ma ne ottenne in risposta solo la conferma della condanna e dei rimproveri, sottoscritti proprio dal Capo del Sodalizio, Guido Cavalcanti, che gli indirizzò il sonetto "I’ vegno ‘l giorno a te ‘nfinite volte/ e tròvoti pensar troppo vilmente:/ molto mi dòl de la gentil tua mente/ e d'assai tue vertù che ti son tolte./ …or non ardisco per la vil tua vita/ far mostramento che tu’ dir mi piaccia/..." (Valli, I, p.284). Dante fu, dunque, né perdonato, né riammesso, ma abbandonato a sé stesso, in balia di un angoscioso contrasto interiore di natura ideologica e sentimentale, tra Naturalismo e Misticismo cristiano. Accogliendo la Rivelazione quale complemento della forza conoscitiva naturale, egli decise di prendere "matera nova e più nobile che la passata" (Cap.XVII) e teorizzò la possibilità di dare alla "Sapienza Iniziatica" un carattere mistico che l'avvicinava alla Sapienza Evangelica, emancipatrice della individualità umana che un giorno Cristo aveva consegnato alla Chiesa e che questa tradiva per bassi interessi mondani opponendosi, anche aspramente, a chi volesse tornare a quella Sapienza Evangelica. Così, la sua nuova religione non fu basata solo sulla Fede, ma anche e soprattutto, sulla Ragione che guida l'uomo nella ricerca della Verità e lo tutela dalle false dottrine. Sicché, Dante, in piena libertà di coscienza, discusse i dogmi della Chiesa e ritenne in questo modo di dare giusto spazio alla "Sapienza Iniziatica". Convinto della giustezza del suo pensiero, Dante pensò di rivolgersi autonomamente agli Iniziati alla Fede d'Amore, prescindendo dai vincoli gerarchici vigenti nel Sodalizio e scrisse la Canzone "Donne ch'avete intelletto d'Amore/ i’ vò con voi de la mia donna dire" (Cap.XIX).
Per il suo alto contenuto, questa Canzone venne a porsi accanto a quella del Cavalcanti "Donna mi prega per ch'io voglia dire" e a quella del Guininzelli "Al cor gentil ripara sempre Amore". L'eco e il successo che ebbe la Canzone di Dante furono notevoli, tant'è che il Poeta fu non solo elogiato quale il più perfetto dei Maestri d'Amore, ma ritenuto degno di essere collocato in "Paradiso", cioè, in alto grado nella Organizzazione. Infatti, una Canzone recentemente scoperta, scritta da un ignoto Fedele d'Amore in risposta a quella di Dante, dice: "Poi ched egli è infra gli innamorati/ quel ch’n perfetto amor passa e più giova,/ noi donne il metteremmo in paradiso/ udendol dir di lei c'ha lui conquiso".
Dante, cosi, per soddisfare anche le tante richieste che gli pervenivano, sentì il bisogno di scrivere due Sonetti: "Amor e 'l cor gentil sono una cosa/ sì come il Saggio in suo dittare pone" (Cap.XX) e "Ne li occhi porta la mia donna Amore" per meglio illustrare la sua dottrina sulla natura d'Amore. La nuova ideologia contenuta nella Canzone "Donne che avete intelletto d'Amore" (Cap.XIX), integrata dai chiarimenti offerti con questi ultimi altri due Sonetti, scatenò immediatamente presso i Fedeli d'Amore un notevole fermento. Tutti i contrasti ideologici sulla dottrina d'Amore, fino a quel momento più o meno latenti e più o meno controllati, esplosero quasi contemporaneamente, mettendo in crisi la dirigenza di Guido Cavalcanti e, tenuto conto di tutte le diversità di temperamento e di cultura tra i vari membri, mettendo anche in serio pericolo la stessa esistenza del Sodalizio. Naturalmente, sorse subito contesa per il predominio tra i seguaci della tendenza "conservatrice", che faceva capo a Guido Cavalcanti e quelli della tendenza "innovatrice", che faceva capo a Dante. Qui vale la pena di riassumere brevemente i concetti principali delle due contrastanti teorie. Per la tendenza "conservatrice", la "Sapienza Iniziatica" era di natura razionalistica e non poteva essere commista ad alcunché di mistico, o di extra umano; la Chiesa era avversata in quanto tale e per la sua dottrina. Per la tendenza che si rifaceva a Dante, la "Sapienza Iniziatica" era circonfusa di misticismo e si fondava sia sulla Fede, che sulla Ragione, pur riconoscendo la profonda, irriducibile opposizione dei due termini; la Chiesa era da rispettarsi come organismo gerarchico e le si riconosceva la supremazia religiosa, ma la si osteggiava per la corruzione che la pervadeva; ond'è che, spogliata la Chiesa di ogni potere temporale e ristabilito l'Impero nella sua pertinente sfera di autorità, con la somma divisione tra potestà spirituale e potestà temporale, si sarebbero, finalmente conseguite nel mondo le condizioni essenziali per la felicità e la libertà del genere umano. Dalla piega che presero le dispute, Guido Cavalcanti, allora capo dei Fedeli d'Amore in Firenze, si rese conto che la tendenza dantesca andava prevalendo. Coerente con i suoi principi ed altero nella sua decisione, Guido Cavalcanti rinunciò alla sua carica e si ritirò.
L'eco del violento trauma che subì l'Organizzazione in questo particolare frangente è rilevabile nei due sonetti di Dante: "Voi che portate la sembianza umile" (Cap.XXII) e "Se' tu colui c'hai trattato sovente" (Cap.XXII). Il commento dello stesso Dante a questi due Sonetti ci fa sapere che essi furono scritti quando "colui che era stato genitore di tanta maraviglia quanta si vedea ch'era questa nobilissima Beatrice, di questa vita uscendo, a la gloria eternale se ne gio veracemente" essendo, per altro, "bono in alto grado". Interpretando secondo il senso anfibologico convenzionale, si comprende come per "padre di Beatrice" debba intendersi il fondatore in Firenze del Sodalizio dei Fedeli d'Amore, il quale, in realtà non muore, ma "esce", bensì, "di vita", cioè, si allontana dalla verità della dottrina d'Amore. Pertanto, i due Sonetti e il loro commento introduttivo non possono avere altro significato se non quello di notificare le dimissioni di Guido Cavalcanti, fondatore e, in ogni caso, benemerito dell'Organizzazione, dal comando della stessa; come pure mettono in evidenza, con partecipe apprensione di Dante, la grave crisi in cui essa per questo evento era venuta a trovarsi. In queste circostanze, già così pregne di tensione, si inserì un ulteriore evento che, aggiungendosi al precedente, dovette dare a Dante un nuovo grande dispiacere. Una nuova tendenza dottrinaria andava, infatti, prendendo consistenza sotto la guida del giovane notaio Lapo Gianni de' Ricevuti. Essa sosteneva con mistica concezione, non essere sufficiente per la salvezza del mondo la semplice purificazione della Chiesa, ma essere indispensabile un totale rinnovamento civile e religioso, secondo lo spirito evangelico dei primi seguaci di Cristo. Dante, conscio della gravità del momento, rivolse, allora, ai due antagonisti il Sonetto "Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io/ fossimo presi per incantamento/ e messi in un vasel, ch'ad ogni vento/ per mare andasse al voler vostro e mio..." (Rime XIV, p.427) in cui, per il bene generale del Sodalizio, proponeva un accordo per conciliare le opposte tendenze. Il rifiuto categorico di Guido Cavalcanti pervenne a Dante sotto forma poetica, come d'uso, col Sonetto "S'io fosse quelli che d'Amor fu degno,/ del qual non trovo sol che rimembranza,/ e la donna tenesse altra sembianza,/ assai mi piaceria sì fatto legno." (Rime XV, p.428). L'irreparabile era, dunque, avvenuto. Il Poeta ci informa (Cap.XXIII) di avere sofferto per "nove" giorni di una terribile malattia, aggravata, per altro, da terrificanti visioni preconizzatrici della "Morte di Beatrice". La Canzone "Donna pietosa di novella etade" (Cap.XXIII) ben esprime lo stato d'animo di Dante nella nuova situazione determinatasi. Nella Canzone riecheggiano i drammatici versi "Ben converrà che la mia donna mora" e "Morta è la donna tua, ch'era sì bella" (Cap.XXIII) a chiara testimonianza della gravità del momento. Ma, d'improvviso, un nuovo impulso volitivo pervase la mente ed il cuore di Dante. Preso da insospettata forza egli iniziò una paziente opera di ricostruzione. "Io mi senti’ svegliar dentro a lo core/ un spirito amoroso che dormia:/ e poi vidi venir da lungi Amore/ allegro sì, che appena il conoscia,/ dicendo: «Or pensa pur di farmi onore»… " (Cap.XXIV) è il primo Sonetto che Dante scrive dopo questa grave crisi. Quasi a premiare tanta infaticabile iniziativa, qualche tempo dopo, Dante vide, come con i suoi stessi versi c'informa, passare innanzi a sé Giovanna, la donna di Cavalcanti, e Beatrice, "l'una appresso dell'altra" (Cap.XXIV), a significare il passaggio amichevole del comando dei Fedeli d'Amore in Firenze da Cavalcanti a Dante.
L'attività di Dante, quale capo, fu rivolta particolarmente alla riorganizzazione e alla migliore determinazione dei criteri operativi del Sodalizio. I risultati di questa operosa iniziativa dovettero essere più che buoni perché con i Sonetti "Tanto gentile e tanto onesta pare" (Cap. XXVI) e "Vede perfettamente onne salute" (Cap.XXVI), nonché, con la Canzone, restata incompiuta, "Sì lungiamente m'ha tenuto Amore" (Cap.XXVII), Dante esprime un particolare stato di conseguita intima felicità. Ma, contro ogni appassionato sforzo ricostruttivo di Dante, si posero le mille difficoltà costituite dalle grandi discordie politiche fiorentine, dalle non sopite polemiche tra i Fedeli, dalle crescenti pressioni clericali. In questo contesto, obbiettivamente complesso e difficile, di fatto, il Sodalizio dei Fedeli d'Amore cessò d'operare e si disgregò. Era, dunque, avvenuta la morte di Beatrice.
Fu certamente una fatale coincidenza la morte di Beatrice Portinari, avvenuta proprio in quello stesso lasso di tempo, ma il compianto manifestato da Dante va molto al di là di ogni ragionevole espressione di cordoglio per morte umana. La Canzone "Gli occhi dolenti per pietà del core" (Cap.XXXI) esprime il profondo abbattimento nel quale era caduto il Poeta e tutta la sua tristezza per lo scioglimento dell'Organizzazione: "Ita n'è Beatrice in alto cielo,/ nel reame ove li angeli hanno pace,/ e sta con loro, e voi, donne, ha lassate..." "...ma ven tristizia e voglia/ di sospirar e di morir di pianto...". Il Sonetto "Era venuta nella mente mia" (Cap.XXXIV) commemora, a distanza di un anno, il deprecato avvenimento della morte di Beatrice e con esso si conclude il primo periodo della vita iniziatica di Dante.
Dopo la "morte di Beatrice", Dante, tra il 1293 e il 1295, visse un periodo intenso di nuove e, a volte, penose esperienze che può essere indicato come quello del "deviamento amoroso". Dante, infatti, intravide la possibilità di dare soluzione ai suoi problemi spirituali mediante lo studio della Filosofia, che in "Vita Nova", nel Capitolo XXXV, è riconoscibile sotto il simbolo della "gentile donna giovane e bella molto" (Cap.XXXV) e mediante la pratica sapiente della Politica. Questo capitolo, in realtà, mette inconfutabilmente "Vita Nova" in relazione col “Convivio”, relazione che avrà ulteriori conferme, e che pone, conseguentemente, persanti dubbi circa la presunta epoca di redazione sia della prima che della seconda Opera dantesca, come la corrente critica storico letteraria pretende ancora oggi. (Vita Nova , 1293; Convivio 1307 c.) Il matrimonio con Gemma Donati, intanto, consentì al Poeta di avere l'esperienza di una famiglia, mentre l'ingresso nella Corporazione dei Medici (Cerusici) e Speziali gli permise di partecipare alla elezione per le cariche comunali. Ben presto Dante s'avvide delle difficoltà di conseguire utili risultati e, nonostante le sapienti considerazioni che stava elucubrando nel Convivio, deluso e amareggiato dagli eventi, si convinse della necessità di riprendere la via della "Sapienza Iniziatica", quale l'unica capace di guidare sicuramente alla meta della Verità. "Lasso ! per forza di molti sospiri", fu questo il nuovo esordio di Dante nella ripresa della via iniziatica (Cap.XXXIX). Nell'ora "nona" di un giorno imprecisato, Dante, con rinnovato entusiasmo, riprese a cantare il nome e le virtù di Beatrice. Dante, allora, sentì la necessità di ritrattare quanto, nella speranza vana di risolvere ogni problema, andava scrivendo nel Convivio. A tal fine scrisse il sonetto "Parole mie che per lo mondo siete" (Rime XLIII, p.450), in cui, alludendo alla Filosofia, rivolge alle proprie parole l'esorazione: "Con lei non state, ché non v'è Amore". A questo Sonetto ne seguì subito un altro "O dolci rime che parlando andate" (Rime XLIV, p.451) nel quale, confermando il suo ravvedimento, Dante esortava ad andare oltre la Filosofia, che, secondo Lui, è solo il primo gradino per arrivare alla "Sapienza Iniziatica". Rivolgendosi, poi, ai pellegrini che attraversavano Firenze per raggiungere Roma, in occasione del Giubileo indetto da Bonifacio VIII, col Sonetto "Deh pellegrini che pensosi andate" (Cap.XL) compì notevole opera di proselitismo. ( In questo Capitolo, per altro, si ha la prova che la “Vita Nova” era ancora in corso di redazione nel 1300, come, del resto, ebbe ad intuire anche il Pietrobono. [Cfr. F.Biondolillo, p.26]) Integrò, quindi, l'opera ricostruttice, riorganizzando i superstiti Fedeli d'Amore e indirizzando loro nuovi versi. Con il Sonetto "Oltre la spera che più larga gira" (Cap.XLI), ultimo della raccolta di "Vita Nova", Dante dichiara e conferma di essere definitivamente tornato alla "Sapienza Iniziatica", alla sua Beatrice. Comincia, a questo punto, un nuovo periodo nella vita iniziatica del Poeta. Egli dice di aver ricevuto una "mirabile visione" a seguito di che promette di non più parlare di Beatrice, finché non sarà in grado di farlo nel modo più degno (Cap.XLII). Questo è il passo che mette in indiscutibile relazione, evidenziandone l'intima connessione, la "Vita Nova" con la Divina Commedia. Sotto l'impegno di questa solenne promessa, Dante concepisce la grandiosa idea della Commedia. Quando, finalmente, è pronto al cimento, sia pure conservando alcune forme care ai Fedeli d'Amore, abbandonando le esaurite forme gergali convenzionali e sostituendole con un simbolismo molto più profondo ed estetico, Dante supera con una nuova originale concezione tutte le contraddizioni del suo passato e lascia il suo genio libero di spaziare nell'infinito poetico con l'unico scopo di affermare la Verità Suprema: la "Sapienza Iniziatica", il trionfo di Beatrice. Nell'affermazione di una religione tutta sua, Dante cercò di accordare, nonostante la loro radicale inconciliabilità, la Fede con la Ragione. Teorizzò la dottrina della divisione dei poteri per cui allo Stato competeva la piena giurisdizione temporale e alla Chiesa l'apostolato spirituale. Nella Chiesa, profondamente odiata per la corruzione che la pervadeva, Dante non volle vedere per forza un nemico, bensì la depositaria di quella evangelica Verità che attraverso il Sacrificio del Cristo aveva affermato l'emancipazione dell'individuo nella fratellanza e nell'amore universali. Sul carro trionfale della Chiesa, immagine con cui si conclude la Commedia, supremo compendio della concezione iniziatica del Sommo Poeta, Dante pose, allegoricamente, radiosa nella sua emblematica significazione, Beatrice al fine di coronare e di suggellare il suo sforzo di Iniziato in nome della "Sapienza Iniziatica". Grande nella sua visione, sublime nello sforzo di rappresentarla, unico nella espressione poetica raggiunta, Dante più che il Vate dell'umano futuro progresso e più che il precursore del Rinascimento, dacché tenne sempre il suo sguardo rivolto al passato, può essere ben ricordato come colui che meglio di ogni altro chiuse il Medio Evo. Il suo lascito ai posteri, tuttavia cospicuo, più che la sua concezione iniziatica, più o meno influenzata dai Fedeli d'Amore, furono l'incomparabile poesia e l'unificazione della lingua italiana.
Conferenza tenuta all’Or. di Napoli, presso la R.L. Francisco Ferrer n. 213, il 2 marzo 2012 E.V.
Luigi Sessa
27 marzo 2012
- ( 2 ) Simboli d'individuazione nella basilica sotterranea di Porta Maggiore in Roma
I segni astrali.
E veniamo a considerare gli stucchi relativi a due segni astrali: I Gemelli ed il Toro. Nella costellazione dei Gemelli i Greci riconoscevano due famosi eroi, i fratelli Castore e Polluce, figli del padre mortale Tindaro e del padre divino Zeus. La madre era la famosa Leda, amata da Giove sotto forma di cigno. L'epilogo della vita avventurosa di Castore e Polluce si ebbe nella lotta che essi sostennero con un'altra coppia di gemelli, Linceo e Idas, figli di Aforeo. Dallo scontro il solo Polluce uscì superstite. Egli allora si rivolse a Zeus chiedendogli di poter morire anche lui. Ma il padre degli dei gli rivelò che ciò non era possibile: Polluce era immortale, mentre Castore era stato generato da seme mortale. Zeus offrì quindi al sopravvissuto due alternative: vivere sempre da solo sull'Olimpo, oppure vivere in compagnia del fratello un giorno sull'Olimpo ed un giorno nell'Ade. Polluce scelse la seconda soluzione. Il mito di Castore e Polluce simboleggia la vita e la morte, il giorno e la notte, il male ed il bene, la tesi e l'antitesi. L'archetipo dei due gemelli si ritrova in tutte le tradizioni primitive. Abbiamo in precedenza considerato l'importanza che per il pensiero pitagorico riveste il concetto degli opposti. Vorrei qui rammentare che essi erano intesi non in contraddizione, ma in reciproca mediazione e sintesi. Il mito dei due gemelli con diverso destino allude all'aspetto immortale della vita umana. Riecheggia anche il mito dell'arimaspe in lotta spasmodica per il proprio tesoro, che può essere sempre perduto e riconquistato. I gemelli rappresentano lo spirito e la materia non più in antitesi, ma finalmente conciliati; rappresentano quindi una maggiore armonia di inserimento nella vita, una migliore comprensione di quest'ultima: la vita non è luce e non è ombra, ma è invece la coesistenza di questi due opposti; e l'uomo è attratto dall'uno più che dall'altro a seconda del grado di consapevolezza raggiunto. L'« integrazione » è un'esperienza fondamentale dell'analisi junghiana: « il conflitto tra estroversione ed introversione, tra tendenze regressive e progressive, l'opposizione dialettica delle quattro funzioni (l'Io, la persona, l'ombra, l'anima-animus) e del Sé, la loro vicendevole relazione nelle loro innumerevoli manifestazioni, costituiscono il completo dinamismo della teoria e della pratica della psicologia di Jung ». Il riconoscimento e accettazione dell'ombra è dunque l'aspetto che soprattutto risulta nel mito dei Dioscuri, una volta trasferito tale mito sul piano psicologico. Dice Jung: « L'ombra è un problema morale che sfida tutta la personalità, perché nessuno può diventare conscio dell'ombra senza un considerevole sforzo morale. Diventarne consci significa riconoscere gli aspetti oscuri della personalità come presenti e reali ». Da parte sua la Jacobi rileva: « Se si vuoi rendere cosciente l'ombra mediante il lavoro analitico, bisogna aspettarsi una forte resistenza da parte dell'analizzando, che non tollera affatto di considerare appartenente a sé tutto quel buio e teme sempre di veder crollare sotto il peso di questo riconoscimento l'edificio del suo !o faticosamente costruito e tenuto in piedi... Per quanto amaro, il calice non può venir risparmiato ». Tanto l'affermazione di Jung che quella della Jacobi sembrerebbero porre l'accento su un certo modo di condurre l'analisi, modo che consiste nel mettere in risalto gli aspetti negativi dell'analizzando, affinchè questi possa integrarli in una personalità cosciente. Ma io mi domando se tale modo di procedere sia proprio necessario e se, in fin dei conti, sia terapeuticamente efficace. Ognuno di noi è già costretto nella vita di tutti i giorni, in abbondanza, a sorbire il calice amaro. La vita, con le sue strutture sociali, ottiene più che bene lo scopo di far conoscere al singolo le sue manchevolezze, i suoi talloni di Achille. I contatti che si hanno prima in casa, poi a scuoia e quindi nel campo del lavoro, sono quasi sempre contatti che tendono a far risaltare l'ombra piuttosto che la luce. Questa affermazione mi sembra incontrovertibile. Ora, nel momento analitico, il paziente non ha bisogno di ulteriori amarezze: l'ombra, in fondo, non è così ombra come potrebbe sembrare. Essa è una parte caratteristica dell'uomo, sulla quale bisogna far leva affinchè il paziente comprenda non soltanto la propria negatività, ma tutta la globalità del suo essere. Il paziente nevrotico ha già una vita difficile. La chiarificazione dei complessi può avvenire solo a condizione che egli prenda fiducia nel suo lo e cominci a conoscere le sue potenzialità intrinseche. C'è anche l'ombra, s'intende, in tali potenzialità: ma esse, pur essendo bifronti, costituiscono un tutt'uno: ed è così che vanno prospettate. Accanto allo stucco dei gemelli, osserviamo quello del toro. L'interpretazione simbolica del toro non è molto chiara, e le ipotesi avanzate sono molteplici. Le popolazioni sumeriche, che tanto si sentirono dominate da una moltitudine di divinità, dettero supremazia assoluta al dio toro. I Sumeri erano convinti della partecipazione del toro al fenomeno della fecondazione. Anche gli antichi abitanti dell'india avevano culti taurini connessi ai riti di fecondazione. Alcune testimonianze persiane mettono in evidenza che il dio degli dei creò un toro addirittura prima di Gaymont, il primo superuomo. In Egitto, fin dalla prima dinastia, si adorava il dio Apis sotto forma di toro. Nella mitologia greca Zeus, trasformato in toro, rapisce Europa, ha una relazione con Antiope, cerca di violentare la sorella Demetra. Eliade riferisce che a Creta si leggeva uno strano epitaffio: « Qui giace il grande bovino che si chiama Zeus ». Sempre a Creta, il toro era considerato come una dinamica riserva di energia. Inoltre, secondo una credenza egiziana, la salma di Osiride, era condotta nelle sfere celesti sulle spalle di un toro, che diveniva così simbolo di mediazione fra il cielo e la terra. Nel volume « Mitologia dell'anima », di Baynes, troviamo rappresentato, nel disegno di un paziente, il toro celeste: esso appare in posizione emergente, come un sole che stia per sorgere. Secondo Baynes il toro del disegno simboleggia la liberazione dell'energia primordiale, che in quel momento prendeva davvero a funzionare nella vita del paziente. Stando al Frazer, il toro, per i popoli pastori, è un naturale emblema di vigorosa energia riproduttiva. Lo stesso significato hanno alcuni reperti archeologici siriani, nei quali è visibile una dea, con gli organi genitali esposti, seduta su di un toro: Neumann ritiene che in questo caso il toro sia simbolo di mascolinità. Nel rito mitriaco l'uccisione del toro è un atto creativo: dalla morte sorge nuova vita. Crediamo quindi che si possa vedere in questo segno astrale il simbolo della forza istintiva, della vitalità che defluisce naturalmente. E' significativo, mi sembra, che assai spesso nelle fiabe una prova dell'eroe consista nella lotta con un toro: la von Franz avanza l'ipotesi che tale lotta, vittoriosa, simboleggi la superiorità della umana consapevolezza sulle emotive forze animali. Giustamente però aggiunge che il problema dell'uomo moderno è quello di ritrovare una via alle sue forze originarie istintive. E io credo che, in chiave psicologica, proprio questo sia il messaggio dello stucco ora esaminato: l'uomo non si distacchi mai dalle sue potenzialità inconsce.
Il ratto delle Leucippidi.
Uno fra gli stucchi più belli rappresenta il ratto delle Leucippidi. Le figlie di Leucippo, Febe ed Maria, erano state promesse in spose ai loro cugini, i gemelli Idas e Linceo. I Dioscuri le rapirono dando vita ad un feroce combattimento fra le due coppie di gemelli. Poniamoci ora una domanda: qual è il valore psicologico del ratto? Il ratto è stato probabilmente la prima forma di rapporto fra uomo e donna. In un clima indifferenziato di minacce, pericoli, lotta per il cibo e probabile amore periodico, la donna è soggetta senza possibilità di difesa alle violenze cicliche del maschio. Il ratto per la donna rappresenta un cambio di stato: vi è la perdita della verginità e la trasformazione in donna generatrice. Ma quest'evoluzione positiva si ha dopo il ratto; al momento in cui esso avviene la donna, come appare in tutte le raffigurazioni antiche, è atrocemente spaventata: nel nostro stucco, ad esempio, una delle Leuccipidi ha il terrore stampato sul viso mentre tende le braccia in un'invocazione di aiuto. Gli aspetti psicologici fondamentali del ratto stanno dunque nel « passaggio » da una fase all'altra della vita e nella decisione forte, vorrei dire nella violenza, nello « strappo », che precede tale passaggio: Vi sono momenti del vivere in cui bisogna « correre il rischio », bisogna cioè sottrarsi agli schemi protettivi di un contesto sociale che basa la sua forza su inevitabili costrizioni individuali; in quei momenti è necessario porre in gioco la propria onorabilità, la reputazione, insomma, tutti quei valori che la società difende e protegge, e che assicurano al singolo il generale rispetto: un rispetto sempre pagato con la stretta osservanza di certe regole. Nell'attimo in cui si « decide » che il proprio destino individuale è più forte della banalità organizzata, allora non c'è altra soluzione che lo « strappo », la rottura degli schemi. E quando uno di quei momenti giunge a maturare, la decisione va presa subito, con violenza, altrimenti si rischia di rimandare per anni e anni la svolta decisiva della propria vita. Andiamo ora verso il centro della volta, i cui motivi mitologici si dispongono in un chiaro proseguimento del processo finora illustrato. Intorno al quadro centrale, che mi riservo di analizzare in seguito, vi sono quattro stucchi raffiguranti quattro coppie di personaggi; Orfeo ed Euridice, Ulisse ed Elena, Giasone e Medea, Èrcole ed Esione. L'accostamento di tali personaggi non dev'essere stato casuale; io credo che l'artista, nella creazione dei suoi stucchi abbia seguito alcuni particolari motivi conduttori. La prima cosa che viene in mente a proposito di queste quattro coppie, è che tutte hanno in comune il tema del viaggio nell'altro mondo: Orfeo, dopo la perdita di Euridice, discese negli inferi per tentare la riconquista della donna amata. Giasone salpò verso il misterioso paese di Colchide per impadronirsi del vello d'oro, e questo viaggio, come ci attesta l'arte funeraria, simboleggia una discesa nell'oltretomba; Èrcole compì la sua più dura fatica recandosi nell'Ade per catturare Cerbero; Ulisse come racconta l'undicesimo canto dell'Odissea, incontrò le ombre dei morti nella lontana terra dei Cimmerii, avvolta in un continuo crepuscolo nebbioso. L'ombra di Tiresia diede all'eroe utili consigli contro i pericoli da superare durante il resto del viaggio. La discesa nel mondo degli inferi rappresenta sul piano psicologico, la discesa nell'inconscio. Nelle storie d'eroi, nelle avventure dei protagonisti di fiabe, si presenta spesso la necessità di penetrare nel fondo della madre terra, alla ricerca di un tesoro, di una donna, di un qualcosa il cui ritrovamento è indispensabile per l'ulteriore sviluppo della vicenda. La discesa nell'inconscio, dunque, è una tappa fondamentale per la conoscenza delle forze oscure e sconosciute che muovono la nostra esistenza e la spingono verso il suo vero significato. Questo viaggio non è mai senza pericoli: c'è sempre un mostro, un tranello, un gigante, insomma un ostacolo che mira ad atterrire l'eroe e indurlo alla fuga. Due sono allora i possibili atteggiamenti: la rinuncia o il tuffo nell'avventura. Chi sceglie questa seconda via, lo fa perché spinto da un'esigenza insopprimibile: conosce il pericolo, sa che rischia la morte, ma la morte fisica è per lui preferibile a quella psicologica; la rinuncia significherebbe la completa identificazione con i valori vegetativi della natura. Certo, il viaggio incute spavento perché implica la necessità di avventurarsi in un territorio misterioso le cui particolari caratteristiche non hanno quasi risonanza in chi si accinge all'impresa; bisogna avanzare senza sapere se le forze di cui si dispone saranno adeguate, e, per di più, senza una chiara percezione di quel che sta avvenendo, tanto che il senso stesso della avventura sembra sfuggire all'eroe; e tuttavia il viaggio è necessario per la rinascita psicologica: è il percorso obbligato verso l'individuazione. A volte questo tipo dì percorso si manifesta nelle visioni oniriche come una difficile e penosa immersione marina. Domandiamoci ora a cos'altro possono alludere — oltre che alla discesa nell'inconscio — le quattro coppie di personaggi: io credo che Giasone, Orfeo, Ulisse ed Èrcole stiano a rappresentare i quattro tipi psicologici propriamente detti, mentre Medea, Euridice, Elena ed Esione rappresentino le quattro strutture fondamentali della psicologia femminile. Vorrei tentare di dimostrarlo: Giasone affronta le sue imprese non in maniera violenta, ma cercando come prima cosa di chiarirsi le idee: discute con pacatezza ogni problema, scevera attentamente i fatti e si sforza sempre di giungere ad una soluzione razionale. In Colchide, mentre i compagni tengono consiglio di guerra, Giasone reputa che sia meglio presentarsi prima ad Eete e trattare con lui la restituzione del vello d'oro. Nonostante l'iniziale sgarberia del re, Giasone non perde la sua calma e gentilezza. Continua ad esporre le sue argomentazioni fino a quando Eete non può rifiutarsi di accettare un compromesso. Giasone è un eroe solare, i cui principali attributi sono la bellezza fisica, la lealtà, l'inalterabile limpidezza dei suoi atteggiamenti di fronte ai vari casi della vita. Da come affronta le situazioni, potremmo dire che egli usa soprattutto la funzione del pensiero: non commette azioni impulsive, comprende la realtà esterna e vi si adatta. La donna che gli è vicina nello stucco è la consorte, Medea, la maga, l'incantatrice. E' l'unica donna che partecipa con i cinquanta eroi alla conquista del vello d'oro, e la sua presenza si rivela indispensabile per la riuscita dell'impresa. Medea non stabilisce mai un rapporto autentico col marito, vive con lui in uno stato di rivalità, e più volte gli fa notare che i troni posseduti da Giasone dipendono dal potere di Medea. Il fatto di essere moglie di un eroe non le basta: ha bisogno di vittorie e conquiste sue personali, che persegue mediante l'arte magica, equivalente della forza maschile nel mondo antico. Fino all'ultimo non accetta alcuna superiorità o autorità: ella appartiene al tipo di donna Amazzone, indipendente, incapace di dar vita ad un'armoniosa relazione psicologica con l'uomo, ma capacissima di diventare per lui un compagno d'avventura, di dividere con lui fatiche ed imprese. Naturalmente il tipo amazzone presenta tutti gli aspetti negativi caratteristici della donna in preda alla protesta virile, che non riconosce alcuna autorità, affronta il mondo soprattutto con strumenti intellettuali, e, se si sposa, considera il matrimonio soltanto come un mezzo per lo sviluppo dei suoi interessi personali. Orfeo era così abile nel cantare e nel suonare la lira che la dolcezza della sua musica e il profondo sentimento della sua poesia riuscirono ad ammansire le bestie feroci, e smuovere le montagne e gli alberi, che lasciarono le loro secolari radici per seguirlo ed ascoltarlo. Orfeo partecipò alla spedizione degli argonauti, e il suo canto fu decisivo nel superamento di alcuni pericoli. Egli è il simbolo della musica e della poesia, è il simbolo del sentimento spinto alla sua espressione più intensa: il rapporto con Euridice fu « sentito » a tal punto che la tradizione vuole addirittura Orfeo sbranato dalle Menadi, rese furiose dal suo completo disinteresse per qualsiasi altra donna. Quando Euridice, cercando di sfuggire ad un atto di violenza, incespicò in un serpente e morì per il morso, Orfeo fu preso dalla disperazione. Osò tutto quel che un mortale poteva osare: scese nel Tartaro e supplicò gli inferi di rendergli la sposa. Persefone si commosse profondamente al dolore di Orfeo, e gli concesse di portar via Euridice ad una condizione; non doveva voltarsi a guardarla in viso prima di uscire alla luce del sole. Ma come Psiche, a causa della sua femminilità piena di sentimento non resiste alla proibizione ed apre la scatola che le farà nuovamente perdere Amore, così Orfeo, legato com'è alla funzione sentimentale, non riesce a trattenere lo impulso di guardare Euridice e perde per sempre la donna amata. Euridice rappresenta la donna madre, piena di carità e di comprensione. Per lei Orfeo è costretto a scendere nel Tartaro, ad ampliare quindi le sue dimensioni spirituali. Ella riesce a sviluppare e rendere armoniche tali dimensioni al punto che Orfeo, di ritorno dall'Ade, fonda nuovi misteri a cui accorrono tutti gli uomini di Tracia. Ulisse ed Elena ebbero diversi contatti. Il loro incontro più importante, quello a cui allude lo stucco, si riferisce ad un episodio narrato nel libro IV dell'Odissea: Troia sarebbe caduta soltanto se i greci fossero riusciti a rubare dalla città il Palladio di Atena; Ulisse si fece ridurre lacero e sanguinante, e potè in tal modo introdursi a Troia fingendosi uno schiavo fuggiasco. Elena fu l'unica a riconoscerlo, ma non lo tradì e Ulisse rivelò i piani della conquista. Lo stucco li rappresenta appunto durante tale colloquio. Più tardi, con l'aiuto di Elena, egli riuscì ad impadronirsi del Palladio. Ulisse è l'eroe del grande viaggio, l'uomo intrepido e paziente che sa sfruttare le occasioni più labili per raggiungere i suoi obiettivi. Nelle situazioni strane ed insolite, quando le idee e i valori correnti non possono essere d'aiuto, Ulisse, facendo ricorso alla intuizione, è capace di decisioni istantanee. Ora, dice Jung, « l'intuizione è un modo di percepire la realtà non più attraverso la coscienza, ma attraverso l'inconscio. E non è soltanto una mera percezione; è un processo creativo che si impadronisce della realtà esterna e tenta di modificarla ». Nel pieno d'un qualunque caso difficile e problematico, insomma, l'intuizione mira per sua natura ad uno sbocco che nessun'altra funzione sarebbe in grado di trovare. La figura di Elena è una delle più interessanti della mitologia greca. La sua bellezza provocò ben due guerre. Quando Afrodite volle convincere Paride a donare il pomo ad Elena, ne mise in evidenza soprattutto l'aspetto passionale e ardente: « Sono certa che, se ti vedesse, abbandonerebbe !a sua casa e le sue famiglie, tutto insomma, per divenire la tua amante ». Elena infatti fuggì con Paride, e si dette all'uomo amato nel primo porto dove gettarono l'ancora. I troiani restarono fortemente colpiti dalla bellezza di Elena, e in ultimo tutta Troia era innamorata di lei. Sta scritto in un testo antico: « Elena è la dea sovranamente bella che passa e diffonde intorno a sé il fascino irresistibile della sua persona... La sua figura penetra come un raggio di illuminazione interiore per far comprendere quello di cui, nel pieno empito sentimentale, è capace l'animo umano ». Da un punto di vista psicologico, mi sembra che Elena rappresenti il tipo di donna interamente impegnata nel rapporto col partner: « II suo interesse istintivo è diretto verso il contenuto della relazione e verso l'uomo. L'uomo d'altronde tende spesso ad evitare un rapporto totale, vissuto in tutte le sue potenzialità, o comunque il rapporto è per lui meno conscio e meno importante, perché può distrarlo dai suoi impegni. Per questo tipo di donna, invece, il rapporto è decisivo: qualsiasi altra cosa, sicurezza sociale, posizione, rispettabilità, viene da lei considerata secondaria e non importante ». E veniamo all'ultima coppia, Èrcole ed Esione. La funzione psicologica dominante in Èrcole è a mio giudizio quella della sensazione. Se osserviamo il semidio nei momenti che precedono le dodici fatiche, notiamo che molte divinità vengono in suo aiuto: Hermes gli dona una spada, Apollo frecce ed archi, Efesto uno scudo d'oro e Minerva una tunica miracolosa. Ma Èrcole rifiuta questi doni, perché li sente al di fuori della sua esperienza: preferisce servirsi soltanto della fida clava e del suo arco. Egli, insomma, resta ancorato a ciò che può con immediatezza — e superficialità — toccare, comprendere, conoscere: « II tipo sensoriale prende ogni cosa come viene, vive le sue esperienze per quelle che sono, in modo diretto, né il pensiero tenta di indagare in cerca di spiegazioni più profonde. Il pane è il pane; al di là di questo dato evidente non c'è nulla, ciò che conta è la forza e il piacere della sensazione ». I poeti comici greci puntarono ben presto sulla figura di Èrcole. Misero in ridicolo la sua straordinaria capacità di ingurgitare cibi, la sua mancanza di sottigliezza. Quando Èrcole si trovò ad affrontare la città degli uccelli, che minacciava la vita degli dei, venne meno al suo compito per seguire l'odore di pietanze squisite. Consideriamo ora l'incontro di Èrcole ed Esione: egli s'imbattè nella fanciulla completamente nuda, avvinta ad una roccia in attesa di essere divorata da un mostro. Esione, figlia di Leomedonte, doveva essere sacrificata per espiare le colpe del padre. Ma Èrcole la liberò e uccise il drago. Il motivo della vergine esposta al mostro e liberata dall'eroe, è un pattern classico riscontrabile in tutte le mitologie e fiabe del mondo. Tale motivo fu studiato dal Frazer che lo interpretò come il retaggio di un costume arcaico, secondo il quale si dovevano sacrificare vergini agli spiriti delle acque. Nel particolare caso di Esione, come vedremo in seguito, l'esposizione al mostro ci servirà per illuminare di luce riflessa la figura di questa donna, dato che su di lei abbiamo pochissime fonti mitologiche dirette. Ma, ripeto, di questo parleremo in seguito. Quello che ora mi interessa esaminare è il modo con cui Èrcole combattè ed uccise il mostro: egli saltò nelle sue immense fauci e trascorse ben tre giorni nel ventre della fiera prima di riemergerne vittorioso; nella lotta però perse completamente la capigliatura. Scrive il Graves: « La leggenda di Èrcole che salva Esione, paragonabile alla leggenda di Perseo che salva Andromaca, deriva senza dubbio da una raffigurazione assai diffusa in Siria e Asia Minore: la vittoria di Marduk sul drago marino Tiemat. Èrcole, come Marduk, viene inghiottito dal mostro e sparisce per tre giorni prima di riemergerne vittorioso dalla sua bocca. Cosi pure, secondo il racconto morale ebraico che a quanto pare si ispira alla medesima fonte, Giona passò tre giorni nel ventre della balena. E il re di Babilonia, rappresentante di Marduk, trascorreva ogni anno tre giorni di ritiro, come se dovesse simbolicamente lottare contro Tiemat... La calvizie di Èrcole accentua il suo carattere di Dio solare: una ciocca di capelli recisa quando l'anno volgeva al termine, simboleggiava infatti un affievolirsi della magica forza del re sacro, come d'altronde accade nella leggenda di Sansone. Quando il re riappariva, aveva il cranio liscio come quello di un neonato... ». Ora mi sembra che Graves non faccia altro che porre l'accento sul tema dell'inghiottimento da parte del mostro, ma senza metterne in luce il vero significato; c'è poi da dire che, valutando il particolare dei capelli perduti come un « affievolirsi della forza » Graves ne da un'interpretazione troppo riduttiva. Più acutamente Propp individua nel tema inghiottimento - eruttazione un complesso rito di tipo iniziatico: « Le forme di questo rito mutano, ma hanno pur sempre caratteri costanti. Noi lo conosciamo attraverso il racconto di coloro che lo hanno subito, e ne hanno violato il segreto, attraverso testimoni oculari, miti, informazioni ricavate dalle arti figurative. Una di queste forme consiste nel far passare l'iniziando attraverso un congegno che rappresenta un animale mostruoso. Là dove già si costruivano edifici, quest'animale era rappresentato da una capanna o da una casa di forma speciale. S'immaginava che l'iniziando venisse digerito e quindi vomitato come un uomo nuovo. Dove ancora non esistevano edifici, si ricorreva ad altri mezzi. Cosi in Australia il drago era raffigurato da una cavità sinuosa nella terra; altre volte nell'alveo asciutto d'un fiume si erigeva una tettoia, e davanti a questa si collocava un pezzo di albero spaccato raffigurante le fauci ». Potremmo dunque dire che nella lotta con il mostro Èrcole viene sottoposto ad una rigenerazione completa, ad una vera e propria rinascita. Questo è il senso, io credo, della perdita dei capelli, della riapparizione al terzo giorno « con il cranio liscio come quello di un neonato ». Graves non accenna questa interpretazione, suppongo, a causa della sua resistenza emotiva verso tutto ciò che suona di psicologia analitica. Più volte egli ha attaccato, in un modo che mi sembra legittimo definire gratuito, le scoperte di Jung. Dice Graves che la mitologia non va studiata in un gabinetto psichiatrico, ma nei contesti della storia, dell'archeologia e delle religioni comparate. Ebbene, in una nota su ciò che si deve intendere per fenomenologia dello spirito nell'ambito della favola, Jung dice testualmente: « ... la teoria della struttura della psiche non fu dedotta dalle favole e dai miti, ma si fonda su esperienze e osservazioni appartenenti alla sfera della ricerca medico-psicologica; e solo in una seconda fase questa teoria ha trovato conferma nello studio comparativo dei simboli, in campi prima lontanissimi per il medico ». Nessun psicologo analista ha mai affermato di studiare la mitologia attraverso i sogni dei pazienti. Quel che invece si può sostenere è che la presenza di temi mitologici nel materiale onirico di un qualunque analizzando — temi a volte del tutto ignoti alla coscienza del sognatore — indica l'esistenza di un inconscio al di là delle esperienze del singolo individuo, quindi un inconscio collettivo, comune a tutti. Ed allora lo psicologo deve chiedersi che significato ha quel mito, prima nel suo contesto storico, archeologico ed antropologico, e poi nella psicologia stessa del paziente. Vorrei comunque premettere che il mito si esprime attraverso simboli. I simboli sono, per cosi dire, il modo con il quale lo psicologo si accorge d'essere di fronte ad una modalità non del tutto personale, vale a dire legata alla storia del soggetto: questa modalità, tanto per dare un nome, viene chiamata da Jung archetipo. Quella dell'archetipo è una espressione innocente che ha suscitato ansie ed improperi specialmente fra gli incompetenti che non hanno mai consultato un testo di Jung, documentandosi soltanto sull'ormai famigerato falso scientifico del signor Glover! Dice Jung: « Gli archetipi si possono definire fattori e motivi, che ordinano gli elementi psichici in certe immagini... e in modo tale che si possono riconoscere soltanto dal loro effetto. Esse sono preconsce e formano presumibilmente le dominanti strutturali della psiche in genere... Come condizioni a priori, gli archetipi rappresentano il caso psichico del ' pattern of behaviour — modello di comportamento — familiare al biologo, che presta ad ogni essere vivente il suo modo psichico ». E' più oltre « L'attivarsi di un archetipo è assai probabilmente dovuto a un mutamento dello stato di coscienza che esige una nuova forma di compensazione ». Ed eccoci a parlare di Esione. Le fonti mitologiche riportano di questa fanciulla pochi ed insignificanti particolari. Sembrerebbe quasi che la sua figura serva da stimolo e veicolo per le imprese altrui: nel nostro caso, ad esempio, ella provoca sia pur indirettamente la rigenerazione di Èrcole. Credo quindi si possa affermare che Esione rappresenti il tipo psicologico della donna mediatrice, la cui prima caratteristica è lo spirito di sacrificio: in tutti i racconti mitologici in cui una vergine viene offerta in olocausto al mostro, è ella stessa che si reca impavida sul luogo. Inoltre, aspetto più importante, questo tipo di donna rappresenta uno strumento attivatore dei processi archetipici maschili: Èrcole, che era stato schiavo di una donna, si riscatta salvando una donna attraverso la lotta che, come abbiamo visto, allude ad un processo. Esione evidenziò il suo ruolo di mediatrice anche in un'altra significativa circostanza: Troia era stata distrutta da Èrcole e Telemone, che avevano annientato quasi tutta la famiglia reale: sopravvissuti erano soltanto Esione ed il più piccolo dei suoi fratelli, Priamo; la fanciulla implorò Èrcole, di risparmiare almeno il bambino, e l'eroe esaudì la preghiera. I discendenti di Priamo dovevano poi sostenere una parte molto incisiva nella storia del mondo antico. Vorrei ora soffermarmi sul fatto che Esione ottenne la salvezza del fratello non solo supplicando, ma anche facendo dono ad Èrcole di un velo ricamato in oro: il velo, da un lato è simbolo di protezione femminile, dall'altro rappresenta l'« invisibile », quindi lo spirito; Esione impegna tutto il suo spirito — tutto il suo inconscio — per salvare il piccolo Priamo: « la donna mediatrice è quasi schiacciata dagli effetti dell'inconscio; essa è assorbita e formata da esso e qualche volta quasi lo rappresenta». Riassumiamo ora il significato dei quattro quadri mitologici. Il motivo comune è il viaggio nel mondo sotterraneo, che quasi sempre è l'ultima fatica o l'ultimo obbligo che viene assegnato all'eroe. Ed è un'avventura che simboleggia lo sforzo verso l'individuazione. Il ritorno prelude ad un completo rinnovamento dell'eroe che è riuscito a superare la più difficile delle imprese. (Si ricordi ad esempio la discesa di Enea nell'oltretomba, e come egli ne ritorni più forte e più coraggioso). Il mito di tale viaggio trova il suo equivalente psicologico nell'indagine analitica dell'inconscio. Che tale indagine sia pericolosa e richieda molto coraggio, è inutile sottolineare. Quest'indagine tende all'individuazione che è, nel senso pitagorico, armonia e bellezza. I quattro quadri stanno inoltre a simboleggiare le funzioni e le strutture psicologiche femminili. Ma non dobbiamo intendere tali funzioni e strutture come rigidamente separate, vale a dire come rigidamente caratteristiche dell'uno o dell'altro sesso: la contrapposizione maschio-femmina mette anzi in luce il rapporto anima-animus all'interno dello stesso individuo, uomo o donna che sia. Nel momento in cui Pitagora, primo nell'antichità, riabilitava la funzione della donna, intuiva profondamente il rapporto psicologico fra le componenti maschili e femminili nella personalità di qualsiasi essere umano. Vorrei a questo punto ricapitolare brevemente tutto quanto finora esposto, aggiungendovi magari qualche altra considerazione: l'uomo deve conquistare e mantenere il suo tesoro più intimo con una lotta che non ha mai fine, lotta che in sostanza è un perenne confronto con l'inconscio: la situazione inconscia è infatti uno stato naturale. Dice Neumann: « non si può desiderare di rimanere inconsci, perché di fatto si è inconsci ». Il desiderio della consapevolezza è un tentativo di violenza alla stessa natura. Fra tutte le specie viventi, soltanto l'uomo manifesta questo tipo di ansia. Ma la lotta per la consapevolezza non può avere successo senza l'aiuto degli aspetti inconsci della personalità, i quali non controllati criticamente dalla censura che mira ad inserire ogni cosa nell'ambiente in cui viviamo, sono spesso più saggi e lungimiranti degli atteggiamenti consci. Si ricordi però l'affermazione di Jung: « la presunta onniscienza delle parti funzionali inconsce è naturalmente una esagerazione. Di fatto esse dispongono — e ne subiscono l'influenza — delle percezioni e dei ricordi subliminari, così come dei contenuti istintivi dell'inconscio con carattere di archetipo. Questi appunto procurano all'attività inconsce informazioni di insperata esattezza ». I miti e le fiabe ci parlano spesso di aiuti soprannaturali: tali aiuti sul piano psicologico, rappresentano il benefico influsso dell'inconscio. Il fatto straordinario e stupefacente è che, in concreto, l'uomo sulla via dell'individuazione, l'uomo cioè che vive in un continuo e vitale confronto col proprio inconscio riesce a fronteggiare e risolvere situazioni apparentemente senza via d'uscita: egli si affida soprattutto alla comprensione e assimilazione del concetto di sintesi degli opposti, per cui riesce spesso ad avere visioni per così dire « globali » delle varie circostanze e problemi, egli inoltre, non dimentica mai la presenza e l'indissolubile simultaneità di luce e ombra nella vita personale di qualsiasi individuo. Quella che Jung chiama « la più meravigliosa di tutte le leggi psicologiche, cioè la funzione regolatrice degli opposti », non fu, come già abbiamo visto, una scoperta di Eraclito, ma una formidabile intuizione pitagorica. Ricordiamo poi il valore del ratto, che, sul piano psicologico, va inteso come « rottura degli schemi » rifiuto della banalità organizzata, ricerca di una soluzione individuale al dramma dell'esistenza. E mi sembra che, oltre a ciò, il ratto possa anche alludere al rapporto anima-animus, rappresentando una volontà di unione mistica tra le componenti maschili e femminili dell'individuo. La strada verso l'armonia e la realizzazione del Sé, si snoda poi attraverso la presa di coscienza delle varie funzioni atte ad affrontare e risolvere i problemi del vivere, ma la discesa nell'inconscio è l'elemento decisivo, la condizione imprescindibile per la completa rinascita e trasformazione dell'uomo. Questa rinascita è illustrata dal ratto di Ganimede e dall'ultimo episodio della vita di Saffo.
Ganimede e Saffo
II quadro centrale della basilica ci mostra la elevazione di Ganimede all'Olimpo. Come narra Omero nell'Iliade, Ganimede era un bellissimo fanciullo, che, a causa delle sue attrattive, fu rapito direttamente in cielo per fare da coppiere agli dei. Ganimede è uno dei pochissimi esseri umani innalzati alla immortalità. Il fatto che questo quadro occupi la posizione centrale non è certo un caso: esso doveva, in un certo senso, raccogliere e sintetizzare il significato di tutte le altre illustrazioni. Tale compito va naturalmente attribuito anche agli stucchi dell'abside, che, come nelle chiese cristiane, aveva la funzione di riassumere i concetti più alti da ispirare ai fedeli. In quest'abside appare una figura femminile sul ciglio di un promontorio. Sulla testa ha un velo gonfiato dalla brezza marina. Sembra che la fanciulla stia per tuffarsi nelle onde lievemente agitate del mare. Nella mano sinistra ha una cedra. Eros la spinge premendole col braccio le spalle. Nel mare un tritone stende un velo per riceverla, mentre un altro tritone suona la buccina. Su uno scoglio siede un giovane pensoso, con la guancia al palmo della mano. In alto si vede Apollo che impugna l'arco rituale. Lo stucco si riferisce all'ultimo episodio della vita di Saffo, così come è stato tramandato dalla leggenda: respinta da Faone per la sua bruttezza fisica, Saffo si uccide lanciandosi in mare dalla rupe di Leucade. Viene subito in mente una considerazione: suscita meraviglia il fatto che i pitagorici abbiano posto in risalto un episodio tanto in contrasto col loro ideale di vita: il pitagorismo, analogamente all'idealismo cristiano, interpreta la vita umana come un perfezionamento in vista dell'immortalità, per cui non è consentito all'uomo di accorciare la durata della prova e scrollarsi di dosso il fardello. L'episodio di Saffo può essere compreso soltanto se non lo si valuta come il dramma di una morte volontaria, ma come un rito di rigenerazione che Saffo affronta con grande fede: il salto nel mare è simbolo di rinnovamento, e in questo senso si ritrova in altri racconti mitologici. Negli inni di Callimaco, ad esempio, leggiamo che Britomarte, inseguita da Minosse, riuscì a sfuggirli gettandosi in mare, e che, dopo quell'atto fu trasformata in Dea da Minerva. Apollodoro mitografo ci parla di Ino, resa folle da Giunone: dopo aver ucciso il proprio figlioletto, si lanciò in mare e divenne una divinità marina. Quando Teseo arrivò a Creta, dovette dimostrare di essere figlio di Posydone: Minosse buttò in mare un anello e gli chiese di ripescarlo. « Senza esitare Teseo si tuffò allora nel mare; un branco di delfini lo scortò fino al palazzo delle Nereidi, dove Teti gli regalò una corona ingioiellata, dono nuziale di Afrodite che più tardi cinse il capo di Arianna; altri dicono che Anfitrite, la dea del mare, gli consegnò la corona e ordinò alle Nereidi di nuotare tutt'attorno per trovarle l'anello. In ogni caso Teseo emerse dal fondo del mare reggendo sia l'anello che la corona ». Ora è senza dubbio interessante il fatto che Teseo dopo l'immersione nel mare, riporta non solo l'anello, ma anche una splendida corona. Jung ha rilevato che la corona è per eccellenza il simbolo dell'avvenuto raggiungimento di qualche alto obiettivo: chi conquista sé stesso, ottiene la corona della vita eterna. Mi sembra utile a questo punto ricordare una recente scoperta archeologica di Mario Napoli: la «Tomba del tuffatore», rinvenuta a Paestum il 3 giugno 1968. Una pregevole e plastica pittura, raffigurante un giovane teso nel tuffo, adorna la quinta lastra di questa tomba. Tra le varie interpretazioni proposte, la più convincente appare quella che si richiama ai riti di purificazione connessi alla conquista dell'immortalità. Dice Napoli: « Da quanto si è detto, apparirà chiaro che siamo presi dal forte sospetto che la Tomba del tuffatore possa essere compresa solo in chiave pitagorica. L'argomento meriterebbe una più approfondita indagine... Ma è certo che il tuffo può essere spiegato solo come allegoria della liberazione dell'anima dal peso del corruttibile corpo, per la sopravvivenza della purificata anima al di là della morte ». E' anche da riferire l'autorevole testimonianza di Carcopino: « Se noi guardiamo attentamente la Saffo della basilica, non possiamo scorgere nessuna agitazione nel suo atteggiamento; Saffo è l'esempio classico di una rigenerazione sacramentale e morale che trasforma gli iniziati » . Ma che cosa significa tutto questo in termini psicologici? Jung afferma che ogni vita, in fondo, è un processo che tende alla realizzazione della totalità, del Sé, tende insomma all'« individuazione »; e questo processo implica un rinnovamento, una « trasformazione ». Si può affermare che il vero scopo della psicologia analitica è appunto quello di provocare, in un modo o nell'altro a seconda del livello del paziente, un processo che conduce a irreversibili trasformazioni della personalità. Dice Jung: Le collettività sono somme di individui e i loro problemi somme di problemi individuali... Tali problemi non sono mai risolvibili con artifici legislativi. Per risolverli occorre un generale mutamento nei modi di concepire e affrontare i problemi dell'esistenza, mutamento che non comincia con la propaganda, coi raduni di massa o con la violenza: esso deve cominciare nei singoli, e deve consistere in una trasformazione delle loro tendenze e avversioni personali, dei loro modi di vedere le cose, dei loro valori; soltanto la somma di tali trasformazioni individuali condurrà ad una soluzione collettiva ». In un altro scritto Jung è ancora più esplicito, coinvolgendo nel processo di trasformazione anche la personalità dello psicoterapista: « Le personalità del medico e del paziente valutate « insieme » sono spesso molto più importanti — per una buona riuscita della terapia — di quanto il medico dica e pensi... L'incontro di due personalità è come l'unione di due differenti sostanze chimiche: se c'è qualche combinazione, ambedue sono trasformate. In ogni reale trattamento psicologico il medico è impegnato a influenzare il paziente; ma questa influenza può soltanto aver luogo se il paziente ha una reciproca influenza sul medico. Non si può influenzare se non si è influenzabili ». La conclusione del lungo iter pitagorico è dunque rappresentata dall'immortalità a cui viene elevato Ganimede, e dal rito di « rinascita » vissuto da Saffo. Mi sembrano a questo punto evidenti le notevoli convergenze tra il concetto di trasformazione insito nelle teorie pitagoriche e lo stesso concetto cosi come viene illustrato da Jung. Si pensi soprattutto all'importanza che i circoli pitagorici dettero alla realizzazione pratica e terrena dei precetti psicologici che essi venivano imparando dalle testimonianze del maestro. E qui vale forse la pena rammentare che anche la psicologia analitica, secondo noi, non può prescindere dall'esperimentazione dell'archetipo nella vita di tutti i giorni. Non è sufficiente a parer nostro ciò che dice la Jacobi, quando afferma che la individuazione porta al singolo quella tolleranza e quella bontà di cui è capace soltanto chi ha indagato le proprie oscure profondità e le ha consciamente vissute. Bontà e tolleranza sono soltanto tali quando si è nella mischia sino al collo e non nel ritiro di previlegiate situazioni. Nell'espressione di Jung « L'individuazione è un migliore e più completo adempimento delle finalità collettive dell'uomo », noi intravediamo quanto a cuore stesse a Jung che l'analisi ed il lavoro psicologico non estraniassero l'individuo dalle sue responsabilità verso l'ambiente di cui, volente o nolente, è partecipe. L'uomo ha un unico scopo nella vita, la fedeltà a sé stesso. Ma tale fedeltà si realizza sempre e solo su due fronti, interno ed esterno. Nel momento della trasformazione interiore, prima o poi ci si scontra con un ordine sociale collettivo che vede le innovazioni come elementi di estrema rovina. A noi sembra evidente che il contrasto individuo collettivo sia risolvibile prendendo in considerazione ambedue le modalità, mentre ci appare del tutto irrisoria l'enfasi che generalmente viene data all'uno o all'altro aspetto dagli psicologi o dai sociologi. I due momenti sono talmente intricati da essere, in pratica, inseparabili. Ed a questo proposito è iiluminante quanto scritto da Ernst Bernhard: « Una delle mie idee essenziali, che voglio realizzare con la mia mitobiografia, è quella della così detta presa di coscienza collettiva. Sono oggi del parere che la presa di coscienza collettiva individuale non è affatto possibile e non dovrebbe essere possibile senza una simultanea presa di coscienza collettiva. Poiché esse devono integrarsi reciprocamente... (infatti) in ogni analisi, in ogni situazione di presa di coscienza, deve sempre venire insieme elaborato il collettivo, e si dovrebbe sempre fare il tentativo di una presa di coscienza collettiva poiché questo risparmia una fatica immensa al singolo. Se i genitori restano inconsci, tocca ai figli far tutto, e così se il collettivo resta inconscio, devono far tutto i singoli. Naturalmente i singoli influenzano per così dire il collettivo, ma ciò che avviene nel singolo è già il collettivo ». D'altra parte ci sembra anche che l'umanità abbia di continuo oscillato fra i poli opposti del rifiuto assoluto della vita in terra ed il desiderio di creare in questo mondo un'esistenza più sopportabile e degna di questo nome. Ambedue le posizioni, comunque, offrono all'individuo una soluzione metafisica del proprio problema individuale rimandando a Dio o alla società le responsabilità dei propri destini. Possiamo definire queste posizioni come dei tentativi « paranoici » di comprensione della realtà. Di fatti l'individuo viene privato, nell'uno o nell'altro caso (Dio o società) delle sue capacità introspettive per cui, come ha notato Jung in un commento al Briccone divino l'etica di un tale individuo « è soppiantata dalla conoscenza di ciò che è permesso o proibito o comandato ». E' preoccupante notare lo sforzo demagogico corrente perché si dimentichi l'importanza dell'impegno individuale. Ciò è tanto più sconfortante se si pensa che una corretta interpretazione del marxismo evidenzia la necessità di modificare i rapporti fra gli uomini proprio perché i singoli si realizzino con maggiore « interezza » e responsabilità.
Aldo Carotenuto
Pubblicato da
Nicola Ferraro
alle
19:38
0
commenti
![]()
Etichette: Alchimia, Ermetismo, Esoterismo, Filosofia, Massoneria, Pitagora, Pitagorismo, Simboli
18 marzo 2012
- ( 1 ) Simboli d'individuazione nella basilica sotterranea di Porta Maggiore in Roma
21 aprile 1917. Una voragine si apre sotto un binario della linea Roma-Napoli, nei pressi di Porta Maggiore, e viene scoperta una basilica sotterranea a tre navate, di cui la centrale termina in un'abside semicircolare. Gli esperti hanno modo di stabilire che i muri perimetrali ed i pilastri erano stati ottenuti scavando prima il terreno secondo le forme e profondità volute, e poi riempiendo gli scavi di malta e calce; il tempio era stato successivamente vuotato di tutta la terra attraverso un ampio foro adattato in ultimo a lucernaio; il pavimento della parte centrale veniva così investito dalla luce che cadeva dall'alto. L'aspetto più sorprendente della basilica, o almeno quello che più colpisce il visitatore, sta nella presenza di un gran numero di stucchi, perfettamente conservati, che riecheggiano alcuni temi fondamentali della mitologia greca. Il giornale « Notizie sugli scavi », nella prima comunicazione che della scoperta venne data a! mondo scientifico, avanzò con molta prudenza l'ipotesi che il monumento fosse stato adibito al culto di qualche religione misterica. In seguito lo studioso belga Franz Cumont, notando che la caratteristica principale del tempio consisteva nel suo essere sotterraneo, si richiamò agli spelei mitriaci. Ma bisogna dire che la maggior parte della decorazione interna è in netta contraddizione con i riti connessi alla religione di Mitra: due soli elementi, il toro e i gemelli, potrebbero riallacciarsi a tale culto; però, come verrà chiarito, questi due stucchi si riferiscono a tutt'altra simbologia. Nel 1923, infine, lo storico ed archeologo francese Carcopino dimostrava l'appartenenza della basilica ad una setta neopitagorica. Carcopino, con una buona dose di fortuna, si era imbattuto in un passo poco conosciuto di Plinio il Vecchio, là dove si accenna ad una certa erba che aveva la proprietà di rendere affascinante all'altro sesso chiunque riusciva a trovarla nelle campagne: cosa che capitò a Faone, e la povera Saffo, innamoratasi perdutamente di lui senza esserne corrisposta, si uccise lanciandosi dal promontorio di Leucade. Ora, dice Plinio, « a ciò credevano non solo quelli che si interessavano di magia, ma anche i pitagorici ». L'episodio di Saffo fa parte degli stucchi della basilica, ed occupa anzi una posizione predominante: tutta la parte superiore dell'abside semicircolare. Vedremo in seguito come questo stucco, alla luce della dottrina pitagorica e a quella della psicologia analitica, rappresenti, insieme allo stucco del ratto di Ganimede, la sintesi finale del mitologema espresso plasticamente sulle pareti e le volte della basilica. Accertata dunque l'appartenenza del monumento alla setta neopitagorica romana, e fattane risalire la costruzione al primo secolo dopo Cristo, l'attività degli studiosi ha potuto stabilire ben poco d'altro; solo il Bendinelli, in un'erudita monografia, ha sostenuto che la basilica serviva da grande tomba per una ristretta cerchia di aristocratici. Dicevamo che la parte più sorprendente del tempio consiste nei meravigliosi stucchi che lo decorano. Essi, con ogni probabilità, non avevano soltanto un puro scopo ornamentale, ma, trovandosi in un luogo di raccoglimento e di meditazione, dovevano anche significare qualcosa: dovevano ispirare a chi li contemplava un certo dramma, una certa teoria, una particolare visione dell'esistenza umana. Avevano cioè quella funzione meditativa esercitata, per esempio, dagli emblemi scolpiti nei monumenti mitriaci di Ostia e di Santa Prisca a Roma, o dalle pitture parietali della Villa dei Misteri a Pompei, o dalle iconografie dei templi religiosi moderni. Se la basilica apparteneva ad una setta neopitagorica, la prima chiave di interpretazione degli stucchi ci sarà fornita da un'analisi del pensiero pitagorico, soprattutto in riferimento al modo di concepire la vita e la condizione dell'uomo. Vorrei ricordare che, come è stato talvolta accennato, si possono trovare nella psicologia junghiana alcuni addentellati con la filosofia pitagorica: condivido in parte tale ipotesi, e cercherò di dimostrarla analizzando gli stucchi che tratterò, dal punto di vista metodologico, come una serie di sogni. Quest'analisi, alla luce della dottrina pitagorica e a quella della psicologia analitica, condurrà a porre in evidenza il concetto di « individuazione », inteso come processo psicologico inerente alla vita umana.
Il pensiero pitagorico.
Pitagora nacque nell'isola di Samo intorno al 571 a.e. In gioventù, stando alla tradizione, viaggiò in tutte le parti del mondo allora conosciuto. Particolare importanza ebbe per lui l'incontro con la civiltà egiziana, che gli permise d'essere iniziato ad alcune religioni esoteriche. Dal contatto con il popolo ebreo, sembra che abbia poi appreso l'arte di interpretare i sogni. Verso i quarant'anni, non potendo più sopportare la tirannia di Policrate, lasciò Samo e si stabilì definitivamente a Crotone. Qui dette vita alla sua famosa scuola. Più che di scuola, si dovrebbe parlare di una comunità a sfondo prevalentemente etico-religioso, che però si occupava anche di concreti problemi sociali e politici. A lungo andare l'atteggiamento aristocratico dei pitagorici, ed il fatto che nella comunità venivano accolti soprattutto i giovani delle migliori famiglie, diede fastidio al partito democratico. Pitagora fu costretto a lasciare Crotone. Si rifugiò nel Metaponto dove morì verso il 479. La scuola, secondo la tradizione, gli sopravvisse ancora per un secolo, finché non venne eliminata dai democratici che uccisero tutti i suoi adepti. Si salvarono soltanto Liside e Aristippo; il primo si rifugiò a Tebe dando vita a quella che fu poi chiamato il pitagorismo tebano; il secondo fu l'iniziatore del pitagorismo tarantino. Pitagora non lasciò nulla di scritto, e ciò rende piuttosto difficile la differenziazione del suo pensiero da quello dei suoi discepoli. Dato però che nella scuola era fortemente sentito il principio di autorità del maestro, possiamo supporre che non esistano diversità sostanziali fra la dottrina primitiva — segreta — e quella che venne poi divulgata da Filolao in un'opera che ci è pervenuta soltanto in frammenti. Pitagora era profondamente convinto che il processo verso la perfezione non avesse limiti per l'uomo. Riconosceva che la strada era irta di ostacoli, ma sottolineava l'esistenza di alcuni fattori che dipendono solo da noi stessi. Per diventare artefici del proprio destino bisognava rendersi consapevoli di tali fattori, e, nel contempo, neutralizzare quelli nocivi, indipendenti dalla nostra volontà. La caratteristica essenziale del pensiero pitagorico sta nell'indagine sull'uomo e sui mezzi da prescrivergli affinchè la vita abbia uno scopo. Il problema che il pitagorismo si pone è questo: « Esiste un particolare regime di vita che, oltre ad offrire un maggior benessere fisico ed intellettuale, possa stimolare alcune facoltà latenti, privilegio di pochi fortunati? ». Ecco la « grande questione » dei pitagorici. Tutti i loro sforzi convergono verso il punto essenziale della rigenerazione umana, la nascita di un nuovo tipo di uomo. Gli storici si sono sempre trovati d'accordo nel ritenere che l'educazione impartita da Pitagora avesse lo scopo di formare uomini superiori. Tutte le riforme politiche proposte dalla scuola, pur aspirando ad un maggior benessere dei cittadini, avevano anche di mira il loro perfezionamento. Ma qual era questo ideale di perfezione? Sappiamo da Aristotele che i pitagorici sostenevano l'esistenza di tre esseri razionali: Dio, l'uomo e l'uomo pitagorico, quest'ultimo intermediario fra Dio e l'uomo. Compito dell'uomo era quello di tendere verso Dio. Si trattava quindi di un vero e proprio « superamento », ottenibile secondo i pitagorici, attraverso un particolare regime di vita, regime che « mirava a potenziare, trasformare, glorificare corpo ed anima; l’ uomo pitagorico era tale se anche fisicamente più bello, più vigoroso, più resistente alle fatiche, alle privazioni, alle malattie, più giovanilmente longevo, era tale solo se possedeva maggiori e più varie attitudini che lo rendessero atto a tutti i bisogni della vita; se possedeva un'intelligenza più vasta, un più ampio orizzonte intellettuale, una più profonda capacità di penetrazione nei segreti della misteriosa natura ». L'uomo pitagorico si distingueva dunque per una certa sua capacità taumaturgica, un dinamismo psichico che faceva di lui un centro di irradiazione, che gli consentiva di dominare la natura spiritualmente, non meccanicamente, di penetrarla e comprenderla non dall'esterno, ma dall'interno. Nulla era lasciato al caso in quest'opera di profonda trasformazione. Pitagora aveva capito che ognuno può essere l'artefice del proprio destino, e che per ottenere la realizzazione di sé stessi bisogna innanzitutto farsi consapevoli di quel che dipende soltanto da noi. Egli espresse in versi questo concetto: Conoscerai che gli uomini di propria scelta si procacciano i mali, infelici che, stando loro appresso i beni, non li guardano né intendono... . « Gli uomini si procacciano i mali ». Ma quando il male colpisce ciecamente? Come superare il problema dell'apparentemente arbitraria distribuzione del bene e del male su questa terra? E qui si innesta un altro punto capitale del pensiero pitagorico: la metempsicosi. L'anima, prima di giungere una volta per sempre a Dio, deve sottostare ad un certo numero di prove, ed ogni vita trasmetterà i suoi effetti ad una vita successiva, che sarà migliore o peggiore a seconda di quel che avremo precedentemente meritato. Ecco perché possono riversarsi tante disgrazie su di un uomo che sembra nascere per la prima volta; è l'effetto di precedenti esistenze vissute nella malvagità e nell'errore. L'avvicinarsi dell'anima a Dio, alla sua forma originaria e propria, da cui un tempo parti, è un processo graduale e lento, pieno di ripensamenti, di ritorni e di dolore. Secondo la metempsicosi la vita è un circolo, nel senso che l'anima è naturalmente protesa al ritorno verso il luogo originario, il pitagorico perciò era sempre teso al superamento della sua personale esistenza: ma vedeva forse questo superamento soltanto in funzione di una beatitudine eterna? Il genuino pensiero pitagorico era ben lontano da una simile impostazione. I pitagorici si impegnavano moltissimo per modificare le condizioni ambientali, sociali e politiche, perché sapevano che tali condizioni sono in ogni tempo determinanti per l'armonioso sviluppo dell'individuo. Essi volevano che l'uomo « fosse un potenziato su questa terra e per questa terra in cui il destino lo fa nascere» ; ma erano anche certi che il potenziamento in ogni singola vita favorisce, nelle vite successive, quella crescente assimilazione a Dio che dovrà rompere in ultimo il giro dell'esistenza. Si doveva però sempre vigilare, perché la vita umana scorre in continua lotta tra la spinta al superamento e l'attrattiva della banalità. Alla base di questa lotta sta il dinamismo degli opposti, il pari e il dispari, che sono « l'archetipo di tutta quella sequela di opposti, antinomie fisiche e morali, di cui il mondo è costi - trito ». I pitagorici sentirono in modo prepotente tale aspetto della realtà: l'inevitabile presenza, in ogni « caso » del vivere, di due opposti non contraddittori, ma destinati alla sintesi per mezzo dell'anima. Questa teoria, appunto perché presuppone una sintesi che armonizza gli opposti trascendentali, si riallaccia alla concezione del divenire continuo di tutte le cose. In un frammento pitagorico si narra di come un tizio, per liberarsi dal suo creditore, ricorresse ad alcuni argomenti filosofici: « ...così, vedi, sono anche gli uomini. L'uno cresce, l'altro sale: in mutamento siam tutti, per tutto il tempo. Dunque: quello che muta per natura e mai resta nel medesimo stato, mi sembra che sia già per essere diverso dal mutato. Anche tu ed io siamo altri oggi da quelli di ieri, e altri saremo in futuro né mai i medesimi, secondo identica legge... ». Il primo sistema filosofico che viene in mente è quello di Eraclito. Ma questa derivazione dall'eraclitismo è stata dimostrata del tutto falsa sia con argomenti filosofici che cronologici, tanto che spetta senz'altro alla scuola pitagorica il merito di aver formulato le prime tesi riguardo al continuo mutare dell'universo e alle categorie ordinatrici di questo mutare. Un suggestivo parallelo potrebbe essere individuato nella concezione dell'I King: lo Yin e lo Yang sono i principi (l'uno femminile, l'altro maschile) centrali e cosmogonici della realtà mutevole, e, al di sopra di essi, sta il Tao. Il Tao non rappresenta la loro somma, ma il Superiore principio che li sintetizza: è una forza regolatrice, ritmica, armonizzatrice. E veniamo al concetto di numero, pilastro della filosofia pitagorica. Alcuni studiosi ritengono che la teoria del numero sia balenata a Pitagora durante i suoi esperimenti nel campo dell'acustica. Servendosi di un monocordo, egli era giunto a scoprire il rapporto che passava fra l'altezza del suono e la lunghezza della corda: deducendo da tale fenomeno una certa espressione numerica, si accorse che questa, allo stato delle conoscenze di allora, poteva applicarsi a tutti i fenomeni naturali; da ciò concluse che l'elemento primordiale di tutte le cose fisiche, come pure delle entità ideali, fosse il numero che venne cosi a identificarsi con il « principio » lungamente cercato da tutte le filosofie precedenti. L'uno, o monade, è dunque il primo principio. Dall'uno si genera la diade, poi la triade, portentoso simbolo della divinità. Simbolo geometrico della triade è il triangolo. La tetrade era invece ritenuta l'origine della eterna natura: basti ricordare i quattro elementi, i quattro trimestri dell'anno, i quattro umori, i quattro temperamenti e le quattro facoltà critiche dell’ uomo. L'anima stessa, oltre che come un cerchio e una sfera, era considerata come un quadrato. La tetrade aveva inoltre attinenza con le età dello uomo: sappiamo che i pitagorici distinguevano nella vita quattro età, e che ritenevano difficile l'armonizzarle: « Esse infatti, quando una saggia guida non operi fin dalla nascita, tendono ad essere corrotte l'una dall'altra». E vediamo come, secondo il pitagorismo, la vita d'un uomo può essere suddivisa: fanciullo fino a vent'anni adolescente fino ai quaranta; giovane fino ai sessanta; vecchio oltre i sessanta. Tale suddivisione presuppone sempre il concetto dell'armonia, e quindi la problematica dei contrari: «Tener questo conto delle età, vuoi dire metterle in armonia le une con le altre, regolare ed assecondare i trapassi che da esse conseguono, recuperare nel conflitto delle opposte tendenze l'armonia generale della vita; e questo è alla fine il segreto dell'educatore e la specialità dei Pitagorici ». Ma la scuola pitagorica, in termini di « armonizzazione », si assunse un altro compito veramente rivoluzionario: la rivalutazione della donna. Nel VI secolo il primo compito della donna era quello di generare figli. Subordinata al marito, aveva soltanto doveri da assolvere, mentre la sua formazione culturale non superava l'orizzonte delle cose domestiche. Pitagora si presenta alla ribalta della storia come il paladino del sesso femminile, ne difende i diritti e rivaluta la missione della donna in seno alla società: « Egli insegna agli uomini che opprimere la donna è colpa. La femmina non deve essere soggetta allo sposo, ma deve stargli a lato dotata di un identico diritto ». La donna diventa compagna dell'uomo, e, pur non perdendo le sue virtù tradizionali, viene resa partecipe delle più alte forme di vita spirituale. Pitagora, in uno dei suoi discorsi, sostenne che per i due sessi esistono senz'altro occupazioni diverse e caratterizzanti, ma che le più alte prerogative della vita umana sono ad entrambi accessibili; le donne vedevano così spalancarsi la porta della filosofia, e si trovavano vicine all'uomo nell'apprendimento di verità psicologiche: « Le donne iniziate da Pitagora ricevevano con riti e precetti i principi supremi della loro funzione; egli dava a quelle che ne erano degne la coscienza del loro ufficio. Svelava loro la trasfigurazione dell'amore nel matrimonio perfetto, che è la fusione di due anime, il centro stesso della vita e della verità. L'uomo, nella sua forza, non è il rappresentante del principio e dello spirito creatore? La donna, in tutta la sua potenza, non personifica la natura della sua energia plastica, nelle sue realizzazioni meravigliose, terrestri e divine? Ebbene, che questi due esseri giungano a fondersi interamente, corpo, anima, spirito, e formeranno insieme un compendio dell'universo... C'è una ricerca disperata dell'altro sesso, ricerca che nasce da un divino stimolo inconscio e sarà un punto vitale per la ricostruzione dell'avvenire: perché quando l'uomo e la donna avranno trovato sé stessi e l'uno e l'altro per virtù dell'amore profondo e dell'iniziazione, la loro fusione sarà la forza luminosa e creatrice per eccellenza... ». Il motivo ricorrente della problematica pitagorica è la convinzione che l'uomo possa migliorare indefinitamente. Per questo i pitagorici avevano elaborato «il regime di vita pitagorica»: si alzavano molto presto al mattino e, soli, se ne andavano passeggiando in luoghi tranquilli, rallegrati da boschi e da templi: volevano sentirsi ben disposti d'animo prima di venir in contatto con gli altri; più tardi, mediante la ginnastica, si prendevano cura del loro corpo; poi la colazione con pane, miele e decotto di mele; durante il giorno non bevevano mai vino. Dopo la colazione ognuno si dedicava ai propri uffici. A sera riprendevano le passeggiate, non più soli ma in compagnia, richiamando alla mente gli insegnamenti e i precetti della dottrina. Poi mangiavano la carne di quegli animali che era lecito sacrificare, e bevevano del vino. Al termine del pasto il più giovane leggeva dei libri, mentre il più anziano sovraintendeva alla lettura dicendo che cosa e come dovevano leggere. In ultimo il « maestro » impartiva i suoi insegnamenti e ciascuno se ne tornava a casa. La mattina dopo il pitagorico non si alzava dal letto senza prima aver ricordato le cose avvenute il giorno innanzi: si sforzava di richiamare alla memoria le prime parole dette e ascoltate e i primi ordini dati ai familiari; poi, man mano, tutte le altre cose dette, ascoltate o fatte. Ciò perché la memoria e il suo esercizio erano ritenuti utilissimi per la conoscenza, esperienza e intelligenza. Ora, in chiave psicologica, non è difficile vedere in tale pratica un vero e proprio « esame di coscienza », una volontà di mantenersi vigili ai fatti della vita quotidiana: si trattava non tanto di esercitare la memoria, quanto di acquistare una maggiore consapevolezza. Non ci è dato sapere fino a che punto l'inconscio fosse congetturato dai pitagorici. E' comunque indubbio che la psicologia del profondo ha dei lontani precedenti in alcune religioni misteriche, nelle quali si prestava una certa attenzione alla voce dell'inconscio. Pitagora, stando alla tradizione, era esperto nell'interpretare i sogni, ma non sappiamo in che misura egli adoperasse questa perizia nella sua comunità. Siamo però informati che la fisionomica nasce con Pitagora. Egli osservava per un lungo periodo gli aspiranti discepoli, li guardava nei momenti di maggiore rilassatezza, durante il gioco per esempio, o i pasti, particolare attenzione dedicava al riso, perché aveva intuito che in quei momenti il volto non poteva mentire; Pitagora sapeva dunque che l'espressione emotiva, non soggetta alla forza cosciente, era il mezzo più efficace per la conoscenza dell'uomo. E' chiaro che non intendo esporre qui tutti gli aspetti del pensiero pitagorico; ne trascurerò ad esempio i contributi propriamente scientifici; desidero solo esaminarne quelle intuizioni che trovano un'eco suggestiva nella psicologia junghiana. A questo proposito non bisogna dimenticare che, se due pensatori giungono a conclusioni analoghe riguardo all'essere umano, da ciò non si deve necessariamente dedurre che uno abbia conosciuto il pensiero dell'altro; si può soltanto affermare che, se si studia l'uomo in modo genuino e profondo, si incontrano sempre analoghi problemi. Gli storici, come già detto, si sono sempre trovati d'accordo nel sostenere che tutto l'insegnamento pitagorico, anche quello più propriamente scientifico, tendeva alla trasformazione dell'uomo. Il termine trasformazione ha una diffusa risonanza nel mondo della psicologia analitica; come pure in quello dell'alchimia; quando Jung cominciò a studiare la mitologia e le religioni, si imbattè in simboli alchimistici che subito gli richiamarono alla mente alcune analogie con un misterioso processo trasformativo individuato in vari suoi pazienti; tale processo si svolgeva « attraverso » simboli alchimistici nel senso che, in certo modo, questi ne rappresentavano le tappe e i punti di riferimento; ed erano inoltre dotati di una forza impulsiva in vista di futuri sviluppi. Ma come avviene, secondo Jung, il processo psichico di trasformazione? Mediante l'assorbimento di contenuti inconsci da parte del conscio, così da sviluppare ed accelerare la tendenza verso una personalità più comprensiva e più vicina alla « totale » individualità dell'uomo. Tale personalità più profonda, che com'è ovvio trascende l'« lo », è da Jung definita il « Sé », inteso appunto come globalità di coscienza e inconscio. La « trasformazione » che porta a tale risultato viene definita « processo di individuazione ». A me sembra che anche l'uomo pitagorico fosse coinvolto in un processo simile. Ma qual era il fattore che provocava la metamorfosi e l'ampliamento della personalità? Il regime di vita pitagorico doveva certo avere il suo peso, ma solo come sistema per creare un favorevole « temenos » di condizioni oggettive, dato che sostanziali mutamenti psicologici non possono derivare soltanto da una tecnica; io credo che la trasformazione dell'uomo pitagorico avesse il suo punto focale in una progressiva e particolare assimilazione di un concetto caratteristico di quella dottrina: la metempsicosi. Secondo tale concetto, « le anime passano di generazione in generazione, dall'uno all'altro corpo di uomini, di bestie, di piante, scontando di tanto in tanto nelle regioni dell'Ade i loro peccati, ma sempre rinascendo in esseri migliori o peggiori a seconda dei meriti acquisiti... ». Finché l'anima per grazia divina, sarà sottratta al giro di esistenze mediante pratiche e riti iniziatici che le religioni misteriche insegnavano ai loro adepti. Quale significato ha questa dottrina da un punto di vista endopsichico? Il passaggio dell'anima attraverso varie vite — di uomini, bestie, vegetali — configura un'idea importante, quella cioè della parentela psicologica di tutte le forme viventi; non solo, ma per il pitagorico qualsiasi forma vivente, anche la meno nobile, può essere utile ad affinare e comprendere — nell'ambito del susseguirsi delle vite — la dialettica del proprio comportamento psicologico. Ebbene, a me sembra che questo processo sia suggestivamente analogo al processo di assimilazione dell'ombra: assimilare l'ombra, vale a dire i nostri aspetti negativi e rimossi, prenderne coscienza, venire a patti con loro e riconoscerli come aspetti importanti della nostra personalità, rappresenta una vera e propria rinascita spirituale; significa veramente abbandonare uno stato psichico per un altro più profondo addirittura una vita per un'altra, un destino per un altro. Pitagora teneva moltissimo al concetto di continua rinascita dell'anima. Egli cercava sempre di rammentarlo ai suoi allievi e impiegava tecniche particolari per raggiungere il loro intimo e calare in esso quell'idea; in special modo si serviva della musica (l'espressione artistica più vicina all'inconscio). Con la musica, inoltre, egli preparava l'animo dei compagni ai sogni profetici della notte. La Wickes parlando della rinascita psicologica come risultato della volontà di vivere, dice: « Secondo questa concezione, l'uomo non rinasce solo due volte, ma di continuo. Se la vita richiede da noi nuovi compiti e un nuovo orientamento interno, ciò che di vecchio in noi esiste deve perire perché il nuovo possa nascere. Ci sono delle crisi spirituali durante le quali la rinascita porta seco una trasformazione dell'intera personalità. Tutte le cose che erano accumulate vengono allora liberate da una nuova concezione spirituale... Il nuovo atteggiamento porta ad un processo di individuazione superiore, ad una visione più profonda delle cose ed a maggior senso di responsabilità: processo che si ripete sempre di nuovo. Ben presto, il nuovo lo trova ostacoli che deve superare, e da ciò consegue un'altra rinascita. L'energia psichica lotta per conquistare una nuova forma, e ogni qualvolta si giunge ad un simile rinnovamento ha luogo per l'individuo un grande processo interiore... ». L'interpretazione della metempsicosi come assimilazione dell'ombra non deve essere considerata un tentativo di psicologismo. Per usare le stesse parole di Jung, tutti gli atteggiamenti e i fenomeni spirituali implicano certe strutture e contenuti psichici dei quali lo psicologo ha il diritto e il dovere di occuparsi. Il passaggio dell'anima da una vita all'altra rappresenta una vera e propria spirale di approfondimento che forse l'uomo pitagorico magari, senza rendersene conto, riusciva ad assimilare da un punto di vista endopsichico. Tale assimilazione provocava in lui quel lento evolversi della sua anima verso il punto di partenza a lei consono, punto che la psicologia analitica chiama « Sé ». In definitiva, per riassumere e concludere, avanzo quest'ipotesi: il pitagorico era sicuro di credere nella trasmigrazione delle anime da una vita all'altra; ma in realtà recepiva in maniera endopsichica tale credenza, e quindi finiva col riferirla, sia pur inconsciamente, al passaggio della propria anima da uno stato a quello successivo più ampio e profondo. E torniamo a considerare un'altra caratteristica del metodo pitagorico: quale significato poteva avere il ricordare ogni mattina tutti gli avvenimenti del giorno innanzi, le persone e gli animali incontrati, le parole dette? Già ho affermato che per me si trattava non tanto di un modo per esercitare la memoria, quanto di un tentativo per allargare la coscienza. Tentativo condotto, al fondo, mediante l'esame dei comportamenti altrui e il confronto con i propri: ciò che portava a intuire — inconsciamente — un'anima almeno in parte comune a tutti gli esseri viventi incontrati il giorno prima, comune anche all'osservatore: e in lui ancora operante. Certo non abbiamo alcuna garanzia che i pitagorici avessero coscienza dei meccanismi psichici così ipotizzati. Ma credo che il processo di trasformazione non avrebbe potuto svilupparsi in loro senza i supposti contenuti e atteggiamenti dell'inconscio. Ricca di significato è poi la rivalutazione della donna, che trova oggi il suo parallelo nella scoperta dell'androginia dell'anima. Quando i pitagorici parlavano di partecipazione della donna, intendevano soprattutto riferirsi al campo spirituale, ai momenti finali e delicati dell'iniziazione, momenti in cui la donna non solo partecipava al mistero, ma contribuiva a che il rito fosse più fecondo per gli stessi uomini. Quando a Jung facevano notare come la maggioranza dei suoi discepoli fosse composta da donne, egli rispondeva che la psicologia è la scienza dell'anima e che non era colpa sua se l'anima è donna. D'altronde gli studi di Jung sul sentimento e sulla intuizione come strumenti conoscitivi, ci chiariscono i motivi per cui l'anima femminile è cosi attratta da certe discipline: essa, come afferma Baudouin, sembra possedere dei doni particolari che le rendono congeniale la psicologia analitica. Un'altra brillante anticipazione della scuola pitagorica sta nella scoperta della mistica numerica e geometrica, la cui validità ha trovato una conferma empirica nell'analisi dei simboli mandalici presenti nel linguaggio inconscio: certi sogni che preludono alla armonia delle funzioni ed al superamento delle proiezioni in vista di un graduale costituirsi del Sé, sono ricchi di simboli geometrici — triangoli, quadrati, cerchi, il cui significato unificatore ed armonizzante Jung non ha mai smesso di evidenziare. E' stato detto testualmente: « La rivoluzione del concetto pitagorico riguardo all'anima, intuita come quadrata, e il riconoscimento di un valore scientifico moderno alla mistica tetrade, quale espressione di un archetipo sotto la specie di mandala, non sfuggirono a Jung medesimo, che dallo studio medico sui nevrotici aveva saputo estendere la ricerca psicologica al corpus delle dottrine iniziatiche d'Oriente come di Occidente... Ma la luce che dalla moderna psicologia degli archetipi torna alla filosofia esoterica e alla mistica numerologica dell'Antico, non si limita al significato psicologico della tetrade, quale proiezione d'un contenuto psichico inconscio che è allusivo della struttura stessa dell'anima; bensì l'intera aritmologia di Pitagora con la simbolistica correlativa viene ad acquistare dal punto di vista della psicologia scientifica il significato di proiezione dell'inconscio, in rapporto a quei processi di svolgimento e perfezionamento della personalità spirituale già suscitati dalla mistica iniziazione... ». Dallo sguardo che abbiamo lanciato sul pensiero pitagorico rapportandolo alla psicologia analitica, mi sembra sia emerso un elemento fondamentale: il concetto di trasformazione psicologica, meta principale di entrambe le dottrine. Tale concetto acquisterà un rilievo più plastico e suggestivo dalla concreta indagine sugli stucchi della basilica pitagorica.
GLI STUCCHI DELLA BASILICA
L'Arimaspe.
Limiterò il mio esame agli stucchi dell'abside e della volta centrale, gli elementi architettonici su cui più facilmente converge l'attenzione del visitatore. La prima domanda da porsi è questa: da quale punto cominciare? Gli stucchi della volta centrale sono disposti lungo un grande rettangolo nel cui interno è la scena che io ritengo rappresenti il compendio, la conclusione di tutte le altre; questa scena, come vedremo in seguito, farà eco all'altra raffigurata nella abside. Mi è parso giusto procedere con l'esame dalla periferia verso il centro del rettangolo in modo da convergere verso il motivo dominante: ho voluto cioè adottare lo stesso metodo impiegato da Jung per l'interpretazione onirica, metodo basato sul presupposto che i sogni non derivano in linea retta lo uno dall'altro, ma si situano concentricamente intorno al tema principale. Ai quattro estremi del rettangolo troviamo ripetuto lo stesso motivo mitologico: la lotta dell'arimaspe con il drago. Gli arimaspi erano un popolo misterioso del l'Asia minore, sempre in lotta per la conquista di un tesoro custodito dal mostro, o per impedire a quest'ultimo di riprendersi il tesoro già conquistato. Il significato endopsichico d'una lotta così incessante mi sembra piuttosto chiaro; ci troviamo innanzitutto di fronte ai modelli della ricerca di un tesoro e della lotta col drago; ricerca e lotta che hanno il loro equivalente nell'indagine alchimistica, la quale com'è ampiamente dimostrato, non mirava certo ad un tesoro di tipo materiale, ma spirituale, quello stesso tesoro, potremmo dire, che Jung denomina « Sé ». Nella lotta dell'arimaspe sono adombrati, a mio giudizio, il concetto pitagorico della continua perfettibilità umana e la tendenza della psiche verso l'individuazione. E questo sforzo è reso ancor più drammatico dal fatto che il tesoro può essere sempre di nuovo perduto: la lotta non ha mai fine, è un modello che si ripete senza speranza. Qualé allora, nell'ambito del mitico motivo della lotta per un tesoro, l'elemento su cui con maggiore intensità si ferma l'attenzione dei pitagorici? Proprio questa impossibilità di mantenere senza fatica le posizioni acquisite, che restano sempre, potenzialmente, alla mercé dell'avversario. E qui bisogna ricordare quanto dice Jung « II significato ed il disegno di un problema sembra essere non nella sua soluzione, ma nel nostro cimentarsi con esso incessantemente ». Il tesoro che l'uomo cerca è il « Sé », ma ogni vittoria in questa direzione comporta una nuova prospettiva che, nel momento stesso in cui viene alla luce, è già insufficiente perché subito adombra un nuovo balzo in avanti. La lotta dell'arimaspe sottolinea appunto, io credo, l'impossibilità di raggiungere in modo stabile la meta finale; e mostra come tutto lo sforzo consista in un processo dinamico il cui termine può trovarsi soltanto in un cambiamento di stato totale, cioè nella morte. Chi potrà mai dire durante la propria esistenza « Ecco! ho finito, sono tranquillo, ho raggiunto quella pace spirituale cui tanto anelavo? ». Nessuna situazione psichica potrà mai considerarsi chiusa in una totalità statica, e ciò che oggi può apparirci come il tesoro conquistato, domani purtroppo non avrà più lo stesso valore. Ed è per questo che il vero senso della vita umana non sta nella ricerca di una felicità astratta, ma nella continua realizzazione del proprio autentico « essere individuale » che man mano si evolve, nella ricerca di una fedeltà sempre adeguantesi a quest'essere individuale che, finché vive, non giunge mai ad una fine: l'individuazione è un processo non una meta. Vorrei ora notare che, la lotta con il drago per la conquista di un tesoro che può essere sempre perduto e ricuperato, allude anche al mito dell'eterno ritorno e al problema dell'ansia. L'ansia è uno stato primordiale comune a tutti gli esseri viventi: sarà di volta in volta paura di perdere la vita, la salute, i mezzi di sussistenza, la persona amata, una condizione particolarmente felice, il tempo, la stima sociale, il senso di sé stessi. Ma l'ansia ha pure una radice più profonda: all'uomo, come compito, è stato dato lo sviluppo della propria vita: l'ansia può essere allora timore di non realizzare questo sviluppo, e, contemporaneamente, spinta verso tale realizzazione. In genere l'ansia è una caratteristica che appare negli individui nevrotici. I nevrotici sono quasi sempre degli inibiti, che pur sentendo determinati impulsi ad agire in una certa direzione, ne sono impediti dalle loro resistenze interiori. Essi hanno, per dirla in breve, un arresto nel loro sviluppo. Ora « la sola ed unica cosa che davvero conta è lo sviluppo delle proprie potenzialità; ciò significa che perfino l'istinto di conservazione è subordinato ad una più alta legge di natura che da ogni essere vivente chiede il maggiore possibile sviluppo delle sue facoltà interiori. La vittoria sull'ansia è dunque la premessa fondamentale per la conquista del tesoro, per quell'adattamento alla nostra realtà interna che costituirà la base di ogni ulteriore sviluppo.
Calcante ed Ifigenia.
Dedicherò adesso la mia attenzione allo stucco che mostra Calcante nell'atto di recidere le chiome ad Ifigenia, operazione che prelude al sacrificio. Calcante, secondo la tradizione è il più grande indovino dell'antichità greca. Ma cosa rappresenta in tutte le mitologie la figura del « mago »? Un'incarnazione di Dio nell'uomo: incarnazione che non infonde tanto una maggior forza, quanto una conoscenza più ampia, non limitata dallo spazio e dal tempo. Il mago possiede quel tipo di personalità da Jung denominata « mana », termine che riecheggia il modello dello uomo che « sa » e che « può ». Tale immagine è una dominante dello « inconscio collettivo ». E la divinazione non è altro che la capacità di percepire l'inconscio, sia personale che collettivo, capacità preclusa all'uomo normale. Percepire l'inconscio significa dunque conoscere la sorte — e la « realtà globale » — propria e altrui. Potremmo allora dire che l'inconscio, in un certo senso, rappresenta il destino dell'uomo, e chi, o per capacità diretta o affidandosi al « mago », prende coscienza del proprio destino (quindi del proprio inconscio) e lo accetta, trova in tale accettazione un riscatto al destino stesso, quale che questo possa essere. La dolce Ifigenia, come sappiamo dalla tradizione, non si oppone alla sua sorte. Lo stucco della basilica la raffigura mentre si offre in olocausto senza apparente timore, la testa inclinata, modesta e bella, Ifigenia incarna la figura di colei che espia. Deve pagare per la colpa del padre, uccisore di un cervo sacro ad Artemide, e attende il sacrificio con dolore, ma con rassegnata serenità. Salvata poi dalla stessa Artemide, sarà costretta per lungo tempo a compiere sacrifici umani in Tauride; finché riesce a commuovere il severo Re Taonte che abolisce i sanguinosi riti; Ifigenia salva così il fratello Oreste e dona al popolo di Tauride la possibilità di una epoca civile e umana. La caratteristica essenziale di Ifigenia è quella di vivere la storia accettandola senza chiedersene o contestarne le ragioni, « e appunto in questa ingenuità dolorosamente colpita, in questa purezza che soggiace al male senza esserne offesa, nella naturale devozione con cui ella accetta gli ordini degli Dei e ammette implicitamente in essi giustizia superiore che pur non riesce a comprendere, sta la forza della sua figura ». Nell'abbandono di Ifigenia al suo destino è anche la sua salvezza. Artemide la risparmia, evento tanto più interessante quando si sottolinei il carattere violento e vendicativo di questa dea, responsabile di varie morti atroci: quella di Atteone ad esempio divorato dai propri cani, o quella del cacciatore Broteas, reso pazzo e spinto a lanciarsi nel fuoco. La salvezza di Ifigenia è l'unico atto di indulgenza che venga attribuito dai mitologi alla dea. Qual è allora il messaggio di questo stucco? Esso va individuato appunto nell'invito ad abbandonarsi alla voce dell'inconscio, a non contrastare le direttive che provengono dalle dimensioni arcaiche della vita. L'uomo deve fare il possibile per controllare gli eventi esterni, ma deve anche sapere che non può opporsi a certi disegni che lo trascendono: dalla loro accettazione potrà anzi scaturire uno sviluppo salutare. L'accettazione, in effetti, è un venire a patti con l'inconscio e con i suoi modi di procedere; è un riconoscere i complessi da cui siamo condizionati; e ciò porta ovviamente al risultato di sminuire il loro potere autonomo nei confronti della nostra coscienza.
Èrcole e Minerva.
Passiamo ora allo stucco che rappresenta l'incontro di Èrcole e Minerva, accostamento rarissimo nelle raffigurazioni mitologiche, dato che lo si è reperito in tutto quattro volte. Èrcole si avvicina solenne alla dea. Pende dalle sue spalle la pelle leonina e in mano ha la clava. Nella mitologia greca egli è per eccellenza l'« eroe ». A noi interessa analizzare non tanto le sue vittorie, quanto le condizioni in cui esse maturano. Èrcole, se vuole conquistare l'immortalità, dovrà subire un processo di trasformazione attraverso le dodici « fatiche », fatiche che dovrà compiere per volontà di Euristeo; e proprio qui sta la chiave per comprendere il profondo dramma psicologico dell'eroe. Euristeo è il tipo mediocre per eccellenza; non ha nulla di eroico, di forte, di intelligente, nulla che possa giustificare la sua posizione sociale. E' la banalità fatta persona, attenta soltanto a! proprio benessere individuale. Negli altri non vede che gli strumenti per la realizzazione dei suoi interessi. E' l'uomo delle convenzioni, l'uomo che difende le strutture sociali a lui favorevoli e che, a ragione del suo mediocre essere, del suo scarso talento e de! suo minimo valore, possiede i beni del mondo ed il potere. Ed Èrcole deve piegarsi di fronte al meschino Euristeo, del quale sente l'indubbia inferiorità. Quando apprende che dovrà compiere le dodici imprese, l'eroe cade nello sconforto: non perché tema la lotta, ma perché è costretto ad una profonda umiliazione. D'altra parte sembra un tratto particolare del destino che gli uomini grandi siano sempre soggetti a forze negative e prepotenti: mentre essi guardano allo spirito, altri lavorano alla loro distruzione. Si pensi al nazismo: la « cultura », nel senso più ampio del termine, fu il primo nemico ad essere attaccato e sgominato. Ma per quella legge che fa seguire alla degenerazione la generazione, le anime sofferenti sparpagliate per tutta la terra acquistarono capacità di sopravvivenza e rinascita in terre straniere. Alla fine della grande follia ci fu come il ritorno di un'onda da mondi lontani, e quest'onda rese familiari quei mondi: il ponte era gettato proprio da quelli che erano stati costretti alla fuga. Dalla follia sembrerebbe essere nata una consapevolezza dell'appartenenza non alle nazioni ma al mondo intero. Come un motivo ricorrente nelle fiabe, il principio distruttore è anche il principio di salvezza, nella misura in cui spinge il perseguitato ad affinare le sue doti positive. Tornando ad Èrcole, potremmo affermare che il suo dramma con Euristeo configura, da un punto di vista endopsichico, la necessità dell'eroe di fare i conti con la propria parte oscura, con la propria ombra. E ciò prima di affrontare il processo di trasformazione attraverso le imprese. Per analogia sono condotto a notare che, all'inizio dell'analisi l'elemento « ombra » assume una grande importanza ai fini dello sviluppo psicologico: capita spesso in questa fase che i pazienti sognino un viaggio ne! fondo del mare (simbolo dell'inconscio), dove sono costretti a fronteggiare realtà obbrobriose. Poniamoci ora una domanda: oltre al confronto con l'ombra, a cos'altro può alludere lo stucco di Èrcole e Minerva? Èrcole, secondo il mito, è uno dei pochissimi mortali che abbia combattuto e sofferto per conquistare l'immortalità. Al grande impulso verso la propria individuazione, che si manifestò per la prima volta nella lotta contro i due serpenti, egli non è mai venuto meno. E colui che affronta la lotta trova anche il protettore. Subito dopo la nascita, Minerva espresse la sua ammirazione per il bambino. Nella battaglia contro l'esercito della città di Orcomeno, Èrcole combattè rivestito della corazza donatagli da Minerva. Durante la pulizia delle stalle di Augia, Minerva appare soccorritrice. Gli interventi della dea stanno dunque a significare che immancabilmente subentrerà un fattore protettivo per coloro che seguono la strada autentica. « L'uomo deve soltanto lottare e aver fiducia, ed i guardiani eterni appariranno ». Non c'è storia di eroi o fiaba che non contenga questo particolare insegnamento, il quale, trasferito sul piano psicologico, vuole ammonire che le forze dell'inconscio daranno aiuto a chi subisce le conseguenze di una lotta tesa alla ricerca della personale autenticità. Dal primitivo e coraggioso abbandono alle forze dell'inconscio (Ifigenia), si passa quindi ad una fase in cui l'inconscio diventa soccorritore, sebbene con modalità che spesso appaiono contrastanti con quelli che sono obbiettivi a breve termine.
Aldo Carotenuto
Pubblicato da
Nicola Ferraro
alle
19:12
0
commenti
![]()
Etichette: Ermetismo, Esoterismo, Filosofia, Massoneria, Pitagora, Pitagorismo, Simboli
Iscriviti a:
Post (Atom)